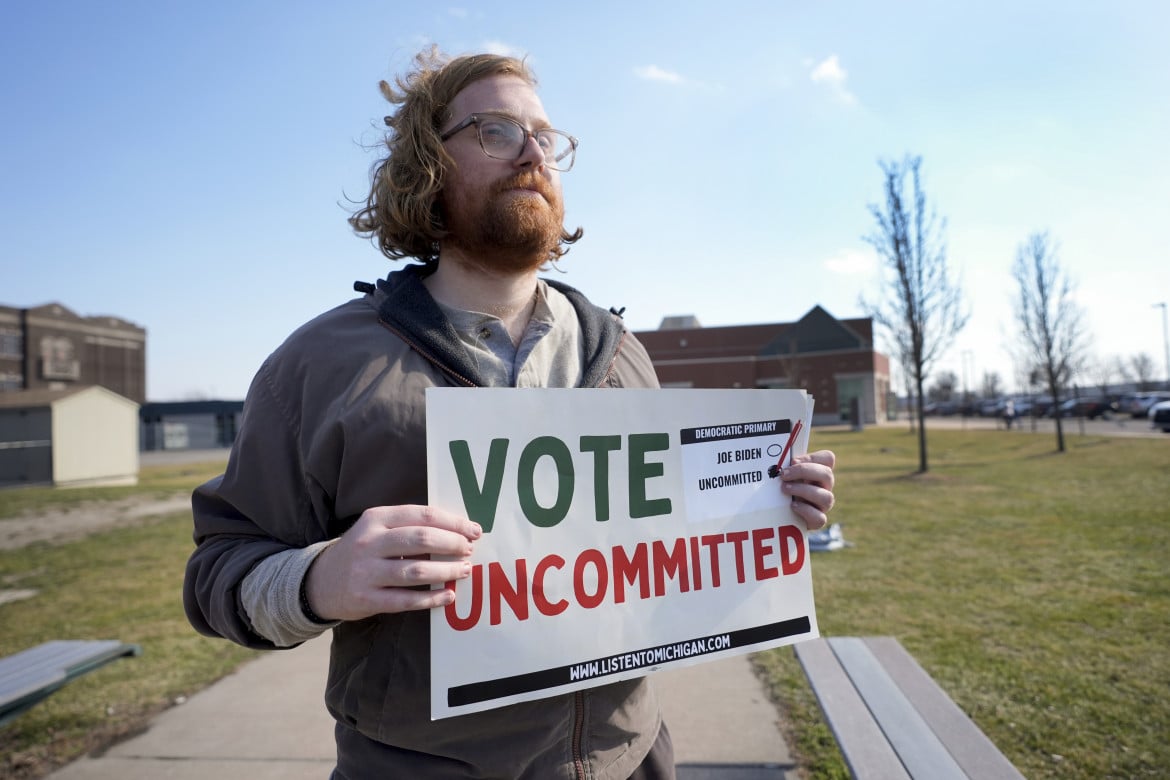Più bianco del latte, il piccolo stato dell’Iowa regalò al nero Barack Hussein Obama la vittoria nel 2008 sulla favorita Hillary Clinton. In campo repubblicano, vinse Mike Huckabee, pastore cristiano, ultraconservatore.
Huckabee è di nuovo in corsa, uno degli undici repubblicani in lizza nei caucus che si svolgono lunedì, prima tappa della competizione per la successione a Obama. Sull’altro fronte c’è anche questa volta Hillary. Favorita. Come nel 2008. Questa volta con cautela.
E già, otto anni fa la Clinton era così bene sostenuta dall’establishment, ricca di fondi, una squadra di insuperabili strateghi, tanto da essere soprannominata Hillary-the-inevitable, eppure perse con un candidato dal «nome buffo». E questa volta? Possibile che un vecchio signore del Vermont che s’ostina a definirsi socialista possa batterla, proprio come fece il giovane post-ideologico Obama?
Possibile, dicono i sondaggi. Possibile che Hillary arrivi a giocarsi di nuovo la nomination democratica? Anche allora ci si consolò, nel campo clintoniano, dicendo che l’Iowa è uno staterello di contadini e vaccari che porta pochi delegati alla convention. Poi venne il mediocre risultato del New Hampshire, dopo ancora Obama si mise al galoppo verso la Casa Bianca.
No, questo film, sono solo i più inossidabili fan di Sanders a immaginarlo. Ma neppure è detto che abbiano torto.
Il 2008 è una svolta storica non solo perché è l’anno della prima elezione a presidente di un africano americano. Il 2008 segna anche uno spartiacque tra un prima, in cui erano gli establishment dei partiti, e le loro connessioni con le lobby economiche di riferimento e i gruppi d’interesse organizzati, a determinare la corsa, e un dopo, nel quale questi vecchi blocchi di potere contano molto meno, cedendo spazio ad aggregati più fluidi. Da un lato, i processi sono diventati più aperti (con la diffusione delle iniziative dal basso agevolate da internet), dall’altro, al tempo stesso, più chiusi con il protagonismo sempre più sfacciato del denaro. Addirittura oggi “impersonato” direttamente dai candidati in campo. Non solo Donald Trump, ma anche Michael Bloomberg.
Cambiamenti strutturali in corso
Le vecchie corse dei cavalli, come un tempo erano definite le primarie americane, seguivano dunque un percorso abbastanza prevedibile. Oggi non è più così. È la ragione per cui Hillary non può pensare di avere la vittoria in tasca.
Anche perché tra i cambiamenti in corso vanno contemplati quelli strutturali. Sono le trasformazioni di un’America nella quale le disparità sociali crescono e più evidente è la debolezza del sogno americano, secondo il quale le diseguaglianze sono corrette dal mito di salire la scala sociale fino alla cima, se solo ci s’impegna e ci s’ingegna a farlo. Quel mito si è sfarinato, e nessuno prova davvero a ridargli consistenza, se non quel trombone di Trump, che lo fa, però, non proponendo sogni, ma solo e costantemente alimentando l’incubo del nemico esterno, l’odio, il rancore, la rivalsa dei bianchi, del ceto medio bianco, nei confronti degli immigrati e dei “nuovi” americani.
Il successo di Bernie Sanders preoccupa Hillary Clinton e i suoi strateghi perché sanno che non è effimero. Non è la poesia dell’idealista contro la prosa della pragmatica esperta. Il socialismo non è più una parolaccia nel campo democratico, nel quale, secondo prima Bill e poi Hillary Clinton, perfino la parola “liberal” andava accuratamente bandita perché attribuiva al Partito democratico un connotato di sinistra, quando le elezioni, dicevano, si vincono al centro e rubando spazi moderati ai repubblicani. La sinistra tanto ti voterà comunque, anche se ostenti disprezzo nei suoi confronti.
Ma, poi, che cosa professa Sanders di così estremista, di così socialista, di così idealista, da non essere considerato ragionevole oggi da una parte consistente dell’elettorato americano, non solo democratico, non solo giovane? Professa ammirazione per il welfare state nordeuropeo. Denuncia con sdegno le diseguaglianze economiche e sociali. Vuole un sistema sanitario pubblico e universale, la gratuità dell’istruzione universitaria, investimenti nelle infrastrutture che creino posti di lavoro, misure contro il cambiamento climatico, una riforma del finanziamento della politica. Sostiene i diritti dei gay. In sintonia con i sindacati, è contrario ai trattati di libero commercio. Radical? Agli occhi, forse, di chi trova normale che nella seconda città industriale del Michigan, Flint, l’acquedotto disperda piombo, avvelenando la popolazione, al settantacinque per cento africana- americana.
Radicalismo vs. demagogia razzista
Non c’entra proprio niente il radicalismo di Sanders, 73 anni, uomo politico stagionato e rispettato membro del senato, con la demagogia razzista di Donald Trump, non è il populismo di sinistra contro il populismo di destra dentro un’America inquieta e spaesata.
Ciò che li accomuna è che entrambi si muovono in una fase storica, quella attuale, in movimento, nella quale, le consolidate griglie della politica novecentesca non reggono più. Così da un lato Jeb Bush, il cocco dell’establishment repubblicano è in coda nel drappello dei contendenti repubblicani, che vede in testa Trump, dall’altro la potente Clinton deve vedersela con Sanders, e se vuole farcela deve far suoi molti dei punti programmatici del rivale, e deve farlo non per finta, perché, a novembre, potrebbe non vincere, senza una grande mobilitazione degli attivisti “idealisti”, ma non fessi.
Scenari non troppo fantasiosi
Il voto degli Iowans è importante. E lo è più sul versante repubblicano. Se nei dem la corsa è già diventata un duello, nel Grand Old Party la competizione è – in questa primissima fase – un referendum su Trump. Se vincerà bene, il miliardario potrebbe avere la strada spianata. In caso contrario, la corsa repubblicana si potrebbe avvitare e avvelenarsi. Anche con l’esito di un’esclusione di Trump. Il quale, però, rientrerebbe in competizione, nelle elezioni di novembre, come indipendente. A quel punto potrebbe prendere più corpo anche la candidatura di un altro indipendente, Michael Bloomberg, il miliardario ex-sindaco di New York.
Non uno scenario fantasioso, ma il paesaggio reale di un’America politica cambiata dall’avvento di Barack Obama e dagli epocali processi demografici, sociali e culturali che hanno reso la sua elezione e la sua presidenza un cruciale passaggio trasformativo e non solo un’effimera parentesi.