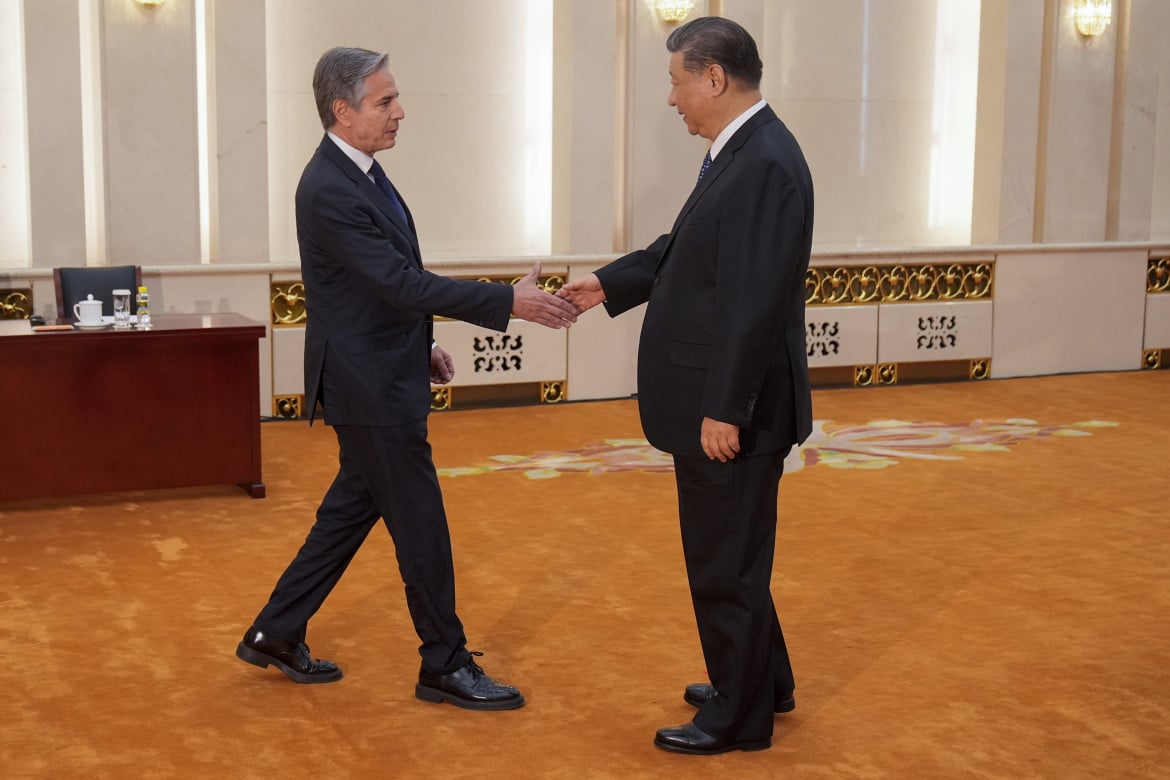Driss Guerraoui è appena uscito dal suo ristorante a Desert Hot Springs quando viene investito da un’auto che percorre a grande velocità la superstrada che taglia in due il deserto californiano del Mojave. Il veicolo prende in pieno il sessantenne immigrato, arrivato nel Paese da decenni da Casablanca, e prosegue la sua folle corsa nella notte. È intorno a questa tragedia che alternando via via i toni del noir, del memoir, dell’indagine introspettiva come dell’analisi sociale, Laila Lalami ha costruito Gli altri americani (Ponte alle Grazie, pp. 438, euro 19, 80, traduzione di Andrea Branchi) un romanzo che indaga le contraddizioni dell’identità americana attraverso i sentimenti e le fragilità di personaggi sospesi tra appartenenze, culture e affetti spesso contrastanti.
Nata a Rabat, in Marocco, docente di scrittura creativa all’Università della California a Riverside e firma di importanti testate, tra cui The Nation e New York Times, Lalami ha già al suo attivo quattro romanzi ed è stata finalista al Pulitzer. Se per Gli altri americani ha scelto nove voci narranti, tra le quali quelle dei famigliari della vittima e dell’immigrato messicano che ha assistito all’investimento, nei suoi scritti precedenti ha sempre concentrato lo sguardo, come spiega lei stessa, su figure che «sono costrette a spostarsi e devono ricominciare da capo in un posto nuovo, e su come quel luogo modellerà le persone che diventeranno».

Quel parlare di «altri americani» nel titolo suona un po’ come una sfida visto che il romanzo offre uno spaccato della realtà degli Stati uniti nel quale ferite, paure o speranze dei protagonisti definiscono uno spazio comune, quale che sia il colore della loro pelle o il loro passaporto.
È proprio così. La storia è raccontata attraverso gli sguardi di nove diversi personaggi legati tra loro dalla tragica morte di un immigrato marocchino. Ma ciascuno di loro prova poi a sua volta un senso di estraneità sia rispetto alla propria famiglia o comunità che alla stessa società in cui vive. Hanno la sensazione di non appartenere del tutto a quello «spazio», di essere in qualche modo «diversi». E questo senso di alienazione credo sia molto diffuso in America. Da un lato siamo una democrazia multiculturale che vuole essere all’altezza degli ideali di uguaglianza e giustizia su cui è nata, ma dall’altro siamo anche un Paese con una brutta storia di discriminazione ed esclusione che persiste ancora oggi.
Dopo aver scritto degli immigrati che traversano il Mediterraneo, degli schiavi del 700 o dei conflitti sociali a Casablanca, in questo romanzo raccontate la normalità di una famiglia marocchina in California e l’emergenza in cui vivono i nuovi migranti ispanici. Sembrate voler raccontare soprattutto le vite sottomesse alle scelte di altri.
Sono soprattutto interessata al modo in cui le vicende personali e lo spazio pubblico, «il politico», si fondono nelle vite dei miei personaggi. A molti di noi piace credere di essere padroni del proprio destino, ma ovviamente dal momento in cui nasciamo ci troviamo continuamente di fronte a una serie di scelte che almeno in parte sono determinate dal luogo in cui nasciamo, sotto quale sistema politico e in quale classe sociale. Ed è partire da queste scelte che ci andiamo definendo anche in termini di appartenenza ad una determinata comunità o in quelli di un’identità individuale o collettiva.
Nelle loro scelte, i personaggi sembrano affidarsi spesso alla memoria: quella cui attingono Driss e Maryam (sua moglie) per capire il senso della loro fuga dal Marocco all’America, quella cui si aggrappa Nora per scoprire chi fosse davvero il padre che ha perso. Il passato determina il loro presente?
Uno dei temi che volevo esplorare è il modo in cui negoziamo e rinegoziamo il nostro rapporto con il passato. Formiamo il senso della nostra identità basandoci sulla storia che ascoltiamo quando siamo piccoli o stiamo crescendo, ma la storia non è mai fissa, ferma né nella sua forma pubblica né in quella privata. Si tratta invece di qualcosa che viene costantemente reinterpretato e la cui trasformazione ci serve anche per andare avanti. Così, ad esempio, nel romanzo Nora è costretta a riesaminare il modo che aveva di guardare a suo padre in base alle informazioni che apprende su di lui durante le indagini che fanno seguito alla sua morte.
Nove personaggi costituiscono l’«io» narrante del romanzo. Quanto è stato difficile offrire a ciascuno il giusto timbro narrativo senza far venire meno le caratteristiche peculiari che rendono ogni voce credibile?
Questa polifonia mi ha offerto la possibilità di vedere gli stessi fatti sotto una prospettiva diversa. Ne Gli altri americani ogni personaggio interpreta ciò che è accaduto in modo diverso e, nel processo interiore che sviluppa, rivela qualcosa della propria vita, delle proprie inquietudini, dell’impatto che il crimine con cui devono misurarsi potrà avere sulle loro esistenze. Così, la figlia della vittima, Nora, è sconvolta dal dolore ma è convinta che quello che appare a prima vista come il gesto terribile di un pirata della strada nasconda un vero e proprio omicidio. Questo, mentre la responsabile delle indagini, la detective Coleman, tratta questo caso come uno tra i tanti di cui deve occuparsi ed è più preoccupata per ciò che sta accadendo al figlio, in piena pubertà. All’inizio ho scritto una bozza completa con tutti e nove i personaggi che raccontavano a turno la storia, ma dopo ogni revisione mi sono concentrata su un solo narratore per volta in modo da poter catturare la sua voce fino in fondo prima di passare al personaggio successivo.
Un altro tema che ritorna nella storia è quello del «ritorno a casa». Riguarda in particolare Nora e Jeremy: la prima rientrata in famiglia dopo la morte del padre; il secondo tornato dall’Iraq dove ha combattuto tra i marines. Per entrambi però questa «casa» (home) è tutt’altro che un luogo accogliente.
Ancora una volta, ad accomunare i personaggi è la sensazione di essere fuori luogo, di non appartenere del tutto a quella famiglia o a quella comunità. È una constatazione piuttosto dolorosa, ma che nel corso della vicenda consente a Nora e Jeremy di riflettere sul fatto che dietro all’idea di «casa» si possono scorgere molti elementi e che tutto ciò può assumere molte forme diverse: «casa» può essere un luogo, una persona, una famiglia, persino un sentimento. E così, alla fine loro due troveranno una casa l’uno nell’altro.

Penso che il romanzo abbia molto a che fare con il lasciare e tornare alla propria casa anche perché io stessa sono un’immigrata. Sono arrivata negli Stati Uniti come studente 25 anni fa e quando sono sbarcata la prima volta all’aeroporto di Los Angeles non avevo certo idea che avrei vissuto qui fino oggi. E la decisione di restare ha ulteriormente complicato il mio modo di guardare a questi temi. Quanto a ciò che considero casa, nel corso della mia vita mi sono spostata così tante volte che non posso dire di aver sviluppato un attaccamento particolare a un luogo specifico. Mentre invece, in termini emotivi per me casa è ovunque si trovi la mia famiglia ed è lì che, letteralmente, «mi sento a casa».
Dopo l’11 settembre gli arabo-americani sono stati a lungo oggetto di discriminazioni: oggi com’è la situazione? E che ruolo, e ascolto, hanno le loro voci – il suo lavoro come quello del poeta di origine libanese Lawrence Joseph o della scrittrice egiziano-palestinese Randa Jarrar, solo per citare alcuni nomi – nell’ambito della società multiculturale che descrive?
L’America non è mai stata una nazione omogenea. Molto prima che ci fosse una colonia a Jamestown, c’erano migliaia di tribù indigene con lingue, religioni, culture e tradizioni molto ricche e distinte. Dopo l’arrivo dei primi coloni, milioni di schiavi con le loro lingue, religioni, culture e tradizioni, furono portati in questo paese. Quindi gli Stati Uniti sono stati un Paese diversificato sin dall’inizio e quella diversità continua ad esistere oggi. Ma in diversi momenti della loro storia, gli Usa hanno anche cercato di escludere persone di culture diverse, ad esempio con il Chinese Exclusion Act del 1882, o il rimpatrio dei messicani negli anni ’30 o l’internamento dei giapponesi negli anni ’40. L’esempio più recente in questa lunga storia è proprio ciò è successo con gli americani arabi e musulmani dopo l’11 settembre che ha incluso l’approvazione di rigide restrizioni all’immigrazione, la sorveglianza della polizia e, infine, il cosiddetto Muslim ban voluto da Trump.
Dopo questo romanzo ha pubblicato una raccolta di interventi e saggi, «Conditional Citizens», che ruotano intorno al modo in cui la razza, il genere, l’origine nazionale, la religione sembrano contribuire a definire ancora oggi la cittadinanza negli Stati Uniti. Cosa rappresenta questa nozione ai suoi occhi?
Nel primo capitolo del libro rifletto sul fatto che spesso pensiamo alla cittadinanza come ad uno status: o ce l’hai o non ce l’hai. Quando sono diventata cittadina americana, il giudice davanti al quale ho prestato il giuramento di rito (il «giuramento di fedeltà agli Stati Uniti», ndr) lo considerava un privilegio che ci veniva concesso. Ma se la pensassimo non tanto come uno status, bensì come una relazione: una relazione che lega un cittadino ad altri cittadini, e il cittadino e lo Stato? Se la pensiamo come una relazione, allora è qualcosa da coltivare, qualcosa in cui capisci che devi dare e devi ricevere, e i tuoi diritti sono legati ai diritti degli altri. Dobbiamo pensare alla cittadinanza come relazione. E deve essere trattata con grande cura. Attraverso la cura che riserviamo agli altri cittadini.