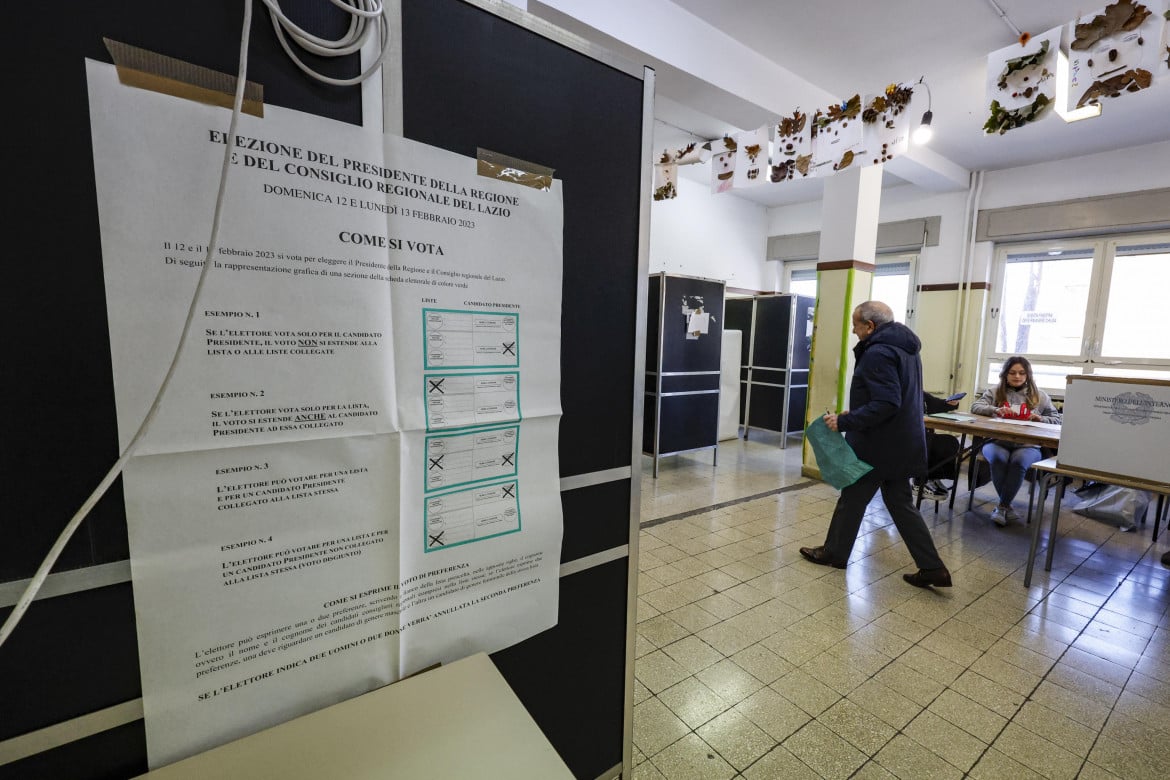Alla loro prima prova elettorale nel 1970, Lombardia e Lazio portarono al voto rispettivamente il 95,5% e il 91,7% degli aventi diritto. Nello spazio di cinque decenni, l’affluenza ai seggi per le Regionali è passata al 41,7% per la Lombardia e al 37,2% per il Lazio. A Roma ha votato circa un elettore su tre (35,17%). Come ormai accade da anni a questa parte, l’astensionismo è correlato alla classe sociale, all’istruzione, al reddito e alla zona di residenza. La “voice” è diventata un esercizio per pochi, mentre i molti preferiscono “l’exit”. Per alcuni questo non è un problema da affrontare, anzi è considerata una tendenza “naturale” dei sistemi liberal-democratici. La post-democrazia è ineluttabile, inutile combatterla. Un realismo cinico che, legittimando l’inazione, avvera la profezia a cui si riferisce e non vede l’enorme portata del disastro che le elezioni regionali appena trascorse ci consegna.
Ancora più grave è la mancata elaborazione pubblica di quanto accaduto, le pseudo-spiegazioni fornite da un ceto politico che è il principale responsabile del non voto. Le prime reazioni all’esito elettorale, infatti, sono sconfortanti. Si parla di tattiche, di alleanze fatte e non fatte, di errori (degli altri) e di meriti (dei vincitori). Una gara tra perdenti, dove ci si accontenta di essere “il primo partito dell’opposizione”, di alleanze estemporanee o di candidature popolari senza un popolo a cui parlare. Nessuno sguardo lungo, nessuna capacità di scavare alla vera base del disastro: la crisi di rappresentanza. Una crisi che ha radici profonde e cause lontane dal tatticismo elettorale.
Perché sempre più astensione? Due ragioni sono – o dovrebbero essere – al centro dell’analisi di chi abbia ancora a cuore l’idea di democrazia rappresentativa e la funzione costituzionale dei partiti politici. Ne scriveva, già nel 2016, Luigi Ferrajoli in un formidabile articolo dove proponeva di “separare i partiti dallo Stato per riportare i partiti nella società (in “Lo Stato. Rivista semestrale di Scienza costituzionale e teoria del diritto”, anno IV, n. 6, gennaio-giugno 2016, pp. 11-33). In questa lettura, la crisi di legittimità dei partiti coincide con la crisi del rapporto di rappresentanza, l’essenza più intima della democrazia rappresentativa. Praticamente un suo sinonimo. Le forme di democrazia diretta sono certo importanti, ma mai sostitutive della democrazia rappresentativa. La possono e devono rafforzare, nutrire, accompagnare e sostenere. Ma nessuna società complessa e stratificata può basarsi solo sulla democrazia diretta.
Se il rapporto di rappresentanza è debole, tutta l’architettura democratica entra in profonda crisi. Così, non stupisce che i partiti siano all’ultimo posto della graduatoria della fiducia istituzionale degli italiani, come segnala l’Istat: poco meno di una persona di 14 anni e più su quattro è completamente sfiduciata mentre almeno una su due assegna scarsi livelli di fiducia. Il paradosso di cui non sentiremo parlare nei prossimi giorni è che i partiti sono sempre (e giustamente) invocati come co-essenziali alla democrazia, “senza partiti non c’è democrazia” come si sente spesso affermare, senza però mettere a tema il nodo della loro la scarsa democrazia interna, l’incapacità di rappresentare gli interessi dei gruppi più deboli, la maggiore trasparenza e il pluralismo dei processi decisionali che dovrebbero caratterizzarli.
I partiti non svolgono più, e da tempo, le funzioni loro assegnate dalla Costituzione. Anzi, ne sono i principali traditori, proprio perché proprio ai partiti e ai rappresentanti eletti era assegnato il compito di attuare la Costituzione. A ciò si aggiunga che i rapporti tra società, economia e Stato si sono completamente ribaltati. Oggi il ceto politico non solo manca di un’adeguata selezione e formazione, non solo i partiti non sono considerati degni di fiducia e sono organizzazioni a bassissima democrazia interna, ma siamo di fronte alle conseguenze di un cambiamento “sistemico”.
Da tempo, non è più la politica a governare l’economia in nome di interessi sociali da proteggere, ma sono sempre più i poteri economico-finanziari che – spesso su scala globale – impongono la loro agenda alla politica. Non stupisce quindi che i partiti abbiano abdicato al loro ruolo costituzionale, trascinando la politica nel Maelström. Per questo, continua Ferrajoli, è urgente una riforma democratica dei partiti sulla base dell’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione. Ciò agevolerebbe sia la separazione e l’autonomia dei partiti dallo Stato, sia l’efficacia dei diritti politici dei cittadini e, quindi, la loro fiducia verso il sistema politico.
Sono però proprio i partiti attuali il maggiore ostacolo a tale riforma, essendo ormai assimilati a comitati d’affari che presidiano i rapporti di scambio tra politica ed economia. A fronte di questo quadro, la domanda corretta che non sentiremo a commento del disastro sotto i nostri occhi non è “perché astenersi”, ma “perché votare”
@Filbarbera