Si potrebbe parlare del più classico «ritorno sulla scena del delitto», se però Joël Dicker l’avesse davvero lasciata anche solo per un istante. In realtà, con Il caso Alaska Sanders (La nave di Teseo, pp. 614, euro 22) che lo scrittore ginevrino presenterà nell’ambito della 34a edizione del Salone internazionale del libro che si apre domani a Torino – sabato 21 alle 13,15 in Sala Azzurra, con Simonetta Sciandivasci -, si ritorna laddove tutto aveva avuto inizio. Vale a dire in quelle cittadine del New England dove alla pace apparente e allo spettacolo mozzafiato della natura si accompagnano una lunga serie di sogni dolorosamente infranti, verità negate e segreti che ad un esame più attento rivelano di essere stati celati solo in apparenza, sotto un sottile strato di sassi abbandonati dalle maree dell’Atlantico. Come per il romanzo che una decina di anni or sono rivelò al grande pubblico il nome di Dicker, La verità sul caso Harry Quebert, dal quale Jean-Jacques Annaud ha tratto una serie trasmessa nel nostro Paese da Sky, ma dopo una mezza dozzina di libri e oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo, è intorno all’omicidio di una giovane donna, avvenuto molti anni addietro, che si trovano ad indagare lo scrittore Marcus Goldman e il detective Perry Gahalowood. Allora la scena si svolgeva ad Aurora, nel Maine, ora a Mont Pleasant nel New Hampshire, ma l’intreccio tra i misteri che la letteratura sembra avere il potere di svelare e le fitte ombre di complicità e menzogne che i protagonisti dovranno squarciare resta lo stesso. Quasi un marchio di fabbrica per un autore che sembra coltivare la passione, al pari dei suoi personaggi, per la continua messa in gioco dei codici del romanzo poliziesco.
Fin dal «caso» di Harry Quebert, lei sembra volerci indicare che la scrittura ha uno stretto legame con il mistero. Vale a dire?
Sono convinto che la scrittura rappresenti sempre un mistero perché non deve necessariamente tenere conto di un codice, di uno stile o di qualche regola. Al contrario, che so, della musica che si basa su una tecnica universale, sulle note a cui si rifanno tutti gli autori, scrivere non implica il tener conto di alcuna norma. Allo stesso modo, la scrittura cambia per ciascuno di noi, rappresenta un processo unico. Spesso qualcosa che ci cresce dentro e a cui ci arrendiamo a dare infine spazio nelle nostre vite.
È questo rapporto con il mistero a rendere Marcus Goldman un «detective» suo malgrado, una figura capace di far luce su vicende per le quali non si è ancora giunti alla verità?
Credo che si possa convenire sul fatto che uno scrittore è prima di tutto una persona in grado di raccontare delle storie, descrivere una vicenda o la vita di altri esseri umani. E può farlo senza erigersi a giudice, senza voler davvero arrivare a dimostrare «una verità» o le colpe di qualcuno. E anche Marcus non sfugge a queste caratteristiche. Certo, finisce per fare le sue indagini, ma in realtà è facendo parlare gli altri, ascoltando cosa hanno da dire e soprattutto ciò che magari hanno taciuto per anni che riesce a far emergere qualche verità nascosta. Anche se sono i lettori che in base agli elementi che lui ha fatto emergere possono poi trarre le loro conclusioni: i veri «detective» sono loro.
La redazione consiglia:
Jennifer Pashley e quelle esistenze americane in cerca di redenzioneQuindi il tema da indagare sembra essere piuttosto il rapporto tra la scrittura e la realtà?
Assolutamente. Anche se si deve sempre tener conto del fatto che stiamo parlando di romanzi, di storie inventate, di qualcosa che non esiste, di fiction. Certo, la scrittura può atteggiarsi a guardiano della verità, o può crearne una del tutto fittizia, che si fonde unicamente sull’immaginario e le sue infinite risorse. Quando scrivo, posso raccontare di una vicenda di cui mi avete parlato, rielaborare delle vostre confidenze, oppure inventare di sana pianta un intreccio del quale, dopo averlo letto, mi chiederete: «Ma è vera questa storia?».

Riflettendo sul fatto che dovesse prima di tutto dar voce agli «ultimi», Pierre Bourdieu spiegava che la sociologia somigliava a «un sport de combat», ad un’arte marziale. Prendendo a prestito questa definizione, come definirebbe ciò che rappresenta la scrittura per lei?
Restando sul piano sportivo, direi che si tratta di una disciplina che necessita di un impegno di lunga durata, come la maratona. Non solo i 42 chilometri della gara vera e propria, ma tutta la preparazione che c’è dietro. Perché uno scrittore, come un maratoneta, non è solo qualcuno che disputa quella determinata corsa, che costruisce pagina dopo pagina un romanzo, ma per farlo si è dovuto preparare a lungo, allenando i muscoli come il respiro e spesso scoprendo in sé risorse che non pensava di possedere.
Le sue storie sembrano mettere insieme il romanzo poliziesco e il memoir, il crimine e l’indagine interiore e nelle biografie dei protagonisti.
Ciò che mi sta davvero a cuore non è tanto raccontare quello che ha fatto questo o quel personaggio, ma i motivi che stanno dietro ai suoi atti. Per questo nei miei libri non incontrerete dei serial killer, degli assassini psicopatici che ammazzano un po’ a casaccio qualche malcapitato. Il centro di tutto sta infatti nel perché quella tragedia ha avuto luogo, nei meccanismi che ne sono all’origine, nel contesto all’interno del quale si è prodotta.
Lo sfondo di queste vicende ci parla spesso di una grande solitudine che coinvolge gli stessi protagonisti.
Ho l’impressione che questa solitudine sia un po’ la cifra dell’epoca in cui viviamo. Le persone hanno l’aria di sentirsi sole anche quando sembrano circondate dagli altri. Penso ai social nei quali ci si mette in mostra esibendo una felicità di facciata, tutto è «favoloso», «bellissimo», «irripetibile», anche se in realtà, proprio come accade nella vita di ciascuno di noi, non sempre le cose vanno invece per il verso giusto. Già non ammetterlo, rifugiarsi in un benessere solo apparente, magari per poi scoprire che malgrado si disponga di migliaia di followers è difficile perfino trovare un amico che ci ascolti quando stiamo male, beh credo sia il segnale che la solitudine oggi è un’esperienza di massa.
La redazione consiglia:
George Pelecanos, l’empatia più forte delle pallottoleQuanto allo scenario del ciclo americano dei suoi romanzi, è dominato dai piccoli centri del New England dove i ricchi e le celebrità, spesso arrivate da fuori, vivono fianco a fianco con i lavoratori manuali del posto.
Conosco molto bene quei luoghi, in particolare il Maine perché da ragazzo ci ho passato a lungo le vacanze estive. Però, è vero, partendo dal fatto che si trattava di una zona che amo molto, ho immaginato potesse anche essere lo scenario ideale per una sorta di scontro tra classi e ambienti che si incrociano senza però incontrasi davvero.
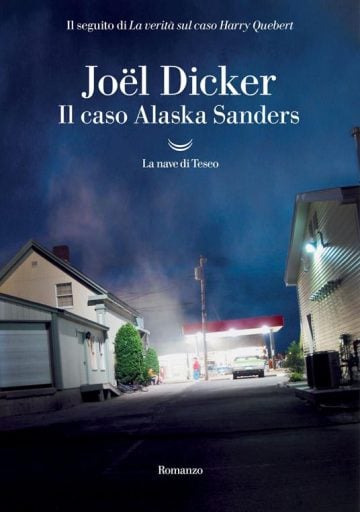
In realtà è come se fossero prigioniere all’interno di mura che però non esistono nei fatti. Sentono che va loro stretta la dimensione di queste cittadine del New England dove tutti si conoscono e dove nulla passa davvero inosservato, ma non riescono a decidere di andarsene. A volte la prigione dalla quale non riusciamo a fuggire, malgrado siamo consapevoli che sarebbe l’unica cosa da fare, l’abbiamo costruita almeno in parte anche con le nostre mani.
In entrambi i romanzi è tra le forze dell’ordine, tra coloro che ne dovrebbero garantire la protezione, che si celano i pericoli maggiori per la comunità…
In piccoli centri come questi è facile che il potere si concentri in poche mani. In una metropoli dove ci sono migliaia di agenti le violenze accadono comunque, ma in un paesino, di sceriffo ce n’è uno solo ed è lui che può stabilire le regole. E magari violarle altrettanto impunemente.
Si suol dire che il tempo è in grado di cancellare oggi cosa. Al contrario, come indicano i vostri romanzi, e una frase di quest’ultimo libro, «un caso non è mai veramente chiuso».
Il trascorrere del tempo ci permette di dimenticarci di qualcosa, di abbandonare le forti emozioni che abbiamo provato di fronte a un determinato avvenimento. Ma in realtà il tempo può nascondere sotto altre vicende un dolore o una tragedia, ma non può mai cancellarla. Non solo. Il passare degli anni fa di noi ciò che siamo ora, ci plasma come un cumulo di pietre cui se ne aggiunge ogni anno un’altra. Ma in queste pietre è racchiuso ciò che siamo stati o abbiamo provato, nel bene come nel male, ed è possibile che scuotendole un po’, come accade nei miei romanzi, tutto torni ad emergere di nuovo. Come se il tempo in realtà non fosse affatto trascorso.





