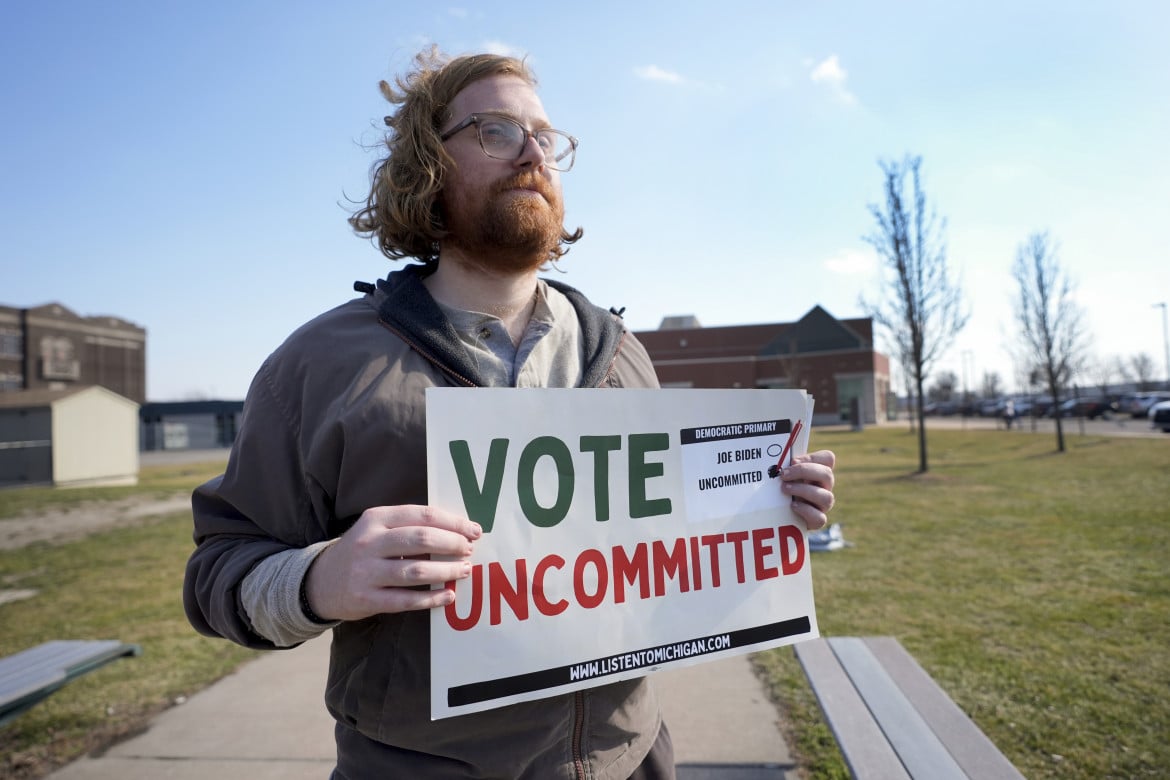Gli apparati dei due partiti non amano le primarie, o meglio vorrebbero che se ne tenessero solo due: i caucus in Iowa e le primarie vere e proprie in New Hampshire la settimana prossima. Queste due scadenze, nella narrazione dell’establishment, sono sufficienti per dare una patina di legittimità al barocco e poco democratico meccanismo di selezione dei candidati alla presidenza. Quindi l’ideale sarebbe che dopo queste due kermesse superpropagandate (che coinvolgono l’1,5% della popolazione americana) rimanessero in scena un solo repubblicano e un solo democratico, massimo due. Ogni tanto, le cose vanno diversamente, come fu nel 2008 quando il rigetto della dinastia Clinton trovò un’alternativa credibile in Barack Obama, ma si tratta di eccezioni: la serie delle primarie finisce solo a giugno, con molti stati tra cui la California che votano solo a fine stagione, e di solito a fine marzo si sa già chi saranno i candidati per le elezioni di novembre.
Quest’anno i partiti sono in difficoltà perché gli stessi elettori sono divisi: i democratici in due gruppi equivalenti, i repubblicani addirittura in tre. Il senatore del Texas Ted Cruz è arrivato prima di Trump, ma di poco, e quest’ultimo ha fatto meglio del «bravo ragazzo» Marco Rubio, ma di un soffio. In altre parole, ci sono tre candidati credibili, che potrebbero alternarsi in testa nei prossimi 49 appuntamenti elettorali, uno per stato.
Iowa e New Hampshire non sono importanti per il numero di delegati che eleggono ma per la possibilità che danno ai partiti di creare uno slancio, una dinamica favorevole, un entusiasmo attorno a un solo candidato. Perché questo avvenga occorre però un’alleanza forte tra il sistema dei media e l’establishment dei partiti, che sostanzialmente devono concordare su un nome, presentarlo come la scelta «inevitabile» dargli la spinta necessaria perché i finanziatori finanzino, gli attivisti si attivino e i votanti votino come richiesto. Di solito funziona.
Quest’anno lo scenario tradizionale potrebbe realizzarsi se, per esempio, il partito repubblicano e le principali organizzazioni della galassia conservatrice (sarebbe più esatto dire «fascistoide») dessero segnali unanimi già da questa settimana a favore del candidato più presentabile, Marco Rubio. Gli elettori, anche frustrati, sono sensibili agli input di Fox News o della National Rifle Association e sposterebbero probabilmente il loro suffragio verso un candidato presentato come quello che avrebbe le migliori probabilità di vincere in novembre contro i democratici.
Se non c’è un largo accordo su questa strategia, il risultato più probabile è una lunga corsa a due tra i candidati più estremisti, Cruz e Trump, entrambi detestati dall’establishment repubblicano, il primo per ragioni personali (anche questo conta, in politica) e il secondo perché è un estraneo, un non politico, un personaggio incontrollabile.
Date le caratteristiche dei due, il partito avrebbe molta difficoltà a ricompattarsi nel sostegno a uno di loro, prolungando il duello – per la gioia di stampa e televisione – fino all’estate. L’incubo di senatori e deputati repubblicani in carica è che si arrivi addirittura alla convention di agosto senza una maggioranza chiara, il che significherebbe trasformare un’occasione di propaganda gratuita in uno spettacolo di divisione del partito catastrofico sul piano dell’immagine.
A complicare ulteriormente le cose sta il fatto che il miliardario Trump potrebbe benissimo decidere di correre come indipendente, se le primarie mostrassero un consenso robusto ma non sufficiente tra i repubblicani. E, per soprammercato, una competizione tra due candidati che rappresentano le ali più ideologizzate e militanti dei rispettivi partiti, Cruz e Sanders, potrebbe stimolare gli appetiti di un vero candidato indipendente, il ragionevole e centrista ex sindaco di New York Michael Bloomberg.
Questa situazione è evidentemente il frutto dell’implosione del partito repubblicano, che negli ultimi ventiquattro anni ha vinto una sola elezione (nel 2004), oltre a rubarne un’altra (nel 2000) con la complicità della Corte suprema. Per un quarto di secolo, l’establishment del partito ha nutrito la paranoia, la xenofobia, il razzismo dei propri elettori senza ottenere nulla sul piano materiale (le condizioni di vita dei maschi bianchi senza laurea sono costantemente peggiorate), né sul piano simbolico: l’aborto è rimasto legale, le nozze tra omosessuali sono legge, l’odiata riforma sanitaria è entrata in vigore. L’unica cosa in cui i repubblicani di Washington si sono dimostrati abilissimi è stato diminuire le tasse ai miliardari e consentire alle multinazionali di fare profitti astronomici, prontamente parcheggiati nei paradisi fiscali.
La ribellione di quest’anno, quindi, è una rivolta dei forconi contro i palazzi e non ha importanza se i leader di questa rivolta sono un miliardario che fantastica di invadere il Messico e chiudere le frontiere ai prodotti cinesi, oppure un senatore estremista e bigotto che potrebbe addirittura essere ineleggibile perché nato in Canada. È una ribellione confusa e fascistoide, che potrebbe segnare la fine del partito repubblicano, ma che potrebbe anche avere successo se i democratici si ostinassero a candidare un personaggio poco amato e molto identificato con i poteri forti come Hillary Clinton.