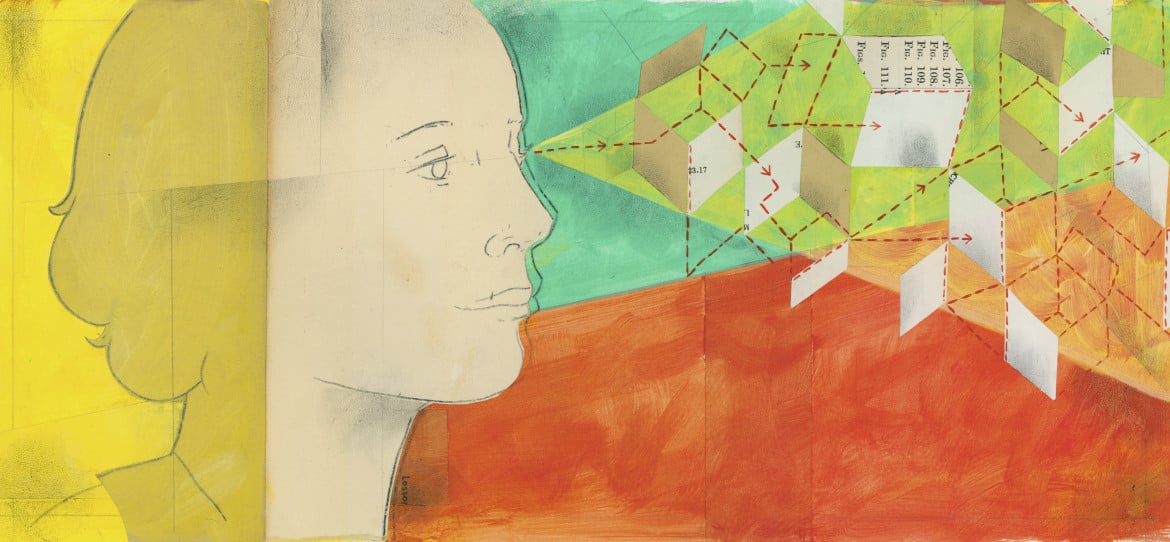«Ma va a casa e torna alle tue occupazioni, / al telaio e alla conocchia ; della parola si preoccupino gli uomini / tutti e soprattutto io, che ho il comando in questa casa». Così parla Telemaco alla madre Penelope in Odissea I, vv. 356-359.
I primi versi si trovano quasi identici nell’Iliade, VI, vv. 490-493. Bisogna solo sostituire «parola» – mýthos, la parola del racconto – con «guerra», pólemos. Questa volta è Ettore a parlare. Si rivolge alla moglie Andromaca, che gli va incontro alle Porte Scee.
Ora, lasciando da parte in questa sede le questioni filologiche legate a Iliade e Odissea, possiamo affermare che dai poemi omerici, testi fondativi della nostra tradizione letteraria e riserva inesauribile di temi e riflessioni, emerge un dato: nella società micenea, che Omero racconta, agli uomini spetta parlare e occuparsi della guerra; alle donne spettano le faccende domestiche. Le donne delle classi dominanti hanno poi il comando diretto su donne di condizione servile.
Entriamo di più nel contesto dei versi. Nell’Odissea, Telemaco reagisce a una richiesta della madre: Penelope ha lasciato il gineceo per ascoltare l’aedo Femio, occupato a intrattenere i pretendenti cantando i viaggi di ritorno dei Greci dalla guerra di Troia. Per la regina è un argomento doloroso. Per questo invita Femio a sceglierne un altro. Si può comprendere: è la moglie di Odisseo, partito vent’anni prima per la guerra di Troia, lasciandola con un bambino appena nato; forse il marito è caduto in quell’assedio; in ogni modo, non ci sono segni di un suo ritorno. Però il figlio la riprende, cogliendo l’occasione per affermare la sua autorità di figlio del re. Il comportamento materno è sentito come espressione di debolezza e di sentimenti poco onorevoli quando si tratta di gloria guerresca, il valore massimo per gli uomini omerici. Telemaco rimette quindi Penelope, letteralmente, al suo posto: lo spazio del privato, opposto a quello della parola pubblica, del canto epico, dell’elaborazione artistica dell’immaginario, destinato a fare da splendido sostegno a un’idea del mondo e della società precise. Penelope torna così al piano superiore, nel gineceo, obbedendo al pater familias supplente.
Nel caso dell’Iliade, Ettore risponde ad Andromaca che prova a consigliarlo in materia di guerra. La guerra ha già sterminato la sua famiglia di origine. Nel caso il marito morisse e Troia, senza di lui, cadesse in mano dei nemici, Andromaca sarebbe ridotta in schiavitù e condannata a diventare la concubina di un Greco. Il figlioletto, in quanto maschio, verrebbe ucciso. Per amore della vita, la donna esorta il marito a non comportarsi da eroe. Ma, in Omero, gli uomini o sono guerrieri valorosi o non sono degni di rispetto. Sono educati così; Ettore lo spiega bene. Il discorso di Andromaca gli suona, in fondo, come un discorso da donne, incapaci di comprendere i valori eroici, ripiegate in un privato ignaro e tremante, destinate a essere protette, oppure rapite, bottino di un qualche nemico.
Come la madre, anche Astianatte piange tra le braccia dell’ancella quando il padre, catafratto nell’armatura, con il cimiero minaccioso, gli si avvicina. Ecco, le donne e i bambini: il gruppo solidale che rappresenta l’umanità, la vita nella sua mortalità, privata degli orpelli dell’eroismo, vulnerabile e misteriosamente commovente, e che ritorna in scena a ogni nuova guerra. Alla paura del bimbo, Andromaca sorride e piange insieme; Ettore sorride, si toglie l’elmo, solleva tra le braccia il piccolo e lo offre, in una preghiera, al suo destino di uomo: si augura che cresca simile a lui e che un giorno qualcuno dica «è molto più forte del padre / quando verrà dalla lotta. Porti egli le spoglie sanguinanti / del nemico abbattuto, se ne rallegri in cuore la madre!» (vv. 479-481).
Astianatte non crescerà e le spoglie sanguinanti saranno le sue, nelle mani di un altro figlio guerriero di un padre guerriero. Un’altra madre sarà orgogliosa dei massacri del bambino diventato uomo più forte del padre; non Andromaca.
Alle radici del nostro immaginario c’è dunque una guerra, la prima di una lunga serie. C’è il patriarcato, uno dei codici sorgenti delle società di classe, compresa quella in cui viviamo oggi. La parola rimanda a una storia millenaria che ha portato al predominio di un sesso solo e alla definizione di una gerarchia, istituzionalizzata e simbolica, incardinata nelle leggi, naturalizzata nel senso comune, consegnata ai prodotti dell’immaginario come un dato ineludibile di realtà, iscritta nei corpi. Questa gerarchia determina dei rapporti di forza, fortunatamente soggetti a mutamenti storici, come ogni fenomeno umano.
Omero è il primo testimone di quest’ordine verticale, della divisione dei sessi e del lavoro che esso determina, assegnando alle donne la casa, la cura della famiglia, i sentimenti; agli uomini la dimensione pubblica, la parola autorevole, universalmente valida, neutra, ma anche la guerra, la necessità di essere forti e di non avere paura, di non mostrare i propri sentimenti, la violenza agita e subita come misura della propria dignità.
Tutto questo è un’evidenza, da cui si può partire per ragionare e confrontarsi con serietà e strumenti rigorosi, senza voler mettere le brache alla storia né pretendere dal mondo antico la condivisione dei nostri pensieri, delle nostre preoccupazioni e delle nostre lotte. Ma senza neppure affermare che il nostro immaginario – mitico, letterario, artistico – non sia sessualmente connotato o che uomo voglia dire umanità, perché storicamente non è così.
Parlavo dell’evidenza dell’ordine patriarcale in Omero. Ebbene, su questa evidenza nessuno, durante gli anni della mia formazione liceale e universitaria, ha mai attirato la mia attenzione. Eppure ho avuto insegnanti preparatissimi, uomini e donne. Nel famoso incontro di Ettore e Andromaca mi veniva additata la bellezza di una famiglia sullo sfondo atroce della guerra, la dolcezza dei due sposi innamorati e del loro piccolo, la dignità di Ettore, così umano nel togliersi l’elmo per prendere in braccio il figlio, l’aura straziante del vinto che soccombe dalla parte giusta. All’epoca, dunque, contemplavo una versione omerica della sacra famiglia e tifavo per i Troiani, invece di interrogarmi sul fato di un’umanità che aveva come unico orizzonte la guerra e la rapina.
Forse per certe prospettive, i tempi non erano ancora maturi. Forse non c’era neppure tempo per scavare negli strati più profondi del nostro patrimonio culturale, delle nostre strutture psichiche. Il tempo manca anche oggi ma gli strumenti per scavare ci sono. Basta interrogarli, liberandoci dalle tentazioni di una falsa coscienza. Non è più possibile ignorare decenni di teoria femminista, scartare in blocco, senza considerarla seriamente, la proposta, sempre più ricca, di opere di scrittrici, filosofe, poete, intellettuali scivolate nello scantinato della storia dopo morte perché private di attenzione critica, non fare i conti con una cancellazione che è un dato storico e con creazioni che fanno sì parte del nostro immaginario comune, e che possono essere esteticamente compiute, ma non sono neutre; sono un’elaborazione unicamente maschile, inserita in quei famosi rapporti di forza che la gerarchia patriarcale impone. Un allargamento di prospettiva non toglie nulla ma aggiunge voci, bellezza e autorevolezza ai testi, ai contenuti dei programmi scolastici, mettendoli in relazione con la vita e l’esperienza.
Chiudo con i versi di un poeta greco vissuto nel secolo scorso, Yorgos Seféris. Come Andromaca, come Penelope, Seféris è stanco e sgomento di fronte alle continue catastrofi umane, della Grecia, nostre. Si mette dalla loro parte, quella dell’umanità nuda, che riconosce i propri limiti mortali e che vuole vivere, sperare in una qualche felicità; un’umanità che il patriarcato respinge, bollandola come femminile, in senso deteriore, inferiore per natura.
Nel 1934 Seféris scrive Astianatte e immagina che Andromaca sia scappata prima della caduta di Troia, lasciandosi alle spalle il marito e il suo cimiero, portando con sé il figlio, salvandolo, per crescerlo altrimenti, lontano da logiche di dominio, da mortiferi maestri e dalla paura: «Ora che parti e che del compimento / Il giorno è sorto, e che ciascuno ignora / Chi ucciderà, come verrà la fine, / Con te prendi il bambino che ti nacque / All’ombra di quel platano: maestri / Gli siano gli alberi».