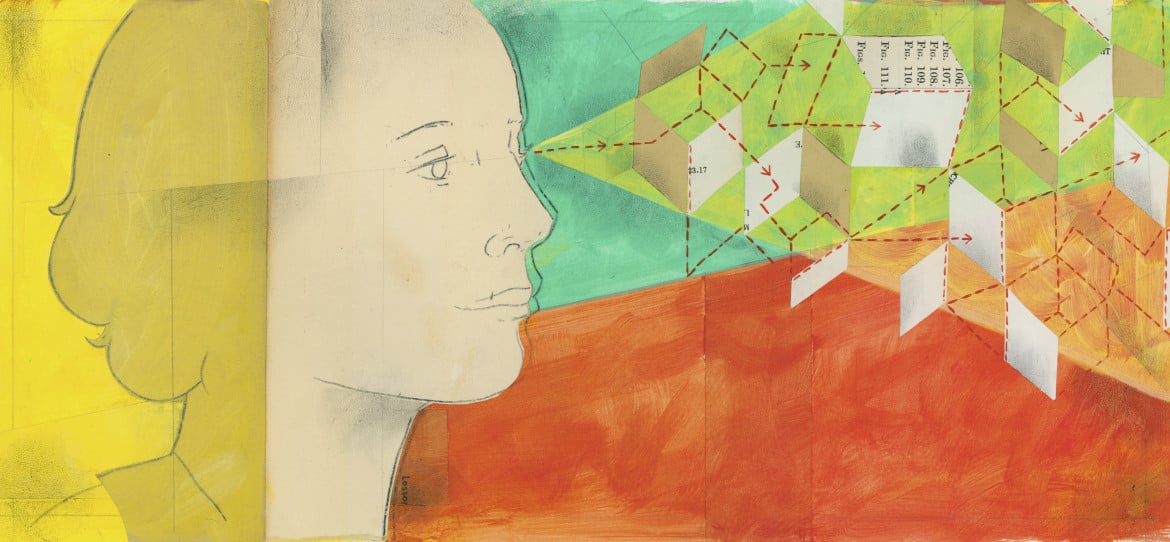È forse il segno di un cambio di prospettiva quello che alcune voci stanno portando in superficie, invitandoci ad abbattere i confini che separano la violenza contro le donne e di genere da quella verso il corpo composito della natura.
LA GIORNALISTA brasiliana Eliane Brum, nel libro Amazzonia, viaggio al centro del mondo (Sellerio, 2023), è riuscita a illuminare i diversi aspetti di una lettura per forza di cosa radicale, intessuta attraverso l’esperienza diretta a contatto con il polmone verde del pianeta, i suoi abitanti e le loro lotte. «L’Amazzonia non è il luogo in cui trasportiamo semplicemente il nostro corpo, quella somma di batteri, cellule e soggettività che rappresentiamo» scrive l’autrice: «L’Amazzonia ci salta dentro, come un anaconda che attacca, frantuma la spina dorsale dei nostri pensieri e ci mescola al midollo del pianeta».
LA DEFINIZIONE DI FORESTA «VERGINE» diviene espressione del dominio sui corpi e una fascinazione per ciò che è naturale, selvaggio e incontaminato che implica la possibilità della sua distruzione. In un mondo in cui «la violenza è parte integrante di ciò che vuol dire essere donna, tanto quanto le ossa, gli organi, il sangue», Brum parla del suo percorso di «riforestazione», «inteso come un altro modo di concepirmi, nel mondo, con il mondo, essendo il mondo». «La lotta per la foresta è la lotta contro il patriarcato, contro il femminicidio, contro il razzismo, contro il binarismo di genere», scrive, spiegando il suo tentativo di de-biancarsi, di spogliarsi dei propri privilegi per divenire un’altra esperienza decolonizzata di sé.
LA FERITA COLONIALE CHE HA PLASMATO il nostro mondo, e di cui oggi gran parte della biodiversità del pianeta porta ancora l’impronta, è anche alla base della rilettura dirompente del quotidiano portata dal femminismo nero, che ha permesso di vedere come l’Antropocene sia necessariamente razzista, sessista e profondamente coloniale. A ricordarlo è anche Gaia Giuliani, filosofa politica esperta in studi culturali e postcoloniali e ricercatrice permanente presso il Centro Studi Sociali dell’Università di Coimbra. Nel suo ultimo libro Monsters, Catastrophes and the Anthropocene, A Postcolonial Critique, (Routledge, 2022) analizza come i processi di sfruttamento delle risorse naturali determinino chi è degno di beneficiarne e chi è sacrificabile alle loro conseguenze.
«L’etica del progresso e della produzione capitalista ha potuto schiacciare qualsiasi cosa, producendo dalle morti bianche all’inquinamento, fino all’estinzione di comunità ritenute di riserva – spiega Giuliani. «Le forme di oppressione a cui noi assistiamo sono indistinguibili: non si può parlare di capitalismo senza parlare di patriarcato e colonialismo. E la violenza antropocentrica si sviluppa attraverso l’esposizione alla morte di determinati soggetti, sia a livello epistemico che materiale».
ANCHE IL TERMINE ANTROPOCENE è inteso come espressione del tentativo di ripensare un capitalismo meno predatorio che non potrà comunque perdere la sua qualità violenta e escludente. «Partendo dall’idea che il patriarcato, seppure in maniera più forte verso alcuni soggetti come le donne non bianche o la comunità queer, fa male a chiunque, produce la donna vittima di femminicidio e il suo aguzzino, io credo in un progetto politico femminista che è per tutti, come dice Bell Hooks, radicale e immanente, che immagini un presente basato sulla transcorporeità e l’interdipendenza tra tutti gli esseri viventi, in cui possiamo esperire per un attimo l’assenza di violenza».
A TARANTO, IL TERRITORIO ABUSATO dall’attività dell’Ilva ha portato all’organizzazione della Convocatoria Ecologista, una «chiamata» annuale alla riflessione e alla sperimentazione di pratiche collettive per superare l’antico ricatto fra salute e lavoro. «Ci siamo chiesti cosa significa salute da un’area che persino l’Unione Europea riconosce come zona di sacrificio in cui si è naturalizzato il diritto di inquinare» racconta Micheal Tortorella, attivista ecologista che ha contribuito alla costruzione della Convocatoria.
«La convivenza con un dispositivo inquinante entra nella quotidianità, vita e morte non sono più meri processi biologici, ma storici, culturali, politici. Nel ricatto tra lavoro e ambiente, spesso si considera lavoro solo quello nella fabbrica, mentre si esclude chi si fa carico delle conseguenze irreversibili prodotte da quel modello. Il lavoro di cura, sistematicamente dequalificato e invisibilizzato, risponde a una divisione di genere e coloniale del lavoro senza cui il ricatto salute-ambiente non si sarebbe potuto dare».
IL TEMA È STATO RIPRESO NEL LABORATORIO di «Cos’è capace questo corpo-territorio, coordinate per una mappa della guarigione collettiva», tenuto nella scorsa edizione dalla ricercatrice e attivista femminista decoloniale Marie Moïse: «La questione che fa da matrice alla violenza di genere e sui territori è l’idea di potersi relazionare in termini di proprietà alla terra, ai corpi delle donne, ai corpi che lavorano. La costruzione sul piano simbolico deriva da una gerarchia che va dall’umano al sub umano, entro la quale deve rientrare tutto il vivente che non corrisponde a un’idea bianca, maschile, occidentale e sui cui poggia l’accumulazione del capitale.
Il ragionamento sul corpo-territorio nasce quindi dall’idea di pensare una trasformazione radicale complessiva a partire da come non essere conniventi con questa visione» – spiega ancora Moïse, che insieme al gruppo di Napoli Splash, collettivo di lavoro im/materiale e attraverso i laboratori cerca di portare attenzione su come l’uso della forza su corpi e territori testimoni però anche come l’atto di appropriazione incontri sempre una forma di resistenza: «La passività di tutto ciò che non è maschile occidentale è una costruzione ideologica. Concentrarsi sulle capacità di resistenza per alimentarle significa attivare processi di guarigione corporea-territoriale».
* Questo articolo aderisce alla campagna Unite. Azione letteraria, che invita scrittrici e giornaliste italiane a denunciare la violenza di genere e nominarla