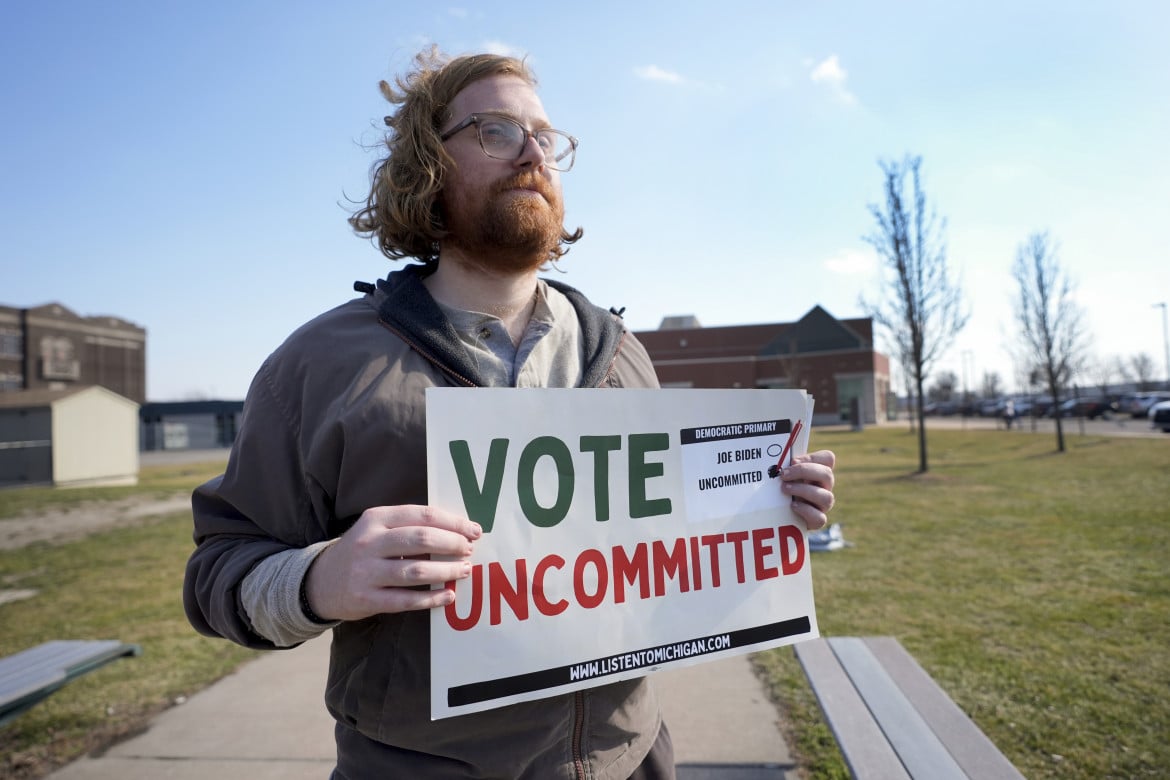L’ultima notizia da una campagna elettorale ormai fuori da ogni schema, riguarda l’annuncio «ufficiale» dell’alleanza fra Ted Cruz a John Kasich. Nell’estremo tentativo di sbarrare la strada Donald Trump i due si sono spartiti i rimanenti stati per ottimizzare le probabilità che Trump non raggiunga i 1.237 delegati necessari alla nomination prima della convention di Cleveland. Mentre il voto di oggi dovrebbe servire ad avvicinare Hillary alla matematica soglia dei 2.383 delegati necessari alla nomination, è molto più incerta la sorte di Trump che potrebbe sfiorare, ma non centrare- come sperano, oltre a Cruz e Kasich molti repubblicani – il numero magico di 1237 delegati.
Qualora nessuno lo facesse, in una contested convention i delegati diventano essenzialmente battitori liberi. Le regole stabiliscono che in quella sede al primo turno i delegati assegnati dalle elezioni debbano rispettare il voto popolare. In caso di fumata nera però, a partire dai turni successivi, è consentito votare secondo coscienza – o meglio secondo accordi e patteggiamenti. È l’ipotesi sui conta Ted Cruz che non ha alcuna possibilità di raggiungere la soglia nelle primarie ma sta già attivamente reclutando delegati utili ai turni successivi nella convention. Ed è la stessa strategia che persegue anche il moderato Kasich, che da tempo è matematicamente escluso dalla vittoria.
Dietro le quinte i candidati sono dunque impegnati in una lobby senza quartiere per assicurarsi la fedeltà dei delegati. Una campagna ombra in cui è particolarmente zelante Ted Cruz. Per contro alcuni delegati, riuniti la settimana scorsa al congresso del comitato centrale repubblicano, hanno denunciato di aver ricevuto minacce, perfino di morte, se non rimarranno fedeli a Trump. Su questo sfondo non è esagerato dire che il partito repubblicano sta implodendo sotto gli occhi attoniti degli americani e quelli inorriditi dei suoi dirigenti.
Il Gop è un partito in paradossale conflitto con i propri candidati: Trump e Cruz hanno raccolto il 90% delle preferenze nelle primarie ma rimangono invisi ai dirigenti che discutono apertamente di come pilotare la convention contro di loro.
In parlamento i repubblicani hanno usato la maggioranza in entrambe le camere per fare ostruzionismo ad oltranza ad Obama, ma sono rimasti incapaci di esprimere progetti alternativi. La Republican revolution di Newt Gingrich negli anni Novanta e l’ascesa dei neocon di era Bush hanno nascosto divisioni insanabili fra la base e la dirigenza del partito, una spaccatura evidenziata dalla rivolta del Tea Party.
Quel movimento di matrice populista esprime tutta l’insofferenza della base per una leadership che ha regolarmente strumentalizzato le pulsioni ideologiche più retrograde per amministrare il proprio potere politico. I repubblicani hanno alimentato decenni di culture wars su aborto, matrimoni gay e immigrazione, facendo leva sulle paure più viscerali del proletariato bianco e dell’hinterland teocon per vincere elezioni.
Ma le «guerre culturali» sono state in gran parte perse, superate dall’evoluzione demografica e generazionale – e sentenze dei tribunali. E il rancore di un elettorato «orfano» è stato raccolto dalla «Trump revolution». Il populismo di Trump esprime, come quello europeo, le psicosi e la paranoia di un elettorato esautorato che volge all’esterno le proprie paure.
Così quest’anno in cui la crisi economica in definitiva è sicuramente meno acuta di otto anni fa e in cui anche l’immigrazione è diminuita, Trump ha dato voce ad una repressa rabbia populista che ha spazzato via i due schieramenti tradizionali della destra, i conservatori «moralisti» e la fazione storicamente dominante vicina a Wall street. I due partiti Usa sono da sempre «tentpole» che raccolgono ampie coalizioni di correnti assai diverse, ma all’interno del «tendone» repubblicano è chiaramente in atto un riallineamento strutturale che la leadership non sembra in grado di gestire e che rischia di rendere irrilevante lo stesso partito.
Paradossalmente infatti il candidato ideale del capitalismo moderato quest’anno sarebbe Hillary Clinton, certamente più vicina agli interessi di Wall Street e della nomenclatura del Pentagono che non gli «insorgenti» Trump o Cruz. Segno che il partito democratico vive un momento se non altrettanto drammatico quasi altrettanto significativo. Le due anime rappresentate da Clinton e Sanders infatti, si avvicinano al traguardo della nomination profondamente divise.
Il successo della sfida progressista di Sanders ha colto di sorpresa gli stessi dirigenti del partito e messo in discussione la coalizione pluralista riunita nel segno di Obama. Un panorama frammentato che indica la crisi dello stesso bipartitismo americano. Si può dire semmai che una corretta rappresentazione dell’elettorato necessiterebbe di almeno quattro partiti: populista, conservatore, moderato e progressista.
Uno scenario impensabile nell’assetto politico americano, ma forse in fondo non del tutto. Un sistema multipartitico americano non è mai davvero stato un prospettiva realista. Ma se mai c’è stato un anno in cui è parso plausibile, anzi necessario, è questo.