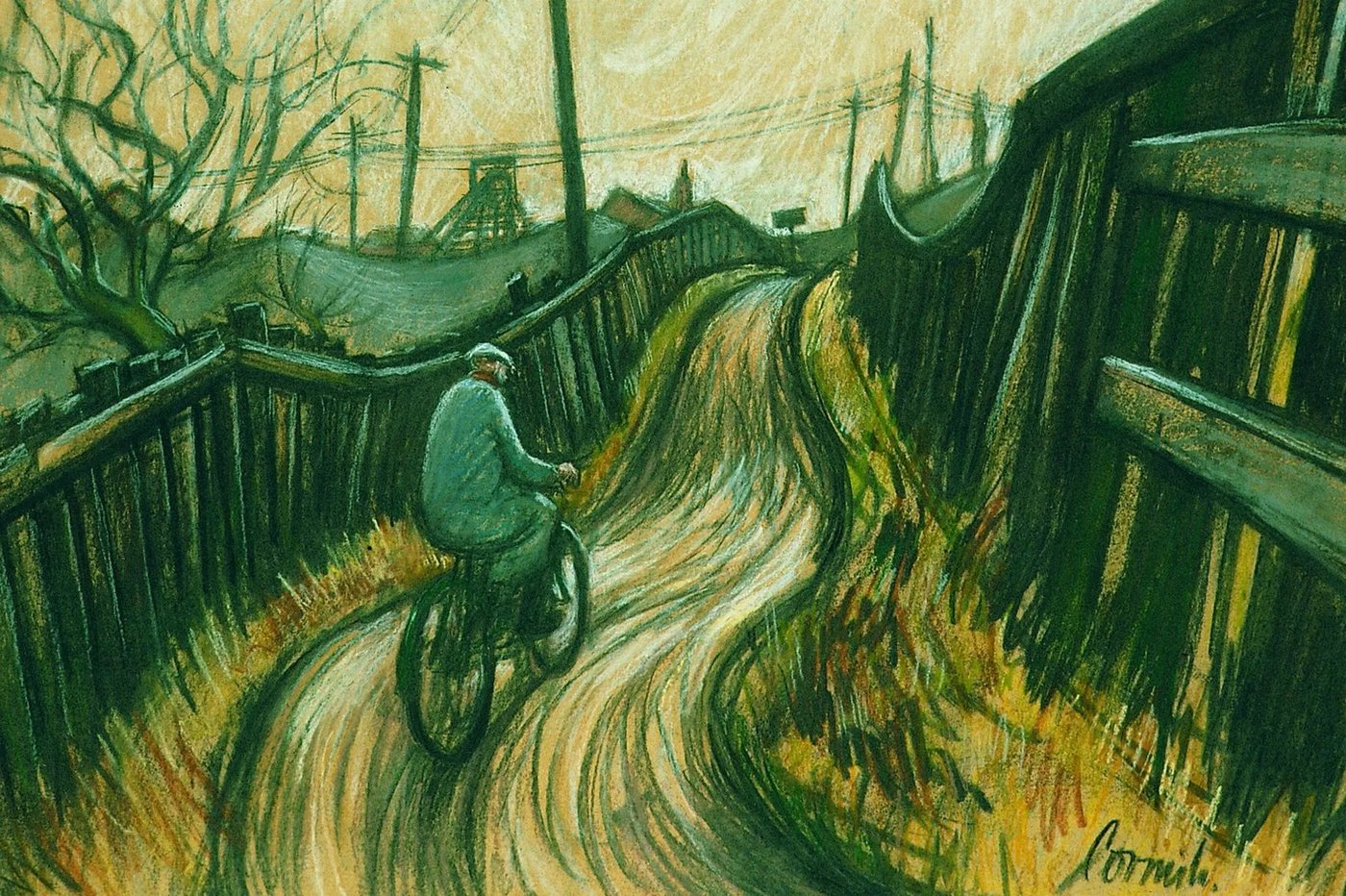Sconfitte, miserie e virtù della classe operaia trovano oggi una degna rappresentazione nei romanzi di Anthony Cartwright, forse l’unico scrittore britannico che sia stato capace di aggiornare letterariamente il working class novel, i cui precedenti più riusciti vanno dal D. H. Lawrence di Figli e amanti ai romanzi di Elizabeth Gaskell a quelli più ironici di Alan Sillitoe. Già in The Afterglow, la sua opera prima, poi in Heartland, la storia di una partita di calcio dilettantistico che rischia di scatenare una guerra razziale, fino a Il taglio, il primo romanzo britannico sulla Brexit, al centro del lavoro di Cartwright è Black Country, territorio delle Midlands occidentali, che nella prima metà del Novecento era una delle zone più industrializzate dal Regno Unito, immiserita, poi, dalla scomparsa dell’industria pesante e, successivamente, dalla politica anti-inflazionistica del governo Thatcher. Proprio attorno alle conseguenze pagate dalla classe operaia di Black Country dopo la deindustrializzazione e le privatizzazioni imposte dalla Iron Lady, ruota il romanzo di Cartwright, Come ho ucciso Margaret Thatcher, uscito in Gran Bretagna nel 2012 e solo ora pubblicato in italiano (da Alegre, pp. 256, € 17,00), nella traduzione di Alberto Prunetti, che rende brillantemente il non semplice linguaggio dell’autore, dove spesso si trovano inserite, soprattutto nei vivaci dialoghi tra i suoi personaggi, parole o espressioni del particolare dialetto orale di Black Country, con tratti di inglese arcaico.
Spetta all’occhio di Sean, un bambino che ha nove anni all’inizio del romanzo, filtrare gli accadimenti: figlio e nipote di operai, ingenuo e ancora incapace di analisi politiche, Sean assiste impotente al progressivo disgregarsi del suo mondo, registrando le reazioni degli abitanti della sua città, Dudley (che è anche la città natale di Cartwright), di fronte agli episodi chiave del governo di Margaret Thatcher, dal giorno della sua elezione nel maggio 1979 fino al 12 ottobre 1984, quando il primo ministro inglese scampò, a Brighton, a un attentato dell’IRA che causò la morte di cinque suoi collaboratori, e una quarantina di feriti. Pur avendo esordito come osservatori preoccupati e, all’occorrenza, commentatori indignati di fatti come l’irruzione armata nell’ambasciata dell’Iran nel 1981, lo sciopero della fame e la morte di Bobby Sands, o la guerra delle Falklands, famigliari e vicini di Sean si trasformano via via, loro malgrado e senza campo, nei sopravvissuti di «un posto ai margini di un impero in frantumi». Le fabbriche chiudono, la disoccupazione aumenta: perdono il lavoro anche il padre di Sean, che si vede costretto a intraprendere un’attività illegale per pagare il mutuo della casa in cui si stringe il suo sogno di elevazione sociale, e il nonno, licenziato a un passo dalla pensione. A Sean sembra non rimanga altro, per evitare ulteriori catastrofi, che uccidere Margaret Thatcher. Ci prova, infatti, ormai adolescente, andando a Brighton, dove approfitta del congresso annuale dei conservatori per proporsi di spararle, con la pistola del nonno.
Sebbene l’espediente della storia vista attraverso uno sguardo vergine non sia originale (sono molteplici le riletture infantili della storia coloniale apparse sulla scia dei Figli della mezzanotte di Rushdie) inconsueto è, invece, l’espediente di affiancare alla narrazione in corsivo e al tempo presente del bambino, il ricordo, scritto in carattere tondo e declinato al passato, dello stesso Sean ormai adulto, che riflette, all’incirca tre decenni più tardi, sulla rovina del suo mondo innocente, che già vede ulteriormente aggravata da fatti tragici ancora di là da venire: «Ci vogliono una trentina d’anni, credo, per riuscire a distruggere qualcosa completamente. Una comunità, una società, come vuoi chiamarle. Le cose ci mettono tanto per morire. È quello che hanno pianificato, se davvero avevano un piano. Dopo il primo shock, tenere la pressione costante. Svendere tutto quello che si può vendere, fino all’ultimo pezzetto. Rimanere in uno stato di crisi permanente. Una rivoluzione… in fondo».
Controcanto al racconto di Sean bambino e ai suoi ricordi di adulto, una terza voce si fa sentire nel romanzo: quella di Margaret Thatcher, dalla quale vengono prese in prestito frasi tratte da suoi discorsi o da interviste, poste in esergo a ogni capitolo, tanto che le parole della ex primo ministro finiscono per costituire una sorta di sottofondo acustico del romanzo: «All’epoca, la voce di Thatcher era ovunque e volevo trasmettere quella sensazione: volevo – ha detto Cartwright – che la sua voce emergesse come una sorta di colonna sonora della vita di tutti i giorni, trasmessa dalla radio e dalla televisione. Una voce strana: fragile, con un accento curioso e teso. E ciò che diceva era straordinario, a volte in completo contrasto con ciò che intendeva effettivamente fare».