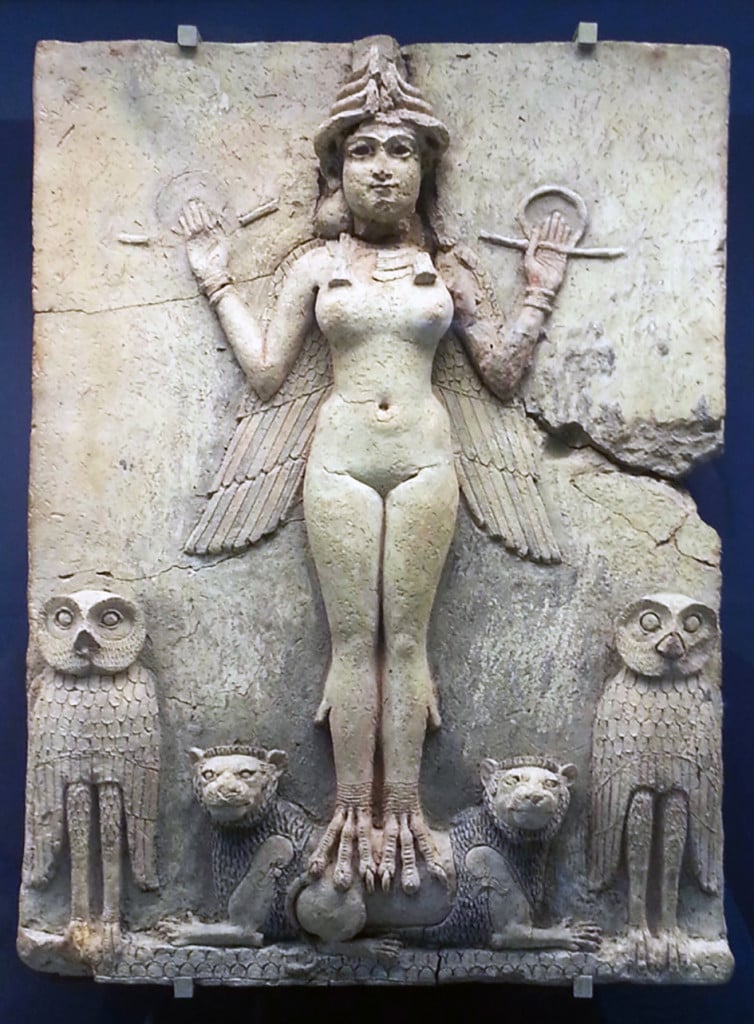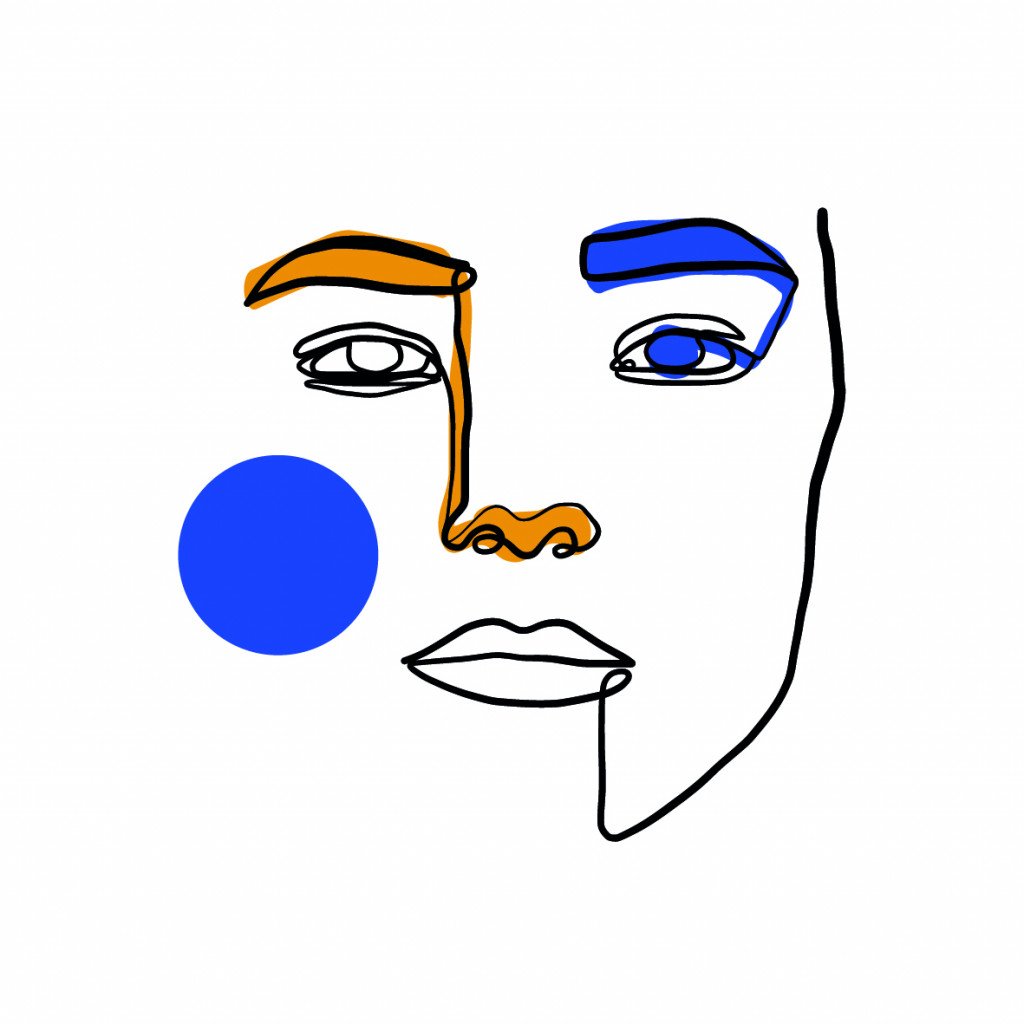Da quando la pandemia ci ha sconvolti, una delle parole che ho sentito usare più spesso è «cura». La cura in senso clinico, ovviamente. E il suo contrario – incuria – quando gli interessi economici hanno prevalso sul dovere di curare tutti gli esseri umani, inclusi i meno performativi, cioè gli anziani. Ma anche «cura» in moltissime altre accezioni: la classe insegnante si è presa cura dei discenti da remoto, molte persone di buona volontà hanno inventato la Spesa Sospesa o altri escamotage per aiutare i meno abbienti, e, in senso generale, il governo ha battezzato il decreto che deve portarci fuori da questo momento tragico «Cura Italia».
Eppure, la parola «cura» non mi piace. Non ne che non ne conosca la poliedrica e intrigante significanza, da Heidegger a Franco Battiato. Ma c’è sempre qualcosa che mi trattiene dall’usarla. Forse perché, inconsciamente, l’abbino al buon cuore di chi dà parti infinitesimali di ciò che ha a chi non ha niente, mettendosi in pace la coscienza, e non agendo mai sulle cause che conducono alle sperequazioni sociali, economiche e politiche. O, anche, perché il «lavoro di cura» è la gabbia nella quale sono sempre rinchiuse le donne, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno anche un’attività lavorativa/professionale fuori dalle mura di casa. Oppure, di quelle incombenze si fanno carico persone chiamate «care givers», quasi sempre di sesso femminile. La mancata negoziazione dei carichi familiari è tuttora alla base di una visione patriarcale e arcaica della società, e delle relazioni che vi si sviluppano dentro – e che evolvono, molto di più di quanto dicano le statistiche, in relazioni abusive.
Sarà per questo che io non ho mai usato la parola «cura» nel definire il lavoro che faccio con la mia organizzazione, Be Free Cooperativa Sociale contro Tratta, Violenze e Discriminazioni, con le donne che esperiscono le situazioni descritte nella denominazione sociale – e che non sono iatture o punizioni, ma violazioni dei diritti umani. Mi piace lavorare con le donne, come ho detto. Non su loro, non per loro. Con loro, perché è ciascuna di loro a potermi far capire, insieme a lei, quale è stata la sua storia – di coppia, o di traffico di esseri umani –, perché ogni storia è unica, e solo chi l’ha vissuta fino in fondo può darne la chiave di lettura, e individuare la migliore via d’uscita. Mi piace lavorare con le donne non soltanto perché sono loro le vere esperte della propria storia, non soltanto perché è magnifico vederle emergere da un viluppo terribile di condizionamenti, legacci e catene, e riacquisire quello che era già loro, in termini di autodeterminazione, autorevolezza, progettualità. Di più: mi piace lavorare con le donne perché percepisco il profondo valore trasformativo che ogni donna che si libera può imprimere nel contesto sociale dato, ancora tanto intriso di patriarcato e di dolorose presunzioni di inferiorità femminili. A differenza del buon samaritano generoso, io pretendo che un intero contesto – sociale, politico, economico, culturale – cambi, superando le narrazioni tipicamente usate da chi nel contesto dato si trova benissimo. Dunque, pretendo qualcosa per me, per mia figlia, per le mie nipoti, se ne avrò.
Mi irrito, però, quando si chiama al soccorso verso le «vittime di violenza» rinchiuse dalla quarantena nelle «case prigione» in balia dell’«orco». Non perché questo non accada (a Be Free abbiamo ogni giorno un picco crescente di chiamate dalle donne che vivono situazioni simili), ma per la banalità della narrazione convenzionale. «Vittima di violenza» è un termine che, lapalissianamente, rivittimizza le donne che esperiscono violenza di genere, appiattendole su uno stereotipo. È una definizione che presume si conoscano già le infinite variazioni che tutte le vicende assumono: personali e di coppia, molteplici e sfaccettate come le individualità sessuate maschili e femminili. Dicendo «salviamole» le arruoliamo in un esercito di donne incapaci di difendersi, scarse di risorse. È come entrare in tutte le case, sapere che gli uomini violenti lo sono sicuramente diventarti di più, e le donne si sono ancora più indebolite. Quest’occhio strabico da Grande Fratello presume di «sapere», appunto. Il partner abusivo non è un pugile suonato che scatta a dare cazzotti in automatico appena sente la campanella del ring bensì uno che ha una gamma infinita di reazioni possibili: forse, costretto alla quarantena, ha vissuto se stesso come fragile, ha messo a tema quella debolezza, magari si è dato un’ora d’aria dal modello maschile che per cultura interpreta oppure la paura l’ha tirato come una corda di violino, si è sentito inadeguato, questo gli ha portato ansia o depressione o rabbia ed è stato feroce; forse è stato un armistizio, non conosciamo i fatti. È violenza anche presumere di sapere.
In vita mia ho incontrato migliaia di donne che volevano uscire dalla loro condizione di coppia. Ma non ce n’è stata mai una che mi abbia raccontato di una relazione in cui quotidianamente, ogni minuto del giorno e della notte, subisse incessanti atti di violenza. Perché le storie non sono mai così. Le storie iniziano con un sentimento e con un’attrazione, come per tutte e tutti, poi si insinuano nel menage meccanismi di controllo agiti dal partner che derivano dalla narrazione socialmente diffusa del Maschile e del Femminile, in cui la differenza di potere è lapalissiana: lui è il capo famiglia, lei è la subalterna. La violenza agita da lui arriva così, sulle rotaie comode degli assiomi universalmente assunti. Per esercitare il controllo sulla “propria” donna bisogna normarne i comportamenti, ed intervenire se questi deviano dal proprio desiderio – dalla propria visione del mondo. Per sentirsi sicuri del ruolo bisogna essere certi del proprio predominio, e della propria presenza granitica nella vita della partner. E dunque la gelosia, per esempio, è un motivo adeguato per sottoporla a violenza se su quella fedeltà si nutrono dubbi, è anzi una dimostrazione del proprio amore.
E dove sono diffusi questi assiomi così crudeli? Nella società civile tutta, nel percepito socialmente accettato, nelle differenze economiche, culturali, sociali e politiche ancora granitiche, nei meccanismi di autoidentificazione maschile e femminile che tuttora vengono percorsi, in mancanza di alternative, dagli adolescenti maschi e femmine. A fine 2019 l’Istat ha reso noto che l’adesione degli italiani a tutta questa paccottiglia di stereotipi e pregiudizi è ancora granitica.
È di questo che bisogna occuparsi: di cambiare la cultura, di scompaginarne le tragiche basi.
Qui da noi è stato più semplice gridare dal ponte di salvare le donne-naufraghe, dimenticando che, in tempi normali, le donne che sporgono denuncia per maltrattamenti sono stimate essere solo il 7% di quelle che li vivono, ed il 4% sarebbero quelle che cercano il sostegno dei Centri Antiviolenza (dati Istat). Dimenticando anche che, alle situazioni più tragiche, è necessario offrire una via di fuga immediata, e che i posti nelle case rifugio sono, in Italia, appena il 10% di quelli che il Consiglio d’Europa giudica adeguati in relazione alla popolazione (poco più di 608 rispetto ai 6087 ritenuti necessari). Dimenticando, inoltre, che da anni circa 150 donne vengono uccise dal partner – e anche questa è una pandemia – e che la maggioranza assoluta di loro l’aveva denunciato e/o lasciato, senza ottenere dallo Stato la protezione prevista dalla Convenzione sulla Violenza contro le Donne del Consiglio d’Europa (Istanbul, 2011), che gli Stati dovrebbero seguire con «due diligence».
E le donne-naufraghe (molte) si sono salvate da sole. Chiamando i centri antiviolenza, usando nuovi strumenti: whatsapp, messanger, sms, email. Dimostrando che non di benevola compassione hanno bisogno, ma di strumenti concreti, e di un profondo cambiamento nella società. Molte altre sono rimaste lì, come da sempre accade. In attesa che quel cambiamento avvenga, per tutte, tutti, tutto.