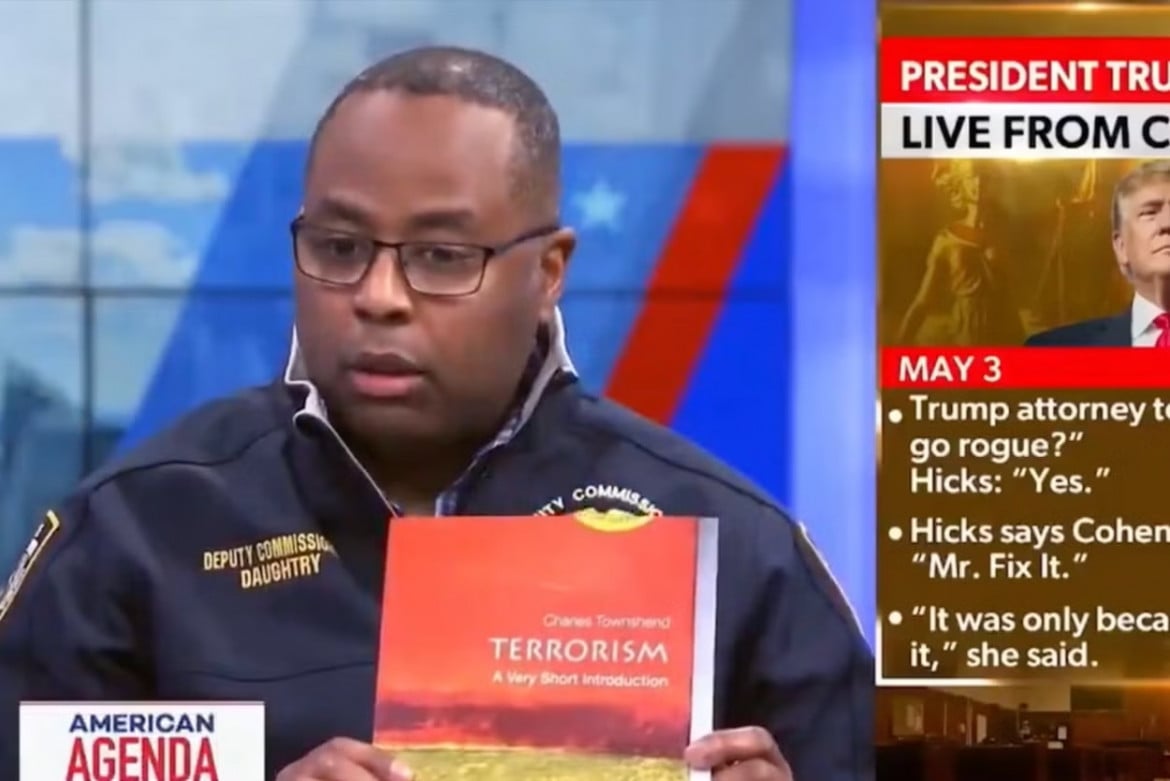Quattro settimane di presidenza Trump e già i democratici parlano di impeachment. Il New York Times chiede “Cosa sapeva il presidente e quando lo ha saputo?”, riferendosi ai contatti del dimissionario consigliere per la sicurezza nazionale Flynn con l’ambasciata russa. Ai party di Washington la parola più usata in queste ore è “Watergate”, quel meraviglioso anno 1974 quando un presidente repubblicano fu costretto alle dimissioni da due giornalisti senza macchia e senza paura.
Purtroppo si tratta solo di questo: gossip sorseggiando un cocktail. Nei 230 anni di vita della costituzione, nessun presidente è mai stato rimosso dal suo incarico attraverso questa procedura. Nessuno. Nixon si dimise avendo perso l’appoggio del suo partito ma non è affatto sicuro che un eventuale processo si sarebbe davvero concluso con la sua destituzione. Il motivo è semplice: la costituzione esige un consenso pressoché universale per rimuovere un presidente, un accordo che si deve concretizzare in un voto a maggioranza semplice della Camera e a maggioranza di due terzi del Senato. Storicamente, questo non è mai avvenuto.
Il primo tentativo lo fecero i repubblicani, gli eredi di Lincoln, quando nel 1868 tentarono di destituire Andrew Johnson, diventato presidente dopo l’assassinio del suo predecessore. Johnson era un uomo del Sud, anche se aveva combattuto per l’Unione, e rifiutava l’idea stessa di dare agli schiavi appena liberati terre e diritti di voto. I repubblicani radicali avevano una larga maggioranza in entrambe le camere ma fallirono nel tentativo.
Ci sarebbero poi stati ottimi motivi per procedere con l’impeachment di Lyndon Johnson, che usò un incidente mai avvenuto nelle acque del Golfo del Tonchino per trascinare gli Stati Uniti in una guerra mai dichiarata in Vietnam, o per farlo nei confronti di Richard Nixon, che invase segretamente la Cambogia, ma il Congresso non ci pensò neppure: il motivo per cui procedette contro Nixon fu il solo spionaggio contro i democratici: illegale ma neppure lontanamente paragonabile a una guerra che aveva causato la morte di 58.000 giovani americani e due milioni di vietnamiti.
Come si sa, l’isteria dei repubblicani attorno al caso Clinton-Lewinski, le scappatelle del presidente democratico con la stagista, furono occasione per un terzo procedimento di impeachment nel 1998 ma al Senato la mozione contro Clinton non ebbe che 50 voti, lontanissima dai 67 necessari.
Questa premessa era necessaria per capire che i democratici, in minoranza in entrambe le Camere, non hanno la più vaga possibilità di condurre in porto la rimozione di Trump per i suoi legami, veri o presunti, con Putin: l’interesse dei repubblicani a mantenere il controllo della Casa bianca è semplicemente troppo forte. I repubblicani sono un partito non solo assetato di potere ma disposto a tutto per cancellare anche il ricordo degli otto anni di Obama: per attuare anche solo parzialmente il loro programma hanno bisogno di Trump quanto questi ha bisogno di loro. Certo, l’alleanza dei media con settori dei servizi segreti garantisce fuochi artificiali sulle prime pagine, ma forse sarebbe il momento di chiedersi se le chiacchiere sui complotti russi non oscurino notizie ben più gravi, come le deportazioni di massa di immigrati, compresi molti che vivevano negli Stati Uniti da decenni e bambini nati sul suolo americano da genitori stranieri.
I democratici si inebriano di uno storytelling in cui hanno perso le elezioni perché il nemico storico complottava nell’ombra, ma non è così: hanno perso perché una gran parte della classe media impoverita e della classe operaia minacciata dalla globalizzazione ha preferito Trump. Hanno perso perché avevano in Hillary Clinton un pessimo candidato e perché il bilancio degli anni di Obama non è così entusiasmante come vorrebbero far credere. Le chiacchiere su un impeachment impossibile servono solo a cancellare la riflessione sulle loro responsabilità e su cosa dovrebbe fare un partito che volesse difendere gli interessi dei più deboli.