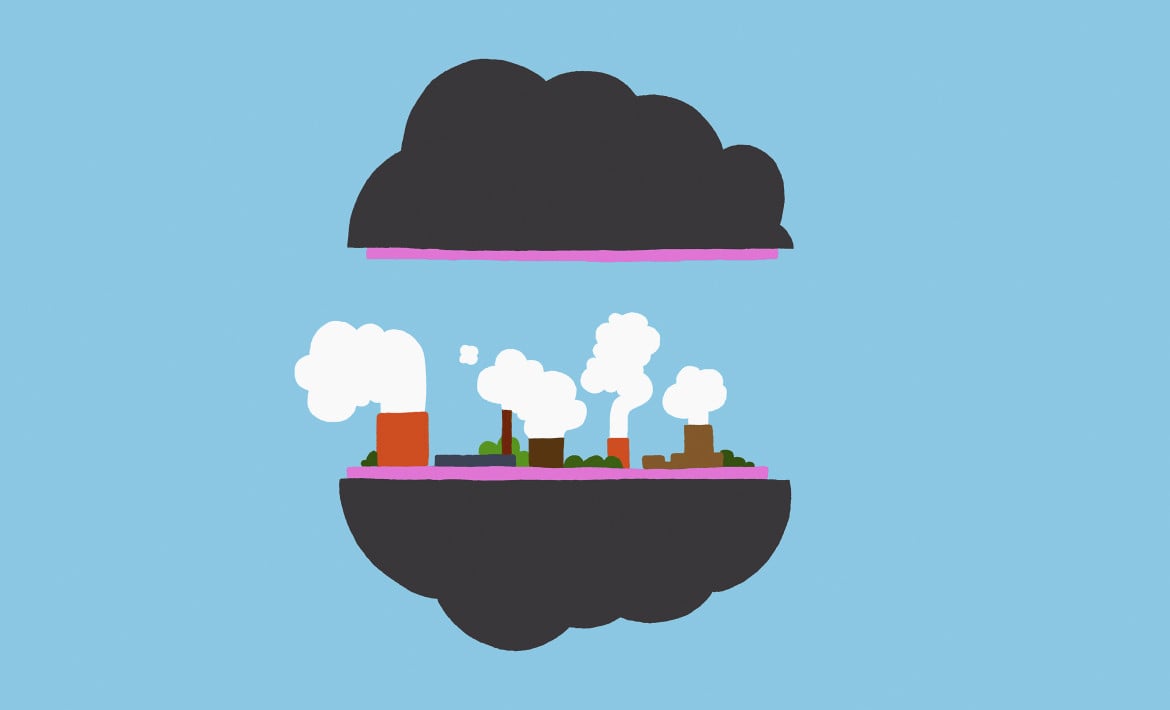L’ultima legge di bilancio della legislatura è stata approvata ieri prima dei selfie che i senatori si sono scattati per immortalare la loro ultima comparsata. Si tratta di una manovra arlecchino composta da mille sfumature di mance e bonus, una quantità record (185) dovuta al fatto che al provvedimento è stato fatto ingurgitare la legge di bilancio, il decreto fiscale e persino il Milleproroghe, assalto alla diligenza di fine anno.
ESPERIMENTO legislativo dovuto alla fretta di sciogliere le Camere e dare fuoco alle polveri (bagnate) della campagna elettorale più indecisa degli ultimi tempi. Per motivi squisitamente elettorali, l’arlecchinata di fine anno, senza capo né coda, ha perso i connotati «snelli» attribuitigli avventurosamente dalla coppia Gentiloni-Padoan al più tardi due mesi fa.
POCHE SETTIMANE sono bastate per fare esplodere gli iniziali 80 articoli a 120. L’ingegneria parlamentare ha poi concepito una costruzione di commi e sotto-commi che farà impallidire anche il più acrobatico e discutibile degli archi-star: 1247 in totale. Ciascuno dei quali ha gonfiato la strana creatura da 20 a 27,8 miliardi , 15 dei quali per sterilizzare l’aumento dell’Iva. L’unica cosa che, probabilmente, riuscirà a fare il prossimo governo sarà quella di dovere trovare 19 miliardi per bloccare un aumento che tutti gli esecutivi si trascinano dai giorni foschi dell’ultimo governo Berlusconi. In pratica, la legge di bilancio serve a rimediare a questo antico guaio. Tutto il resto sono pezze a colori. Con investimenti pari a solo 5,5 miliardi e uno sconto di fine stagione alle imprese del 50% per ogni assunto con il Jobs Act. Una misura che ha dimostrato la sua inutilità in tempi in cui i contratti a termine e il lavoro precario battono ogni record.
A SONDAGGI CALANTI, nella disperazione delle ultime ore, la manovra è stata la scena sulla quale si è consumato il tentativo in extremis del Pd di recuperare l’ultima ombra di «sinistra» che resta al suo centrismo liberista. Si è così provato a modificare una parte del Jobs Act: i contratti a termine ai quali l’ingiustamente dimenticata «riforma» Poletti ha cancellato la «causalità», ovvero il motivo per cui si accende un contratto che in media oggi dura tre mesi. E’ stato un tentativo modesto di ridurre la durata da 36 mesi a 24, intaccando il numero dei rinnovi (da 5 a 3). Senza ripristinare la causale avrebbe avuto l’esito paradossale di moltiplicare i contratti precari in un tempo minore. L’emendamento è decaduto: il governo non ha accettato di proseguire nel pasticcio. Dalle parti di Renzi si crede che il Jobs Act vada bene com’è, altro argomento per la ricca letteratura sulla capacità del «renzismo» di auto-distruggersi. In sé, non una cattiva notizia in uno scenario politico ristretto. Fallito anche il tentativo di aumentare le indennità in caso di licenziamento da 4 a 8 mesi.
WEB TAX. Sul fronte si è molto combattuto, anche qui inutilmente. Sembrava fosse la bandierina da piantare sull’Everest del capitalismo digitale. Ne aveva iniziato a parlare Padoan in un G7 a Bari. L’Italia l’avrebbe adottata anche senza una norma quadro in Europa. Una tassa simbolica che si è trasformata in un boomerang. Sembra infatti che quella approvata danneggerà le aziende italiane e non risolverà il problema con gli unicorni della Silicon Valley: Google & co. «La web tax si è ridotta a un condono – – ha detto Massimo Mucchetti (Pd), presidente della Commissione Industria e promotore dell’iniziativa – e nemmeno usato dalle multinazionali digitali».
MOLTO FIATO è stato speso, infine, per un altro provvedimento «simbolo» del paternalismo: il reddito di inclusione (Rei) finanziato per un paio di miliardi (ne servirebbero 7 all’anno). Si tratta di una misura non universale, selettiva, condizionata all’obbligo di accettare un’attività. La legislatura lascia un’eredità minacciosa: questo è lo strumento per il controllo dei poveri e la produzione di lavoro povero. «L’Italia merita fiducia» ha detto il premier Gentiloni. Ma soprattutto ha bisogno di molto coraggio.