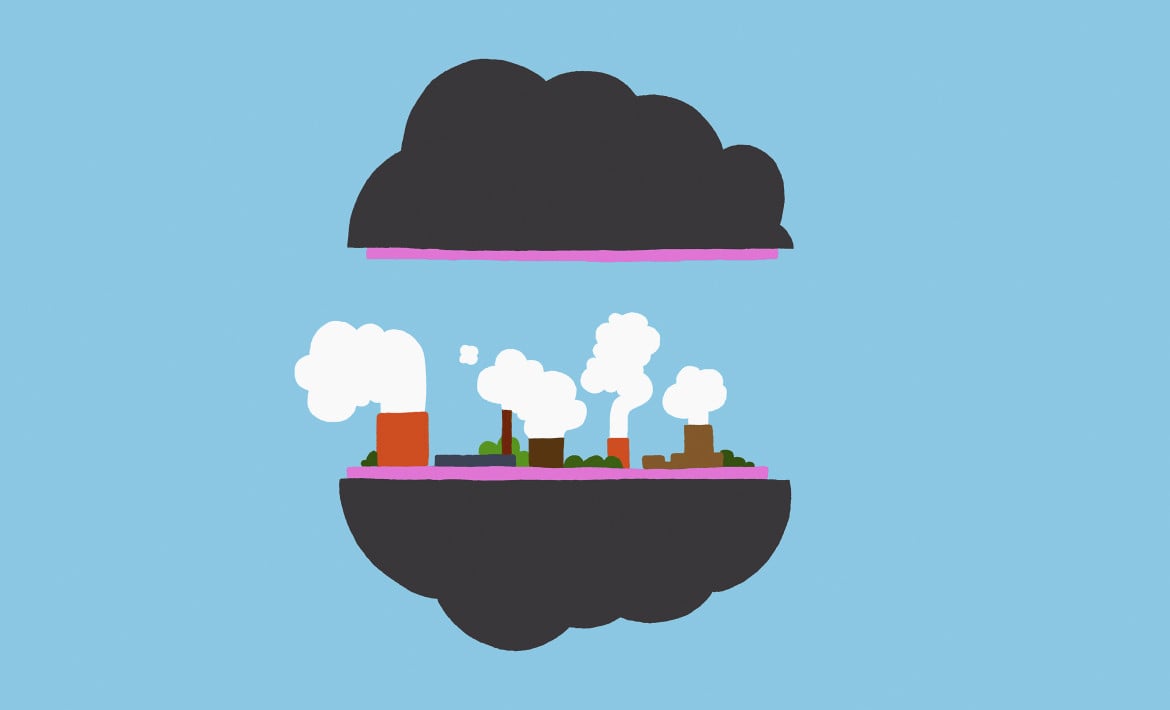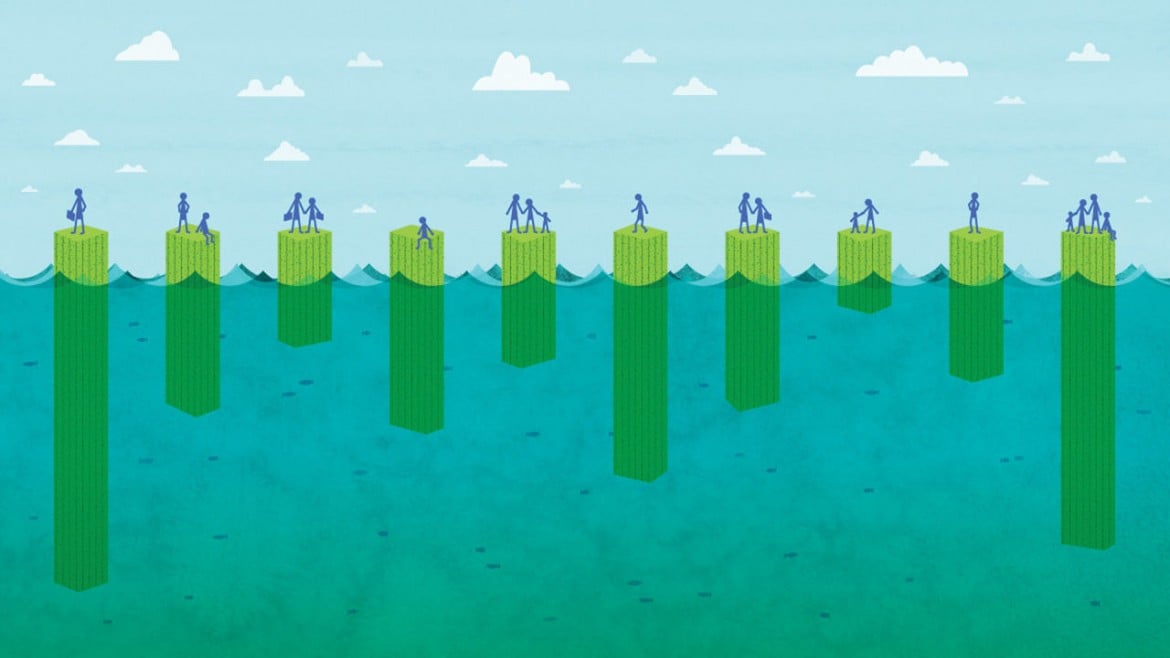Il reddito di base, incondizionato, individuale e universale è la proposta politica del futuro. È la tesi del Manifesto per il reddito di base rilanciata da Federico Chicchi e Emanuele Leonardi in un testo breve ed efficace (Laterza, pp. 64, euro 7, con una postfazione di Marta e Simone Fana).
Per reddito di base si intende un trasferimento monetario finanziato per via fiscale, erogato a tutti i residenti indipendentemente dall’identità nazionale, volto ad assicurare un’esistenza autonoma e degna. Il reddito di base non evoca un’istanza trascendentale (il «popolo»), una forma partito («oltre la destra e la sinistra», «etno-nazionalista», populista o para-fascista), né consegna gli esseri umani al sogno del capitalismo digitale della Silicon Valley, denaro gratis per consumare sulle piattaforme in cambio della rinuncia al potere di decisione sulla propria vita e sulla società.
Chicchi e Leonardi propongono un’idea conflittuale di reddito di base attraverso la quale elaborano una strategia che articola una riforma universalistica del Welfare, complementare e non sostitutiva dello stato sociale esistente, capace inoltre di far convergere la miriade di lotte anti-capitalistiche esistenti. Va evidenziato il contenuto anti-razzista della proposta: il reddito di base sfida il sovranismo dilagante e prospetta una ricomposizione politica e sociale non solo tra i cittadini (precari) nazionali, ma anche con i residenti stranieri, indipendentemente dallo scambio tra prestazione e salario, tra lavoro e permesso di soggiorno.
Il riconoscimento dell’autonomia individuale e collettiva è la premessa per abbattere le divisioni sociali, sessuali e di «cittadinanza» del lavoro in cui sono imprigionate le donne. Questo è il motivo per cui, come ricordano gli autori, il movimento femminista «Non una di meno» parla di reddito di autodeterminazione.
È un programma decisivo per respingere i vincoli di una vita consegnata integralmente al mercato (senza un lavoro non sei una persona); gli effetti devastanti prodotti dalla sovrapposizione tra il lavoro produttivo e riproduttivo (si lavora 24 ore su 24 e tutte le relazioni dipendono dalla prestazione); le gerarchie sociali nazionali e patriarcali (una donna immigrata dipende dalla donna per cui lavora, dal marito, dalla famiglia, dal permesso di soggiorno). Soggettività vulnerabili, schiacciate dai ricatti, anche sessuali, che possono trovare nel «reddito di autodeterminazione» uno spazio politico.
La ricchezza di questa prospettiva non è paragonabile a quella pauperista, filantropica o compassionevole di chi confonde il reddito con una politica pubblica di contrasto alla povertà. Né a quell’imbroglio linguistico del «reddito di cittadinanza» del Movimento 5 Stelle che è, in realtà, un «reddito minimo» condizionato al lavoro povero che non emancipa dal bisogno, ma obbliga all’attività coatta necessaria per rispettare le compatibilità economiche imposte dalla tecnocrazia europea che, a parole, si vuole contrastare.
Reddito di base è una politica pluralistica e multi-dimensionale. Va insieme con il salario minimo; una riforma fiscale fortemente progressiva e sovranazionale; una riforma politica delle istituzioni nel senso dell’autogoverno e non della governance neoliberista; una redistribuzione della ricchezza sociale dalle élites finanziarie alle masse proletarizzate; un patto politico che sposti le leve della decisione sulla produzione verso comunità estese e autogestite e superi la «sindrome produttivista» che ha imposto lo scambio sciagurato tra la sicurezza sociale e lo sviluppo economico basato sulla quantità e la devastazione della natura.
Chicchi e Leonardi propongono anche una pragmatica fase di transizione basata su un «reddito di base inizialmente selettivo» e una distribuzione incondizionata ai poveri «assoluti e relativi»: in totale 14 milioni di persone in Italia. Costo 23 miliardi di euro all’anno fissi, secondo i calcoli dell’economista Andrea Fumagalli. Da erogare fino all’uscita dalla povertà, non fino a quando il soggetto avrà trovato un lavoro miserabile che finisce nel giro di tre mesi. Troppo? No, questo è solo l’inizio, se pensiamo soltanto che in Italia gli sgravi del Jobs Act alle imprese sono costati 18 miliardi in tre anni, il bonus degli 80 euro 9 miliardi all’anno, il salvataggio delle banche 20 miliardi.
Al di là dei calcoli va stabilito finalmente che il reddito di base non è assistenza, ma il riconoscimento della produzione di cui siamo protagonisti al di là dell’impiego precario e dell’occupazione statisticamente rilevata. Il suo obiettivo è ambizioso, considerata la difficile situazione in cui ci troviamo, ma è decisivo perché oggi il lavoro va considerato come un esercizio di libertà e auto-determinazione. Conta più il diritto all’esistenza, poi alla scelta del lavoro, e non certo il diritto al lavoro qualunque sia. Il reddito di base e senza condizioni è la premessa della libertà politica.