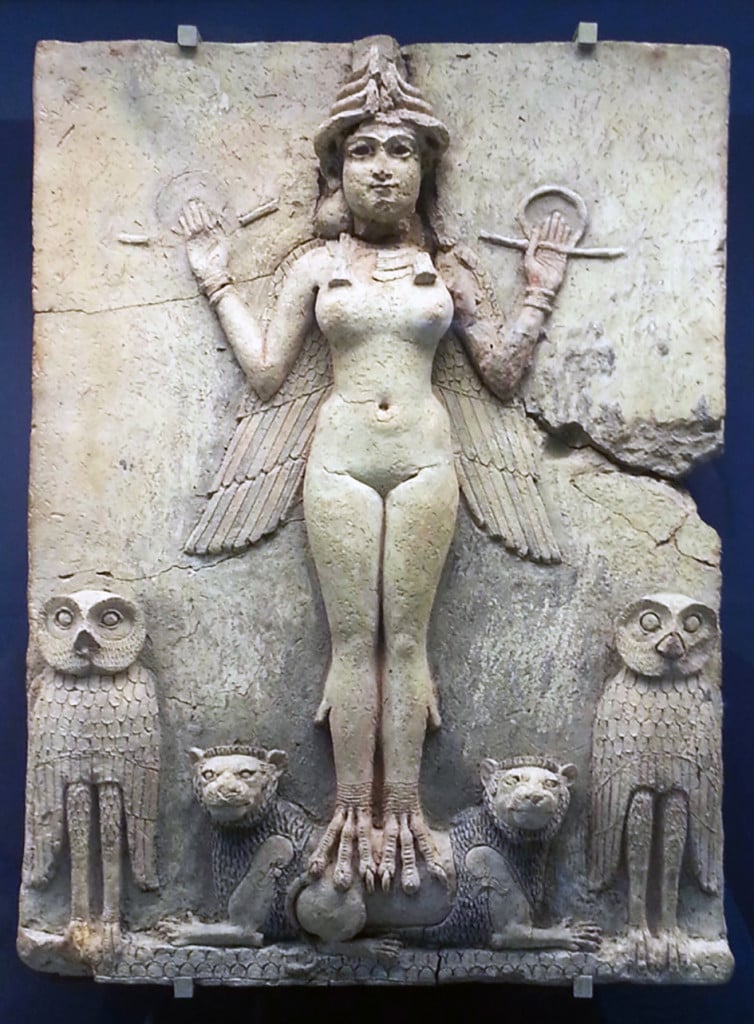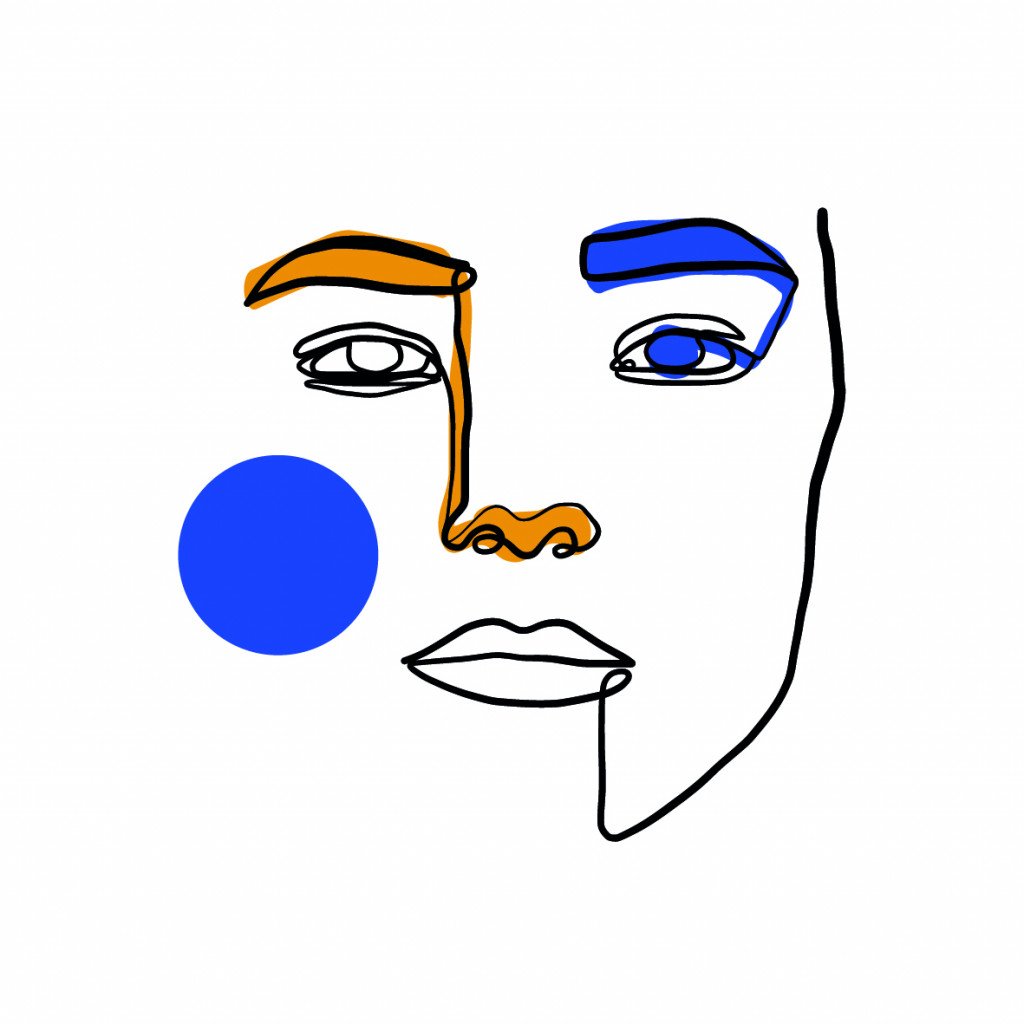Pubblicato 4 anni fa
Doveva essere una primavera bellissima. Per il mese di marzo avevo concordato un mese di visiting alla School of Slavonic and East European Studies (SSEES) dell’University College a Londra. Con il collega Jakub Benes, docente di storia dell’Europa orientale, specialista di storia del brigantaggio nei territori ex asburgici dopo il 1918, e la lettrice di sloveno Maja Rancigaj, sua moglie, avevamo definito il tema e il titolo della mia conferenza che avrei tenuto a fine mese: Da Slovenka a Ženski svet, il femminismo sloveno a Trieste tra cosmopolitismo e lotta nazionale, 1897-1928. Per il resto avrei lavorato nelle biblioteche e...