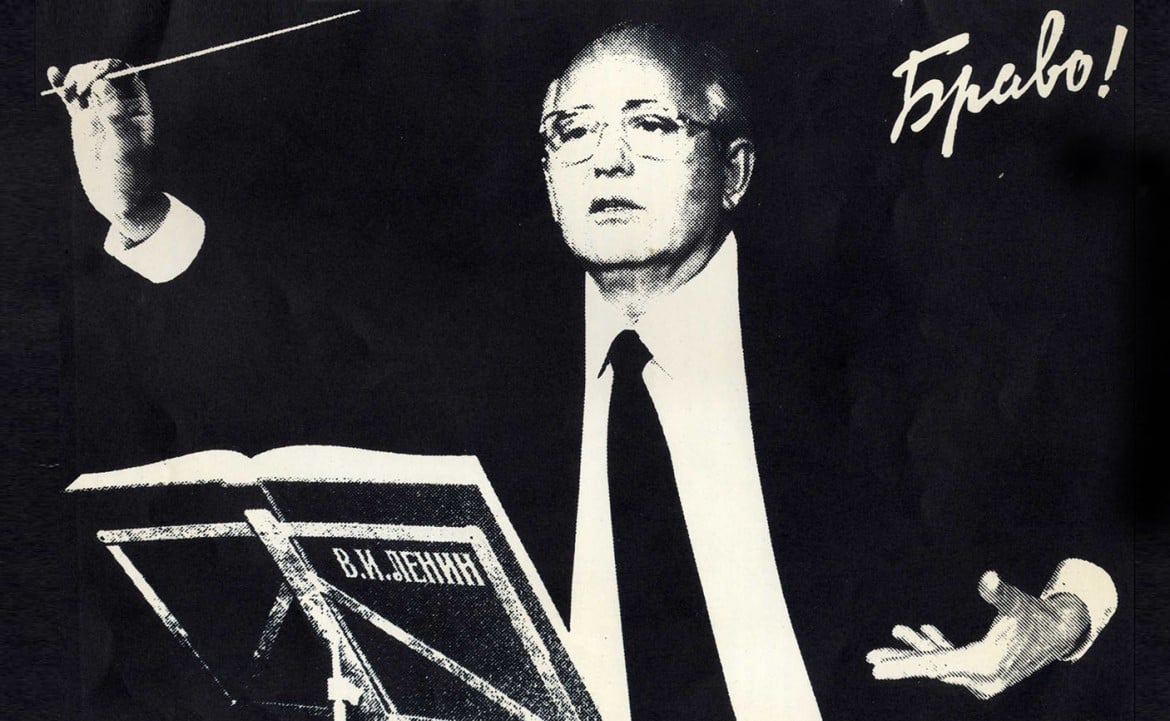Inquieto ma ironico, sottile nell’analisi ma anche sferzante nei giudizi, sempre allergico alle semplificazioni e alla demagogia, capace di leggere i mutamenti della politica senza mai cedere alle seduzioni del conformismo.
Per quelli della mia generazione Valentino Parlato era l’educatore al confronto libero e colto con quell’intellighenzia politica ed economica che forgiava e legittimava un’idea di Italia e un’idea di mondo: quelle idee dominanti che andavano conosciute, interpretate, demistificate.
Ci aiutava ad uscire dal tunnel delle rappresentazioni mitologiche e da una certa retorica sociologica per andare al cuore del problema: che era (che è) la questione dell’egemonia del capitalismo. Di un capitalismo capace di risorgere continuamente dalle proprie stesse ceneri e di trasformare le proprie crisi (una «crisi organica» direbbe Antonio Gramsci) in occasione di rifondazione della propria narrazione e del proprio dominio.
Anche quelli che, come me, non sono mai usciti dal Partito Comunista, soprattutto i più giovani, avevano con il manifesto un rapporto direi esistenziale, quel foglio era come l’oggetto del nostro desiderio, il luogo dove la parola comunista si sostanziava dell’intelligenza della complessità ma anche della genialità lucida e tranchant della semplicità di chi non smarrisce il sentimento di essere parte.
La parte del torto, appunto. Di chi si oppone alla deriva del conformismo (anche del conformismo di sinistra). E poi quel foglio aveva il carisma dell’eresia, cioè di una programmatica attitudine all’insofferenza verso il potere e verso le sue ortodossie. Ed era una scuola autentica di giornalismo, la perfetta negazione del bollettino settario.
Dei grandi vecchi – i padri e le madri della fondazione de Il manifesto – Valentino è stato quello con cui più spesso ero in dissenso, anche se mi spiazzava davvero la finezza politologica con cui descriveva le cose e le persone della vita pubblica.
Ho viaggiato con lui fino in Libia, ospiti di una Conferenza panafricana. Era curioso di tutto, del discorso fluviale di un Gheddafi ancora ben in sella, della sua Tripoli con quel lungomare così simile a quello di Bari, con le sue caffetterie e botteghe pullulanti di popolo. Ed era facile perdersi in quella città così fascinosa ascoltando aneddoti e racconti che mescolavano, con la voce suadente e musicale di Valentino, grande storia e piccole storie di umanità.
Con me era ovviamente il racconto della sua esperienza di dirigente del Pci pugliese, a fianco di un altro comunista speciale come fu Alfredo Reichlin: in un pezzo di sud in cui fu davvero ricca e vitale la relazione tra braccianti e intellettuali e in cui la «questione meridionale» poteva essere letta non come il «ritardo» o la «arretratezza» da correggere.
L’ho visto per l’ultima volta al convegno su Gramsci ed ero davvero felice per la sua iscrizione a Sinistra Italiana. Per quell’uomo renitente alla disciplina di partito era un gesto forte, carico della coscienza della sconfitta epocale di una grande speranza di trasformazione sociale: ma anche una dichiarazione esplicita di indisponibilità alla resa.
Forse questo mi piaceva di più di Valentino Parlato: sapere di essere vinti, ma non dargliela vinta.