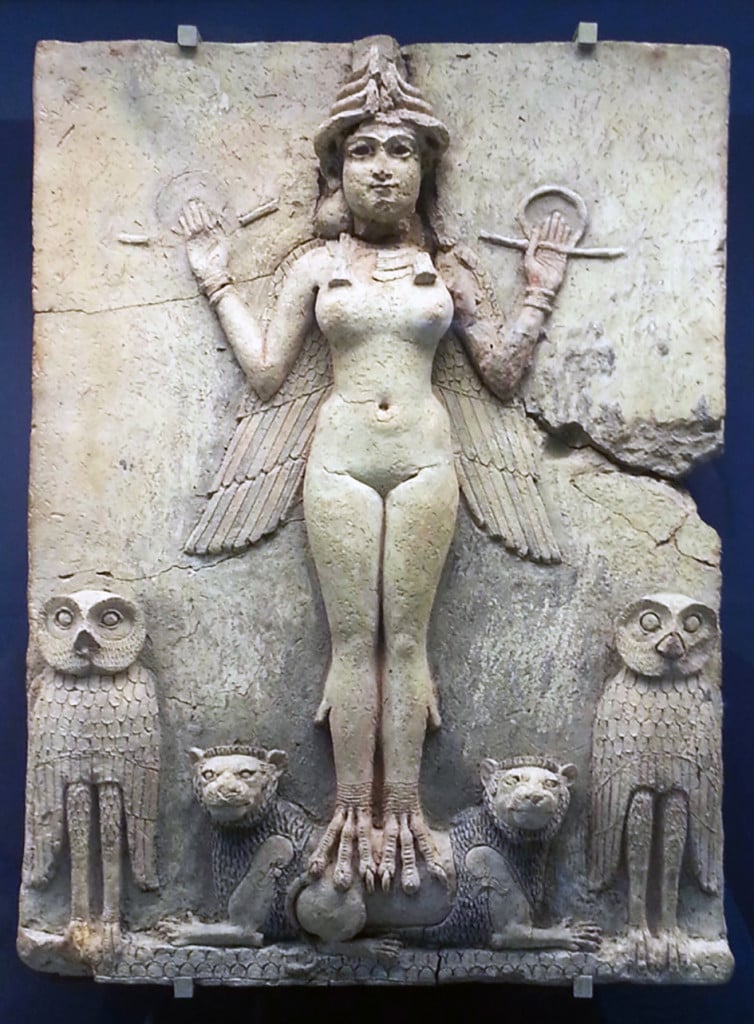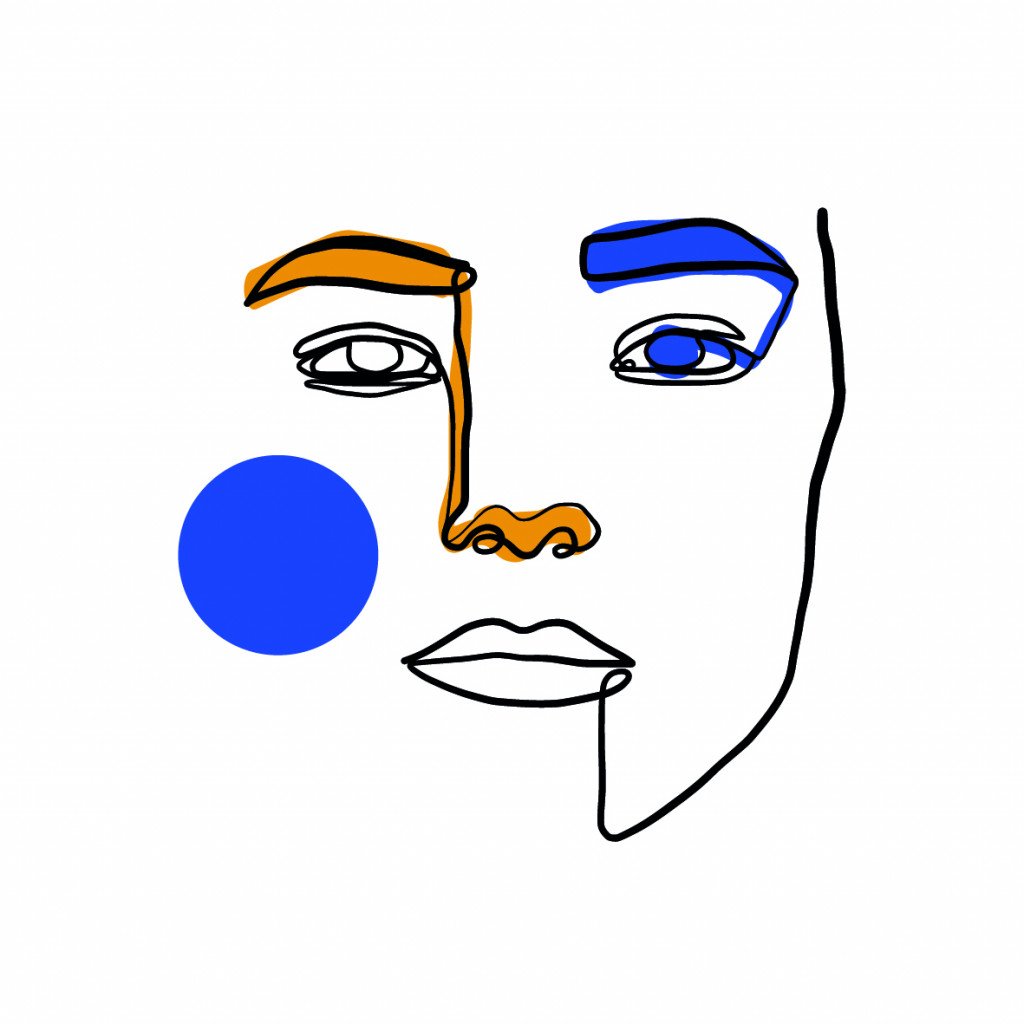Quando una ha quasi 91 anni ( che sono molti di più di 90 perché sei arrivato fra quelli impegnati a passare lo Stige ) la morte la vedi diversamente. Intanto con meno preoccupazione, perché sai che tanto, in un modo o nell’altro, stai per provare l’esperienza, e che sia per Covid19 o per un ictus, è secondario. Pensi naturalmente ai figli e ai nipoti, ma poiché da quando è arrivato il virus è stato fatto di tutto per spiegare che i giovani erano quasi immuni, più che al decesso ti sei soffermata a pensare alla vita: come stanno vivendo l’epidemia; che mutamento ha indotto nel loro modo di stare al mondo; prevale la paura o, al contrario, si ritrova l’energia per ripensarsi e ripensare all’altro?
Poiché io sono ottimista (al limite della stupidtà, come gli amici non mancano di ricordarmi) ho pensato che, al di là delle sofferenze prodotte, virus Corona sarebbe stato salutare: dopo decenni di individualismo esasperato ognuno, finalmente, era costretto a riscoprire che da soli non si può sopravvivere, che tu non sei niente se non in rapporto con il fitto e articolato complesso di cui si compone la società. Non solo, l’amico Corona, con il suo lockdown, stava offrendo un’altra inedita opportunità: mischiare, come forse mai era accaduto prima, il lavoro produttivo con quello riproduttivo, nel senso che lo spazio ridotto delle nostre moderne case, entro cui si sono accavallati quelli e quelle dello smartwork con quelle (le stesse) adibite all’attenzione per bambini, vecchi, malati, e magari anche embrioni. Tutte cose sempre fatte, con la novità che quelli addetti alla produzione sono stati costretti ad accorgersi, come mai era accaduto prima d’ora, della centralità del lavoro di cura. Obbligati se non altro a vederlo, minuto per minuto, non più solo a trovarselo già fatto al ritorno a casa.
E a prendere atto della sua essenzialità.
Questa inedita esperienza potrebbe/dovrebbe indurre a ripensare assieme le «due specie» di lavoro, quello produttivo e quello riproduttivo, ad abbatterne la separazione (imposta dalle leggi del patriarcato), a concepire un solo lavoro: «quello che serve a vivere» (espressione usata in una recente interessante riflessione della Libreria delle Donne). Pensato così, il lavoro in sé potrebbe essere inteso diversamente, sì da aprire l’orizzonte per un superamento del lavoro alienato.
Possibile? Forse sì, anche se non facile: occorre comunque molta autocoscienza delle donne, e anche degli uomini.
Comunque intanto grazie Corona per averci aiutato a riflettere (ma il prezzo effettivamente è stato carissimo!).