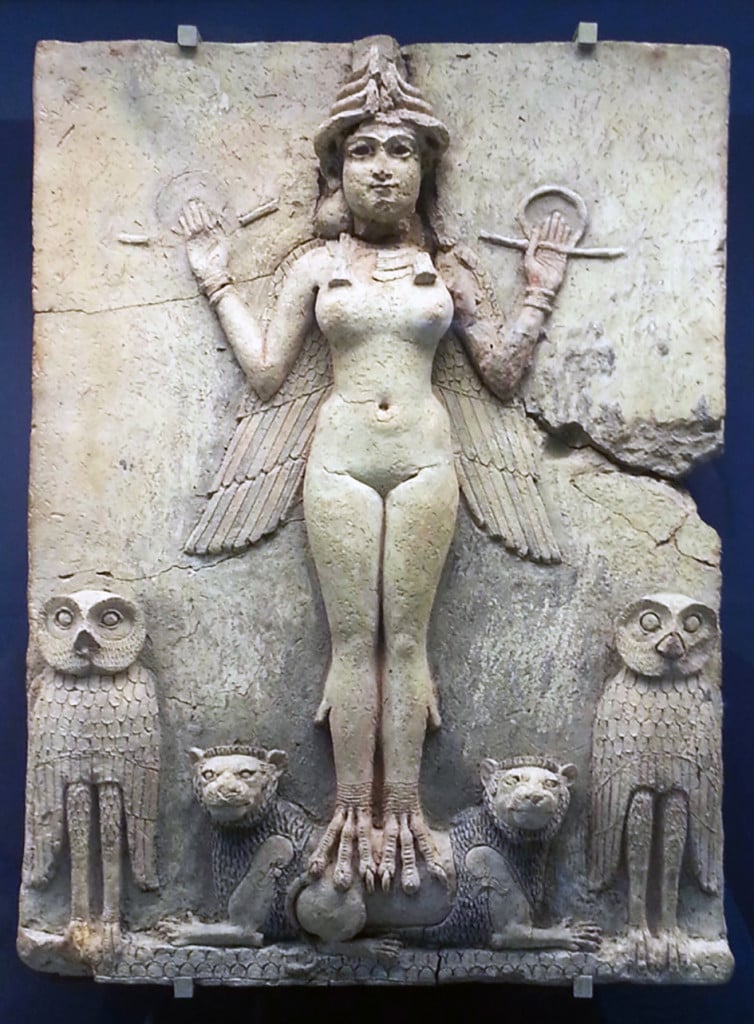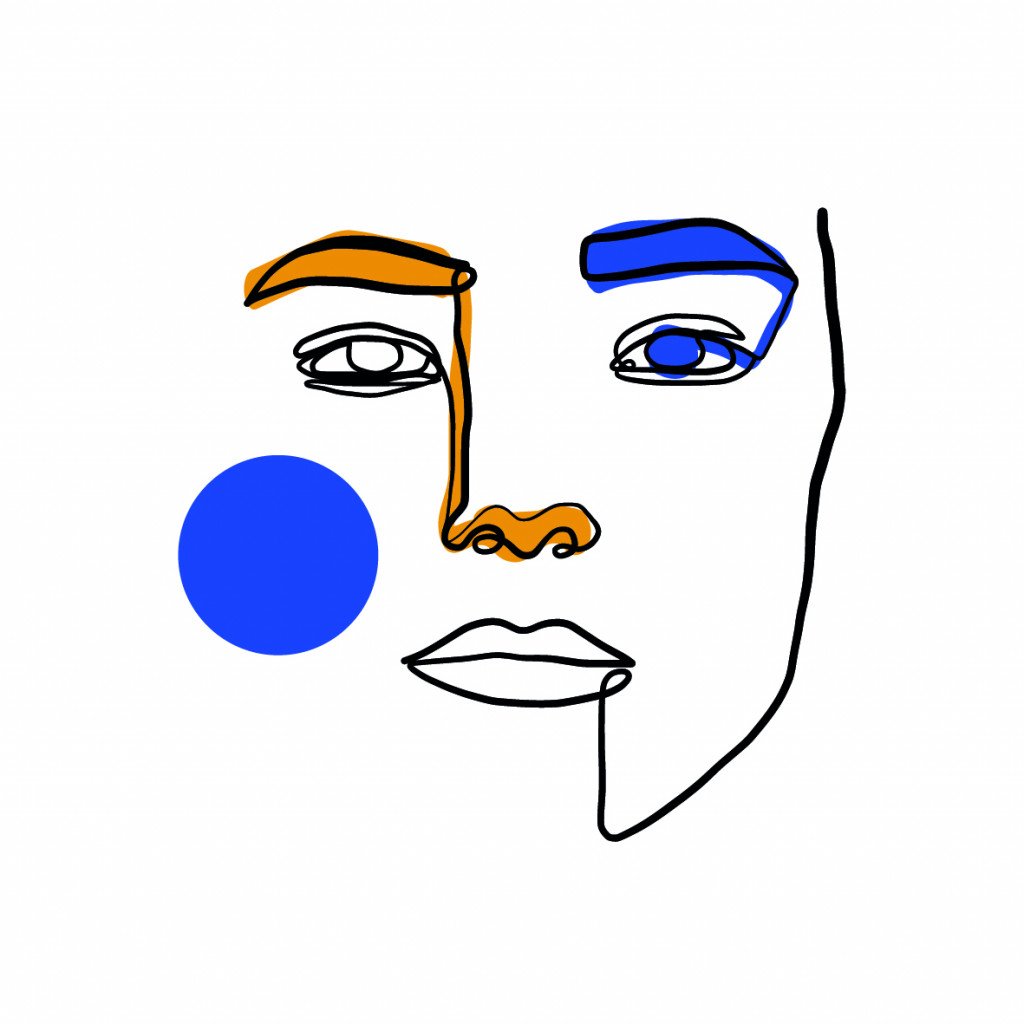Le prime misure di contenimento del contagio da coronavirus si sono temporalmente intrecciate, in Italia, con le iniziative di avvicinamento alle due giornate di mobilitazione e sciopero transfemminista globale dell’8 e 9 marzo attivando una proliferazione di pratiche simboliche e performative di sottrazione. Sull’onda delle sperimentazioni di lotte nella pandemia, si sono moltiplicate le iniziative di inchiesta online da parte di Non una di meno nazionale (con la campagna #iorestoacasama arricchita da quelle delle assemblee territoriali, ad esempio a Padova abbiamo lanciato i #raccontidallaquarantena) e da parte di altri soggetti che hanno provato ad approfondire e interrogare la situazione che tutte e tutti stiamo attraversando. Inchiesta e autoinchiesta femminista sono state sempre strumenti fondamentali per comprendere la realtà delle donne e delle soggettività dissidenti e per darci spunti per costruire intervento politico. A maggior ragione in una situazione di cambiamento così imprevista e profonda l’analisi di cosa ci sta succedendo è stata percepita come un’urgenza irrinunciabile, da realizzare attraverso la raccolta di dati e autonarrazioni. E proprio nel rispondere ad alcune di queste sollecitazioni mi sono costretta a soffermarmi su qual è, in questo momento, la condizione lavorativa mia e di chi mi sta intorno, delle mie reti di supporto.
Con la fine del dottorato e pure della Dis-coll ho dovuto fare i conti con l’incertezza di entrate che arrivassero dal mondo accademico e quindi, senza averlo mai neppure ipotizzato prima, qualche mese fa mi sono ritrovata ad aprire una partita IVA. L’entrata nel mondo del lavoro autonomo è stata solo in parte spaesante: la necessità di doversi autoimporre orari, ritmi, ferie, di incastrare tutti gli altri impegni, di imparare il minimo indispensabile di contabilità e sistemi di fatturazione è stato tutto lavoro che, se suddiviso in singole attività, sarebbe spettato ad altre figure professionali, ma che da lavoratrice autonoma al minimo, devi fare perché non diventino servizi esterni, da pagare. Per la verità, anni di precarietà mi hanno allenata a quel carico mentale fatto di to-do-list in continuo aggiornamento, bigliettini-calendari, scadenze da rispettare, conti da far quadrare… L’ho vissuta quasi come una transizione lineare, il passaggio da «precaria» ad «autonoma» mi è scorso sotto uno sguardo distratto, dandomi conferma incarnata di quello che in anni di mobilitazioni contro la precarietà abbiamo sostenuto. Solo quando mi sono trovata dentro la convivenza lavorativa forzata con chi era abituato a scandire i propri tempi nel passaggio da dentro a fuori un ufficio, hanno cominciato a palesarsi tutti quegli elementi che su di me, nel corso degli anni, avevo normalizzato. L’evidenza, ad esempio, di quanto il lavoro autonomo ricalchi in pieno tutte quelle caratteristiche del lavoro di riproduzione di cui tanto parliamo. Soprattutto nel suo essere lavoro a progetto, in cui ciò che conta è che tu consegni la ricerca entro il tal giorno, oppure abbia preparato la cena. Poco importa quando lo fai, qual è il processo attraverso cui lo realizzi o a quali risorse attingi per riuscirci, ciò che davvero conta è che il risultato sia consono alle aspettative. Certo, i tentativi di controllare anche il processo non mancano, ci sono manuali e scadenze intermedie, oppure visite di controllo e suggerimenti di esperti caldamente consigliati, ma tutto sommato sta a te stabilire come riuscire a portare a casa il fatto che il bambino sia sano e il report sia completo.
Una delle attività a partita IVA terminate poco prima del blocco da pandemia mi ha portato ad approfondire il tema dello smart working e la sua applicazione in Italia dove, non a caso, è stato introdotto normativamente con la definizione di «lavoro agile» qualche anno fa per poi diffondersi oggi come corollario del confinamento da pandemia. Ciò che vedo nelle persone accanto a me che stanno sperimentando questo smart working da covid ha poco a che fare con la sua ideazione – peraltro tutta in seno al capitale e non certo risultato di lotte o strumento a vantaggio dei lavoratori e delle lavoratrici – pensata come riorganizzazione del lavoro in cui dare priorità agli obiettivi piuttosto che all’orario. Addirittura, i modelli di smart working dei grandi gruppi industriali parlano di ristrutturazioni di locali per favorire gli scambi tra lavoratori, di allestimenti di spazi verdi e caffetterie ecosostenibili per alleggerire il carico di stress e migliorare la produttività. No, davvero non c’entra niente con quello che mi sta accadendo intorno. È lo smart working all’italiana, fatto di telelavoro dilatato senza più limiti d’orario e con molto più controllo, da cui è difficilissimo difendersi soprattutto per chi attribuiva luoghi diversi ad attività diverse. Nelle settimane in cui «casa» è il luogo di ogni attività, neanche il cambio di setting aiuta a riconoscere che rispondere a una mail di lavoro il sabato sera alle dieci sia uno sfruttamento inaccettabile. Una cosa che da fuori sede, dottoranda, ricercatrice precaria e lavoratrice autonoma ho sperimentato per anni utilizzando le pause dal lavoro produttivo per andare nell’altra stanza a fare una lavatrice o a lavare i piatti (e sono consapevole che parlo da una posizione privilegiata visto che in questo momento non ho persone che dipendono da me).
Quello che sembra profilarsi, quindi, è che non siano più solo il lavoro precario e il lavoro autonomo a essere stati modellati attribuendo loro caratteristiche proprie del lavoro riproduttivo, il lavoro a progetto (ma non a termine) del prendersi cura. Oggi quelle stesse caratteristiche entrano nel cuore del lavoro produttivo dipendente attraverso lo smart working, approfittando dell’ondata pandemica per accelerare un processo di trasformazione del lavoro dipendente in lavoro autonomo controllato che, pur scaricando su lavoratrici e lavoratori rischi e responsabilità, pretende di controllarne e accelerarne i ritmi di lavoro. Siamo così dentro un paradosso per cui aziende metalmeccaniche eliminano il timbro al cartellino in uscita per evitare assembramenti mentre enti pubblici di ricerca pretendono di introdurre sempre più stringenti controlli sui tempi di lavoro svolto a casa (nonostante non sia previsto dai contratti). Come tutte sappiamo attraverso l’esperienza del lavoro riproduttivo, la dilatazione della giornata di lavoro ha molte implicazioni ed è legata a doppio filo ai rapporti di forza in gioco: ci parla di risorse a disposizione a cui non tutte e tutti possono accedere, di un impegno organizzativo che viene dato per dovuto e scontato, di una espropriazione del tempo a disposizione per sé e per le proprie relazioni. Non che prima non accadesse, ma negli ultimi tempi le riunioni telematiche si affastellano e le mail di lavoro arrivano a getto continuo. Non solo nei fine settimana (che peraltro in questo tempo ridefinito dalla clausura domestica so distinguere solo aprendo l’agenda), ma anche il 25 aprile e il primo maggio le notifiche hanno continuato a fare da colonna sonora delle giornate e quindi mi chiedo: chi può sottrarsi dal rispondere immediatamente alla mail arrivata dal capo di turno? Come possiamo dotarci di strumenti di resistenza collettiva? Io quasi non me ne accorgevo, abituata ormai a questo ritmo senza soluzione di continuità.
Con la chiusura delle scuole (uno degli altri lavori che stavo facendo pre covid erano laboratori scolastici), sono andata avanti settimane a «fare cose» per inerzia, non riuscivo a fermarmi e uscire dalla frenesia a cui ero assuefatta. Questo è solo un piccolo esempio ma qual è l’effetto a più ampio raggio del ritrovarsi in una dinamica così pervasiva di ogni ambito di vita senza aver costruito una lettura critica e condivisa di quanto sta avvenendo perché non sia (più) il capitale a dettarci i tempi?
La partecipazione ad alcune delle autoinchieste di questi giorni è stata decisiva per permettermi di far spazio nelle mie giornate alla riflessione su come sta cambiando per me il rapporto tra vita e lavoro e quindi mi chiedo: se attraverso le inchieste e autoinchieste in corso emergesse il riconoscimento non solo di come il lavoro riproduttivo sia il modello su cui si struttura il lavoro autonomo e precario, ma anche di come questo sia la forma (che prova a essere) assegnata anche ad ampi settori del lavoro dipendente, avremmo forse qualche strumento analitico pronto? Il lavoro di indagine e critica del lavoro riproduttivo e del lavoro precario e autonomo condotto nel corso degli ultimi anni dai movimenti transfemministi permetterebbe di trovarsi, una volta tanto, un passo avanti. Disvelando gli aspetti che ci accomunano nei processi attualmente in corso, come predisporre gli strumenti per la ricomposizione delle lotte?
Se da un lato questo può diventare una freccia in più all’arco del reddito di autodeterminazione che, a maggior ragione, si conferma strumento di liberazione delle possibilità di scelta, dall’altro non può che richiedere riflessioni più puntuali rispetto alle forme di reddito indiretto. Magari a partire dall’analisi critica femminista di quanto introdotto in molti settori negli ultimi anni come il welfare aziendale e altre integrazioni dei salari. Ad esempio, e anche in questo caso limitandomi a quanto posso osservare tra i miei contatti più vicini, chi è stato costretto a lavorare da casa non ha più diritto a che gli vengano corrisposti i buoni pasto, provocando così una perdita di svariate decine di euro in busta paga. Oppure penso a tutte le spese che una lavoratrice autonoma conosce bene e che adesso vengono scaricate sul lavoratore-dipendente-che-lavora-da-casa e che, come magistralmente esemplificato da qualcuno nei giorni scorsi, dovrà pagarsi pure l’aria condizionata (sempre ammesso che a casa sua ce l’abbia…).
E quindi, a distanza ormai di oltre due mesi dallo sciopero transnazionale dell’8 marzo, mentre gli effetti sociali delle settimane di confinamento iniziano a mostrarsi apertamente, può essere la sottrazione transfemminista dal lavoro riproduttivo uno strumento di ricomposizione anche con chi sta vivendo nell’ambito produttivo gli stessi modi di sfruttamento?
*
Bruna Mura, laureata in Politica internazionale e diplomazia presso l’Università degli Studi di Padova con una tesi sull’evoluzione dei consultori familiari, con un dottorato in Sociologia presso l’Università di Urbino-Carlo Bo con un progetto sul rapporto tra salute, welfare e partecipazione in una prospettiva di genere. Collabora con il Centro interdipartimentale di ricerca sugli studi di genere (Cirsg).