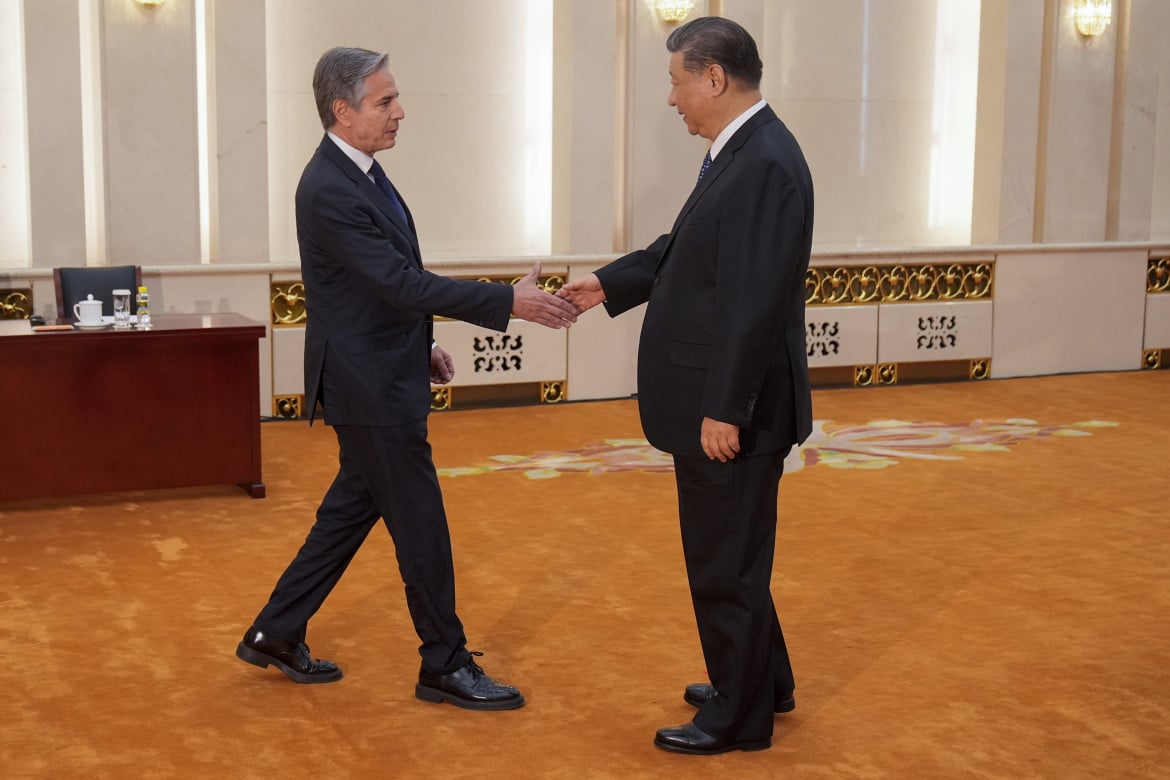Che Adam McKay sia uno dei registi statunitensi più interessanti in circolazione non siamo poi in tanti ad affermarlo. Fattosi conoscere per il suo lavoro nel Saturday Night Live e per essere il partner e regista di alcuni film più clamorosi ed esilaranti di Will Ferrell, straordinario attore ancora troppo poco apprezzato in Italia, con La grande scommessa McKay è riuscito nell’impresa di spiegare cosa c’era dietro la bolla dei mutui subprime senza sacrificare una sola oncia di cinema (l’altro film imperdibile sull’argomento è il documentario Inside Job di Charles Ferguson). Clamoroso regista di attori, McKay è uno che i suoi collaboratori li sceglie con cura.
DA SCENEGGIATORE, produttore e attore conosce perfettamente l’apporto creativo di ogni singolo reparto. Non a caso, il montaggio di Vice, come del precedente La grande scommessa, è curato da Hank Corwin, editor di fiducia di Terrence Malick, mentre la fotografia è curata da Greig Fraser, dop che ha al suo attivo sia Zero Dark Thirty che Rogue One: A Star Wars Story. McKay si presenta come un esempio di regista cinematografico che ha saputo assimilare le funzioni dello showrunner televisivo. Lavora con una troupe di attori fidati (Steve Carell, Christian Bale e altri) che quando non sono davanti alla macchina da presa, si ritrovano dietro le quinte in veste di produttori (in questo Brad Pitt e Will Ferrell). La cosa più sorprendente di questa biografia di Dick Cheney, l’uomo che ci ha regalato la guerra in Iraq fra le altre cose, è che Adam McKay, nel tempo che separa La grande scommessa da Vice, ha assimilato in profondità il principio di incertezza e indeterminazione che ha investito le rappresentazioni e le narrazioni della realtà dopo l’esondazione della post-verità nel mondo dei social media.
IL FILM è raccontato dal punto di vista di un narratore onnisciente che si presente inizialmente come una specie di «parente» di Cheney (Jesse Plemons). Le modalità attraverso le quali McKay utilizza la focalizzazione interna è da manuale: si passa dal discorso indiretto libero (Plemons è sia attore in alcuni teatri della sua storia che narratore), al monologo interiore di molti dei protagonisti (ma come fa il narratore a esserne a conoscenza?, è la post-verità baby..) e il flusso di coscienza cui contribuisce il montaggio di Corwin che intreccia veri materiali di repertorio, altri completamente ricostruiti, finti telegiornali e così via, amplificando a dismisura l’intuizione pionieristica di Robert Zemeckis e del suo Forrest Gump (la decostruzione di massa portata a livelli di virtuosismo puro). L’origine di questa crisi della narrazione e di conseguenza perdita di valore fattuale della verità, pienamente assunta dal film per riaffermare paradossalmente la necessità della verità stessa, basti osservare l’enfasi posta sull’interpretazione dei codici legali dalla quale Cheney fa scaturire il suo potere appoggiandosi sull’Unitary Executive Theory (in pratica, semplifichiamo, la possibilità di scavalcare la separazione dei poteri e concentrarli nelle mani di un solo potere decisionale), è incarnata da Nixon e dal Watergate, scena primaria della perdita dell’innocenza degli Stati uniti. McKay orchestra una vera e propria genealogia, controstoria del neoliberismo.
OGNI ATTO governativo (dalle leggi a favore delle banche all’obbligo di avere sempre un contraddittorio nell’informazione) è considerato come il tassello della marcia inarrestabile delle oligarchie del Gop che non hanno alcuna voglia di pagare le tasse e che devono trovare un modo per farle pagare agli altri inducendoli a votare per i loro rappresentanti che ovviamente non li rappresenteranno. McKay è un autentico virtuoso. Come avveniva nel precedente La grande scommessa, e nonostante si stia raccontando la storia segreta degli Stati uniti, ogni articolazione narrativa è sempre chiara e comprensibile. Nessun passaggio è tirato via o banalizzato e ogni affermazione è stata passata al vaglio del più severo fact checking. E, miracolosamente, il film possiede sia la densità politica dei migliori thriller politici di Frankenheimer e Pollack, che l’acido corrosivo del cosiddetto cinema demenziale di un Landis. McKay è come una triangolazione fra il meglio del cinema americano di oggi: gli anni Settanta, i primi Ottanta e la tv (dal SNL alle serie odierne). Vice è il film che ne rilancia ulteriormente le quotazioni collocandolo fra i grandi registi americani degli ultimi vent’anni. E occhio alla scena che interrompe i titoli di coda.