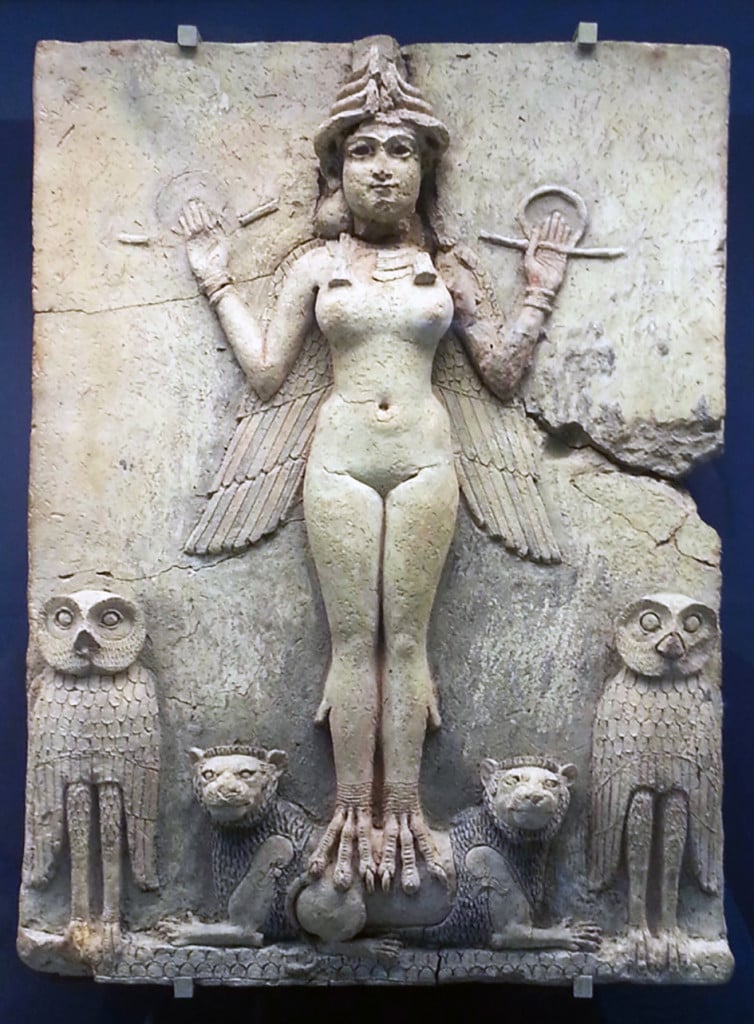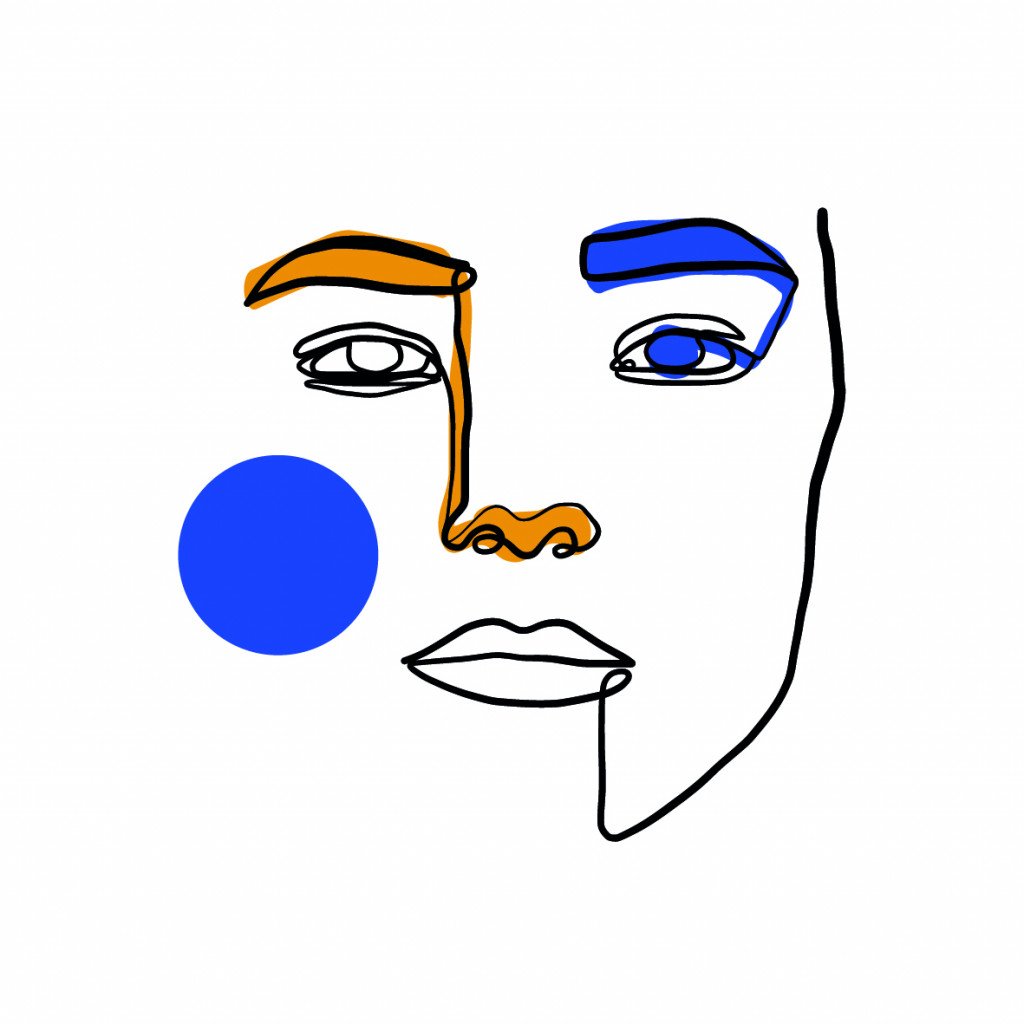Parafrasando il bel libro di Alberto Savinio dedicato a Milano, Ascolto il tuo cuore città, vorrei restituire a Milano, ai suoi cambiamenti, alle molte trame della sua pelle, il disegno di questa nuova cartografia che la pandemia sta generando.
La città degli eventi, la città evenemenziale nata intorno agli anni precedenti e successivi l’Expo 2015, la città che ha ridisegnato non solo il suo skyline, ma interi quartieri divenuti quartieri a tema, come sosteneva l’architetto Boeri, sta di nuovo cambiando fisionomia. Credo che Milano costituisca in Italia un caso particolare, è la città che ha più volte reiventato la sua configurazione urbana, ma anche la sua vocazione produttiva e dunque sociale. La città fabbrica di Romanzo popolare di Monicelli del 1974 e poi dei serial poliziotteschi degli anni Settanta che si svolgevano in Ticinese o nel quartiere di Lambrate, è divenuta poi la «Milano da bere» degli anni Ottanta; la città quaternaria degli anni Novanta (e, infine, centro finanziario) e dei settori di punta del design e della moda; la città-fiera attorno alla quale gravitava e in parte gravita ancora un indotto che oltre a comprendere il settore alberghiero, della ristorazione, del commercio al dettaglio moltiplica a cascata il suo influsso su settori connessi che vanno dall’industria culturale e artistica, alle università e via dicendo.
Questa città ora non è più la stessa. I quartieri del ritrovo, dell’aperitivo, la Darsena appena ristrutturata, il quartiere Isola con i suoi svettanti grattacieli, sono corpi vuoti in un tessuto metropolitano in cui si allargano le maglie urbane dell’assenza. Vuoti gli alberghi, vuoti i micro-appartamenti, gli airb&b, vuote le aree centrali e direzionali. La città è sospesa, forse un po’ indurita, inasprita, l’umorismo milanese, così particolare nel suo modo di porsi nel pieno delle trasformazioni, è perduto nell’angoscia.
Certo si cammina ancora lungo i Navigli, si sosta (quando è possibile) nei piccoli parchetti urbani tutti recintati, ma l’impressione è diversa. Come non pensare che la pelle di Milano è stata disegnata, e ha disegnato tutte le principali fasi della trasformazione politico-sociale e umana di questo paese dal dopoguerra in poi?
Alla Milano di Rocco e i suoi fratelli (1960), nel corso dei decenni si è sostituita una città pervasa dal cinismo violento e un po’ provinciale degli yuppies, che si inventavano scenari newyorkesi piuttosto improbabili come quelli dei cine-panettoni dei fratelli Vanzina. Forse solo il cinema d’autore e Gabriele Salvatores hanno saputo strappare una residua poesia dalle pieghe di Milano negli ultimi tempi.
La pelle di Milano con la pandemia tradisce l’usura di quanto accaduto negli ultimi decenni, il suo svuotamento culturale, la ricerca sfrenata del consumo, un produttivismo che ancora non cerca di ripensare e riconsiderare la questione del lavoro, dello sventagliamento delle professioni, dello smartworking, della precarietà, che, inevitabilmente, vede modificarsi l’uso dello spazio urbano, del suo territorio.
La nuova geografia di Milano disegna un presente schiacciato su un «non ancora», un non ancora che consuma interi quartieri svuotati dai propri riti, dalle proprie abitudini. Meglio resistono le periferie che non dipendono esclusivamente dalla città terziaria o quaternaria. I quartieri del lavoro precario, non riconosciuto, sotterraneo, riescono in un certo qual modo a mantenere la presenza di brandelli di tessuto sociale costituito da qualche luogo di ritrovo, da un modo di mantenere la comunità di quartiere; la circolazione dei mezzi è in queste zone meno rarefatta, perché a lavorare, a «lavorare in presenza», in quei territori si continua. Addetti alle pulizie, alla cura, anziani, gente un po’ perduta, si muovono lungo traiettorie rarefatte, perché se la solitudine già abitava la città ora si avverte in modo drammatico. Le realtà associative, di azione sul territorio, caritatevoli o altro pur essendo state presenti, soprattutto nella prima fase dell’epidemia, non riescono a coprire ora questa solitudine diffusa, a tratti rancorosa, a tratti disperata. La percezione che da quanto si sta sperimentando non si tornerà indietro la si può cogliere nell’esodo che Milano ha vissuto nella prima fase, quando studenti, precari, persone rimaste senza lavoro sono letteralmente fuggite. In molti poi non sono più rientrati e le motivazioni sono tante, il caro affitti unito a una flessibilizzazione del lavoro e della vita che se poteva funzionare nei periodi aurei ora non offre che briciole sparse, mette in evidenza forme e condizioni di esistenza polverizzate, che erano già gravate da una carenza di diritti, spesso minimi.
Chi resta e chi parte. Al desertificato centro storico, alle «cattedrali nel deserto» del terzo millennio nel quartiere Isola-Garibaldi corrisponde la resistenza a sacche del Ticinese, di Porta Romana ma, soprattutto, una sorta di riconversione in corso delle periferie storiche come il Lorenteggio, la Bovisasca, etc. Chi abita in questi luoghi, così come nella cintura dell’area metropolitana che continua ad avere il suo pendolarismo intenso, comprende come la significazione del lavoro, dell’essere presente nel «cuore dove si muove il capitale» sia stata completamente ribaltata; certo le élites non hanno traslocato, ma hanno mezzi e possibilità di spostamento e agio diversi.
Il ruolo trainante di Milano, che da sempre ha indicato anche una visione specifica di concepire e costruire la città, è in impasse. Le «coree» degli anni Cinquanta, le dilatazioni di quartieri satellite – che soprattutto lungo l’asse Monza-Brianza descrivevano l’addensarsi di realtà produttive, fabbriche, fabbrichette, logistica in un continuum teso a lambire la Svizzera e il Nord Europa –, ora mostrano l’altro lato della medaglia che non è solo la tristezza del paesaggio ma la malattia, l’inadeguatezza. Sono state proprio la densità urbana, unitamente all’inquinamento tra i più gravi in Europa, le unità produttive che non hanno mai smesso di operare, ad aggravare una crisi in una realtà che da tempo aveva imboccato la privatizzazione dei servizi, della sanità, della ricerca. Il collasso della medicina del territorio chiama in causa una filiera di scelte che vantando il primato di un’eccellenza che solo il privato poteva garantire, e deve ora affrontare la crudeltà di ciò che ci accade. Una crudeltà cinica che seleziona i vecchi, chi serve e chi non serve, che lascia ammalare gli operatori della sanità e i medici in un caos che non è certo un evento inatteso. Il fattore più importante, che la Milano evenemenziale non può più trascurare, riguarda così la riorganizzazione dei suoi quartieri, delle sue istituzioni, del suo patto civico.
È una città «arrabbiata», improvvisamente trascurata e umiliata, forse anche a causa del risentimento che da più parti si è sempre levato nei suoi confronti, quella che deve ritrovare un suo senso, una sua nuova vocazione. Non è tutto da rimpiangere ciò che è venuto meno, è forse uno svelamento che rende nette le contraddizioni e le possibilità. La solidarietà generosa, i luoghi d’incontro, gli spazi sociali, culturali, associativi non possono più restare rinchiusi nei loro ghetti o nei loro salotti, i quartieri devono progettare gli spazi di condivisione sociale, economica, culturale. Milano deve liberarsi di molti tristi slogan o immagini patinate e ha ancora la possibilità/occasione di ridare forza ai suoi «saperi», oggi necessari e che si sono fragilizzati.
Le culture innovative volte ad apprendere la condivisione e a rimetterla in rete devono ripartire dall’area metropolitana periferica e investire i quartieri gentrificati. Non penso a una città più smart, slogan che significa poco, ma a una città che riapre i suoi portoni nobiliari, offre i suoi giardini, a una città che abbatte le recinzioni che delimitano i quartieri popolari per creare le nuove piazze delle relazioni. Lungo le linee della circonvallazione, soprattutto della famigerata filovia 90-91, una linea di demarcazione ha sempre, in modo nemmeno troppo sotteso, definito la «città propria» dalla sua dilatata crescita periferica. Quartieri di edilizia popolare alcuni e residenziali altri, così anonimi spesso, senza possibilità di aggregazione, violenti nelle strutture, negli arredi così ripetitivi e anonimi. Decentrare Milano significa dunque uscire dalla logica dei quartieri a tema per sperimentare quartieri in cui l’abitare, la cura, la condivisione di progetti, di lavoro, dell’uso delle risorse urbane proceda attraverso la condivisione di un territorio che non deve limitarsi a precipitare nel cortocircuito della produzione-consumo, ma deve aprirsi a forme condivise di soddisfazione in cui creare sistemi di buona vita, ma anche di felicità nello scoprire che non si è solo un frammento di un ingranaggio che, se non serve più, può essere scartato. La Milano che in tutti questi anni è stata più silente è, forse, quella che nemmeno ora molla ma che opera attraverso le sue reti sul terreno di una generosità che appartiene anche questa alla sua storia, certo quella meno patinata e consumisticamente spendibile. Del resto Milano sta attraversando la stessa crisi che attanaglia grandi metropoli come New York, Londra, Parigi, città da cui si fugge perché si tratta di realtà ancora incapaci di offrire alternative ai meccanismi divoranti della mega-macchina urbana del consumo.