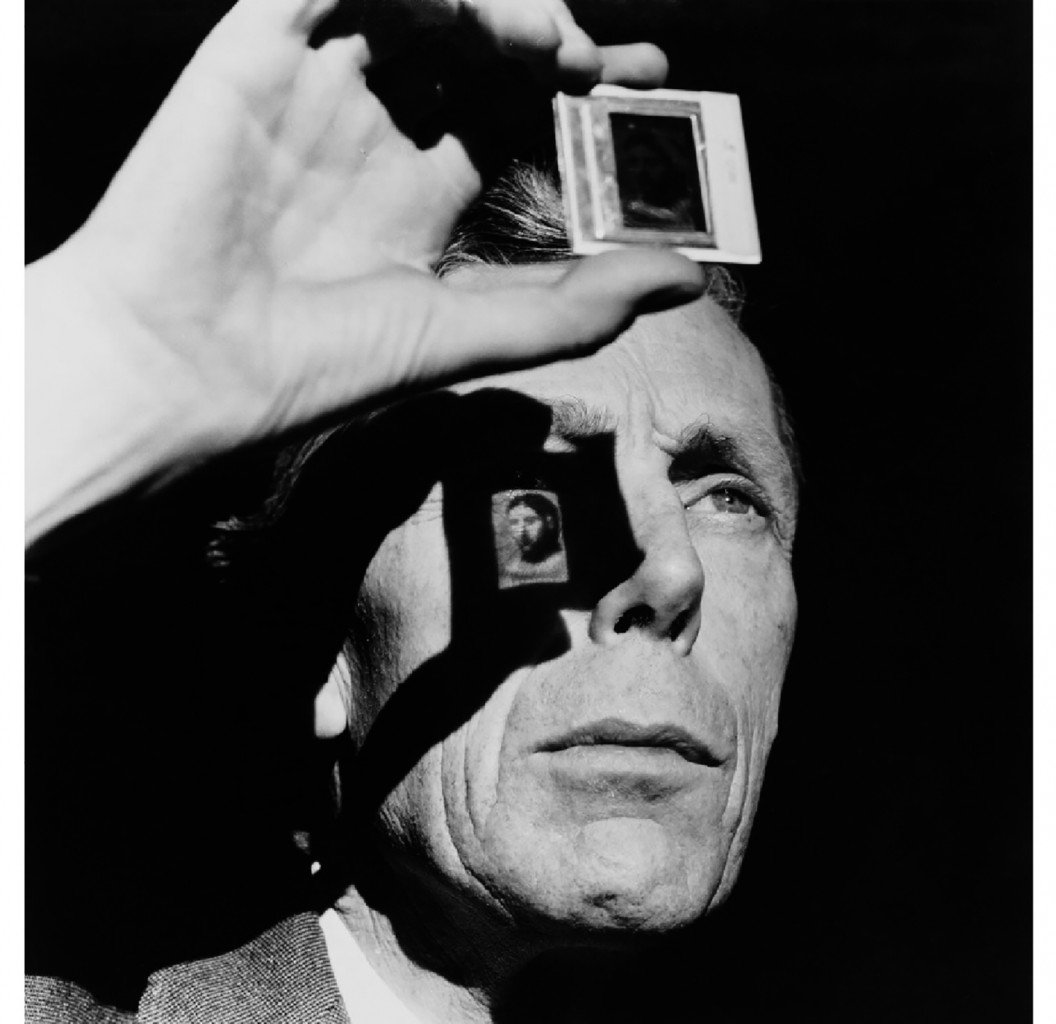
Ci sono storici dell’arte che stringono la loro vicenda di studiosi attorno a un unico artista, e anche se gli interessi si moltiplicano, tutto finisce poi per potersi ricondurre allo stesso centro nevralgico da cui si è partiti. Il caso di Anthony Blunt è sintomatico: Nicolas Poussin non è stato per lui solo il grande nome dimenticato da riabilitare agli onori della critica, ma un compagno di vita a cui ritornare periodicamente, da esplorare con lentezza e costanza, da riscoprire espandendo le incursioni, con riscontri sulle fonti o sui documenti, fino all’organizzazione di grandi mostre e ai tanti cataloghi, di collezioni o ragionati, di disegni o di dipinti.
Questi cinquant’anni di fedeltà originano dai suoi primi tentativi, apparsi perlopiù alla fine degli anni trenta nel «Journal of the Warburg Institute», quando Blunt ha trent’anni e alle spalle poco più di un’infanzia trascorsa in Francia, al seguito di un padre che è pastore all’Ambasciata britannica e di un fratello-pittore, e gli studi condotti al Marlborough College. Rispetto all’itinerario delle tante illustri firme che animano la rivista – Erwin Panofsky, Ernst Gombrich, Fritz Saxl, Edgard Wind – lui sembra guardare alla classicità con occhi meno sedotti dalla sopravvivenza degli antichi dèi pagani e meno segnati dalle durezze dell’esilio. Da subito sviluppa una predilezione per le posizioni teoriche degli artisti, da verificare anche quando il riscontro vira verso il polo negativo.
Proprio Poussin per tutta la vita avrebbe voluto scrivere un Libro di pittura, ma si era limitato ad affidare qualche nota a Giovan Pietro Bellori. Lo studioso si accorge, in un articolo di quegli anni, che c’è ben poco di originale in quelle note: sono tutte ricopiate dagli autori antichi, e non è nemmeno detto che Poussin aderisse a quel che ricopiava. Le casistiche positive sono passate in rassegna nel libro che decreterà le prime fortune di Blunt, Artistic Theory in Italy 1450-1600 (1940), tutto giocato sulla grandezza delle individualità che sono invece arrivate a chiarire il senso morale del loro operare, come Leon Battista Alberti, o che sono riuscite a «esporre per scritto» quello che pensano della propria arte, come Michelangelo. Niente di strano, quindi, che un altro prediletto di Blunt diventasse poi Philibert de l’Orme: l’architetto di Enrico II aveva approntato il trattato di architettura più legato alla sua esperienza personale, riuscendo così a mettersi alle spalle sia Vitruvio che la retorica dell’ornamento.
Uno degli articoli più memorabili di Blunt, A Poussin-Castiglione problem. Classicism and the picturesque in 17th century Rome, appare pure nel 1940, e la sua forza sta tutta nella lucidità che consente di far interagire mondi apparentemente inconciliabili. Blunt pone il «problema» presentando un dipinto, che da più di un secolo si trovava nella galleria dei conti Czernin di Vienna, e che poi, nel 1989, avrebbe acquisito il Metropolitan. Da qualche anno si era anche riusciti a chiarire il soggetto, non semplice da riconoscere: quel vecchio benedicente, mesto nella sua tunica bianca, è Tobia che seppellisce i morti ebrei, contravvenendo ai decreti di Sennacherib, alle porte della città di Ninive. Ancora più complicato, per chi ci aveva provato, era stato identificare l’autore del dipinto: dopo un’attribuzione a Poussin, si era fatto il nome di Sébastien Bourdon, ma con scarso grado di convincimento.
Per inquadrare il dipinto, Blunt si districa fra la Genova di Castiglione, abituata ai continui scambi con olandesi e fiamminghi, propensa a un naturalismo fuligginoso e carico, e l’algida sapienza cromatica di Poussin, tutta calibrata sui Baccanali di Tiziano. L’opera non è un capolavoro, ma pone un rebus: come spiegare una tale vicinanza di stimoli visivi, assorbiti ora da Poussin ora da Castiglione? La scena è infatti poussiniana solo in apparenza, come se una maschera di pittura nascondesse tutt’altro sentire. I blu e i gialli e i rossi «a macchia» delle vesti accendono di colore comprimari misteriosi, che stanno fra le are e le colonne, scuri contro un paesaggio dominato dalle nuvole e da toni di una campagna avvinghiata agli obelischi e agli archi di trionfo, mentre i forzuti che aiutano il sacerdote, ingenuamente spaventati dalla loro stessa azione, sembrano meno consapevoli del cane che sta lì accanto. La tragedia dei corpi, gettati per terra senza vita, scorre quasi inascoltata in un angolo della composizione.
Per decifrare l’enigmatico coesistere di classicismo e pittoresco, Blunt si affida sia all’occhio che a una rete di suggerimenti che gli vengono dallo studio della grafica e delle fonti. Anche Castiglione aveva trattato lo stesso soggetto del Tobia che seppellisce i morti, in un’incisione popolata di nani e di spettri, fuoriusciti dalle invenzioni di Rembrandt. Ecco che da qui vengono i personaggi poi calati nell’impianto ammorbidito del Tobia di Vienna: studiando una serie di altri disegni – conservati a Chatsworth, alla Witt e a Cleveland – cresce in Blunt la convinzione che un pittore si era ingegnato ad assorbire la vena istrionica di Castiglione per poi sconfessarla, introducendo un’atmosfera di segno inverso, dove i cieli splendono azzurri e sereni e le rovine si stagliano come scenografie previste dalle convenzioni.
Il nome del pittore, Andrea de Leone, è quindi scovato in una pagina di Pierre-Jean Mariette del 1743, dove si descrive un Tobia che seppellisce i morti (nella collezione parigina del marchese di Gouvernet )che si sarebbe potuto facilmente scambiare per Poussin: «J’ai vu un tableau de ce maître, qui me donne une grande idée de son habileté. Le sujet étoit Tobie qui donne la sépulture aux morts. Il estoit composé dans le style de Poussin, bien dessiné et bien colorié. Je l’aurois même pris pour du Poussin, si le peintre n’y avoit mis son nom». Per Blunt questo è il dipinto di Vienna, poi passato a New York. E i confronti con le altre opere assegnate a questo pittore, condotte ora con metodo da conoscitore, confermano l’attribuzione.
Oggi su Andrea De Leone si dispone della monografia di Miriam di Penta (De Luca, 2016), un buon libro che permette di seguire agevolmente l’itinerario di questo napoletano, cresciuto studiando il «naturale» con Aniello Falcone e poi finito a Roma, verso il 1630. Si sospetta che De Leone abbia vestito i panni del falsario di opere di Castiglione, cercando di ricavarsi un posto al sole presso collezionisti ormai attratti dalla fama del genovese. Il pittore conoscerà un altro quarto d’ora di gloria quando sarà chiamato a partecipare alla strabiliante decorazione del Casòn del Buen Retiro, con un dipinto oggi al Prado, il Trionfo degli elefanti nel circo, da vedere come un’altra arrogante assimilazione eccentrica, mandando all’aria ancora una volta le caste premesse di Poussin. Bernardo De Dominici aveva anche informato che De Leone era stato costretto a lasciare Napoli dopo la rivolta di Masaniello, e c’è anche un ritratto alla Certosa di San Martino, firmato con la paraffa da Andrea, in cui una tradizione poco fondata vuole riconoscere le fattezze del capobanda. Ma forse si tratta di un autoritratto, e se così fosse si tratterebbe del manifesto principale di una sensibilità autarchica.
Ma per il giovane Blunt conta in particolare l’aver liberato Poussin dalla sola fortuna riscossa in sede classicista. Questa matura soprattutto dopo il suo viaggio a Parigi del 1642, ma se si ritorna agli anni delle sue esperienze romane del decennio prima, il francese diviene una voce fra le tante, di una «città aperta» che era soprattutto fluido laboratorio cosmopolita. Andrea Sacchi e Pietro da Cortona serravano le fila degli opposti schieramenti – accademia versus fazione barocca – ma altre esperienze maturavano ai margini. Non c’erano quindi solo quei versanti che condurranno a codificazioni perduranti: la linea che identifica Poussin nel campione della classicità è quella che prosegue con Bellori, ma si può anche estendere fino a David; quella che lo vuole «campione nazionale» prosegue con Fragonard e Géricault, ma non si dimentichi quanto anche Cézanne ammirasse Poussin, quanto avrebbe voluto rifare Poussin… la terza via, inaugurata dai Castiglione e dai De Leone, è percorribile da bohémiens come Salvator Rosa, più apprezzata dai collezionisti inglesi del Settecento che potevano esporre napoletani e genovesi a fianco dei loro Constable.

