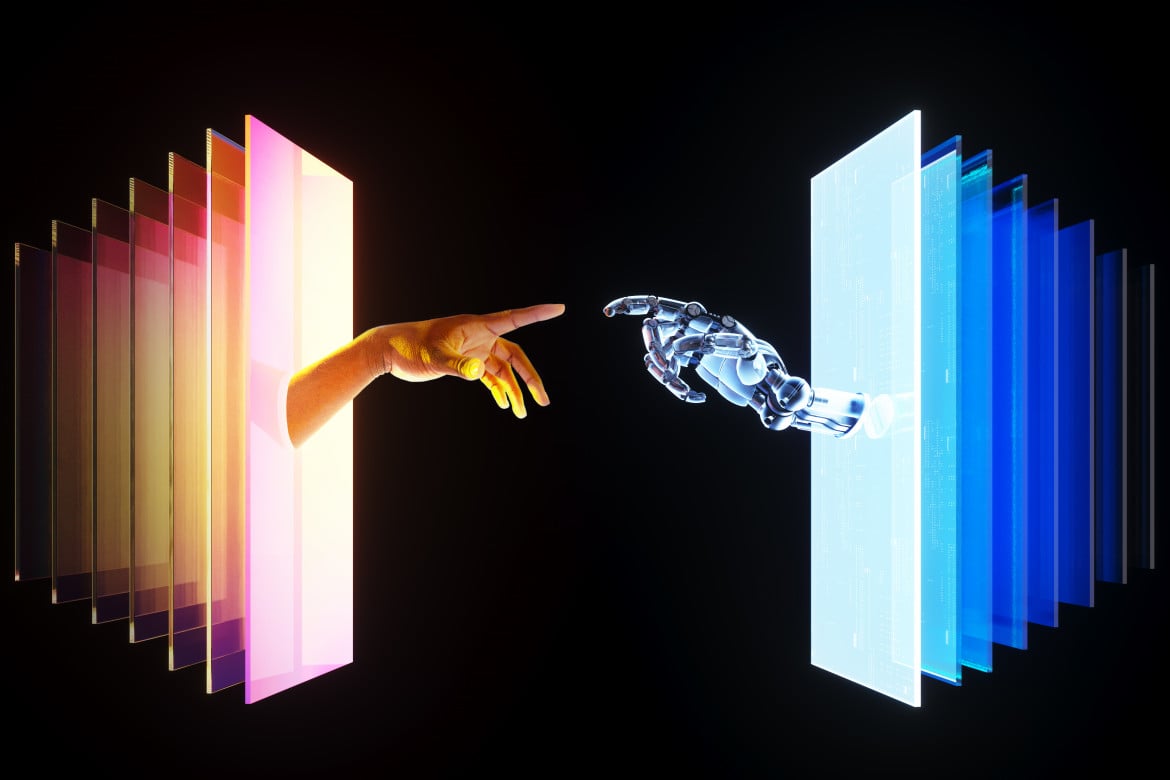Pubblicato 4 mesi faEdizione del 19 aprile 2024
Fino al 21 aprile si svolge a Torino la Biennale Tecnologia, una manifestazione culturale interdisciplinare originale, dedicata quest’anno alle «Utopie realiste». Tra gli ospiti internazionali, c’è Wendy Hui Kyong Chun (oggi alle 15 in Aula 1 del Politecnico, in dialogo con Isabella Consolati), studiosa critica del digitale, concentrata sul rapporto tra democrazia e tecnologia, controllo e libertà al cuore della rivoluzione digitale. Ha la cattedra di ricerca sui new media alla Simon Fraser University in Canada. Ha studiato sia ingegneria dei sistemi, sia letteratura inglese. I suoi libri rappresentano un punto di riferimento per la critica delle piattaforme, del software,...