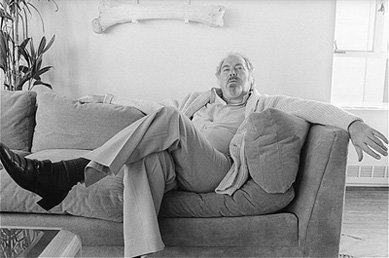Corale e sfaccettata come un film di Altman, l’intervista con Ron Mann, Kathryn Reed Altman e Michael Murphy (uno degli attori altmaniani per eccellenza) ricostruisce non solo il processo produttivo di questo bel biopic doc, ma la figura stessa dell’Altman sovversivo, di generi e in politica, padre di famiglia, regista di attori e sceneggiatore implicito, anche all’interno delle improvvisazioni che incoraggiava («Fammi vedere quello che sai fare, dove puoi arrivare», era la sfida che lanciava agli interpreti), giocatore d’azzardo e festaiolo («Se volevi fargli un regalo, bastava organizzargli una festa», dice Kathryn).
Ron Mann, autore dell’antiproibizionista Grass e dell’ecologista Go Further, cinefilo mai dichiarato finora, ha fatto questo film perché ha sempre amato il cinema di Altman, che considera il padre del cinema indipendente americano, colui che ne ha reinventato il linguaggio, riformulato i generi e sconvolto il modo stesso di fare casting (ammettiamolo: Shelley Duval? Chi le avrebbe mai dato prima una parte da protagonista con quei dentoni e gli occhi sporgenti e quella magrezza così poco sexy?). Mann aveva letto il libro di Zuckoff, Robert Altman: The Oral Biography che gli aveva fatto percepire di essere in sintonia con questo regista politico e innovativo e decidere di girare il documentario.
Approfittando della retrospettiva di Altman al Torino Film Festival, non solo ha rivisto i film, ma è entrato in contatto con Kate, la moglie del cineasta e con Michael Murphy. Le ricerche e la preparazione sono durate due anni, analizzando il fondo di 15mila pezzi di materiali fotografici e cartacei conservati all’Università di Michigan («Pensavo di starci qualche giorno e invece sono rimasto sei settimane») e i film, conservati all’Ucla.
Gli è parso allora che i materiali stessi proponessero il percorso che ha seguito, e che presenta un Altman per certi aspetti inatteso, trasgressivo non solo nel linguaggio filmico ma anche nel modo di produzione. Lavorando con Kate ha scoperto inoltre l’immagine del padre di famiglia, che sul set creava l’atmosfera di una famiglia creativa allargata («Era un tipo socievole, detestava stare da solo») che prima di girare organizzava delle feste per far conoscere il team. («Si stava tutti in quei motel a due piani, e si mangiava insieme»). Durante la lavorazione voleva che ogni attore, anche se con un ruolo minore, vedesse i giornalieri per familiarizzare col lavoro degli altri, creando una situazione in cui si sentissero più liberi di lavorare al proprio personaggio.
Una socialità autentica, rappresentata prima di tutto dalla famiglia stessa di Altman, in sei con i figli dei precedenti matrimoni di entrambi. («Vuoi sapere da dove nasce l’overlapping dialogue? Bastava andare a cena da loro…»)
Il film ripercorre con materiali inediti la prima – e poco nota – fase della carriera del regista, a partire dal suo lavoro nel cinema industriale e in pubblicità, per passare ai telefilm girati per varie serie – Michael Murphy ricorda quando girarono insieme un episodio di Combat, in cui faceva la comparsa nel ruolo di un carrista e Altman fece arrabbiare lo studio perché assegnò delle battute di dialogo anche alle comparse. Tra i primi film Countdown, un B movie che raccontava di un razzo che in piena guerra fredda gli americani facevano atterrare sulla luna con un uomo e un rifugio, ma nel finale che aveva girato la grande impresa propagandistica americana in un certo senso falliva, perché l’astronauta interpretato da James Caan andava in direzione opposta a dove si trovava il rifugio. Allora Jack Warner, con la coda di paglia dalla caccia alle streghe, avendo paura che il film fosse tacciato di essere comunista, licenziò Altman e ci mise un happy ending. Ma il film era interessante anche per lo spazio che dava alle mogli degli astronauti, perché Altman aveva sempre un occhio di riguardo per i personaggi femminili.
Lavorava con le sue attrici (diverse candidate all’Oscar e vincitrici di premi), dando loro la possibilità di approfondire il ruolo, anche a quelle alle prime armi, come in Nashville in cui l’esordiente Ronee Blakley, cantante country, aveva scritto una scena per il suo personaggio, ma lui non volle neppure leggerla, e la mandò in scena davanti a un vero pubblico, estraendone una grande interpretazione. La riprese, in questo caso, con quattro cineprese simultaneamente; l’idea di usare più macchine da presa per girare una scena gli era venuta dal bisogno di esprimere visivamente diversi punti di vista (quella frammentazione non dispersiva ma complessa e talvolta ambigua che diventa sua cifra stilistica).
Altman infatti era un grande sperimentatore di tecnologie e mezzi, anche perché il suo lavoro nel cinema industriale gli aveva insegnato ad essere fast and cheap, veloce ed economico. Fondamentale in questo senso il modo in cui, per riprendere il sovrapporsi delle conversazioni («come avviene nella realtà») abbia utilizzato, invece della giraffa, i microfoni della radio (di cui era grande fan, e che in quegli anni, ricordiamolo, stava esplodendo con nuove funzioni e stili) e i registratori a più piste, sviluppati per lo stereo.
Innovazione come sfida, come gambling, gioco d’azzardo: figlio di un giocatore era lui stesso un amante ed esperto del gioco (basta rivedere California Poker), infatti in uno dei momenti più bassi della sua carriera, quando in famiglia erano in sei e «c’era il conto del lattaio in sospeso» si era giocato gli ultimi soldi; e aveva vinto.
Giocando sul modulo del documentario, che chiede agli attori altmaniani di dare una definizione di cosa significhi per loro «altmaniano» Kate propone la sua: altmaniano vuol dire «senza paura», avere il coraggio di assumersi rischi enormi sia dal punto di vista creativo che professionale: basti contare le volte che è stato licenziato, l’altalena tra grandi successi e flop clamorosi, la sfida costante alle regole dello Studio System e dei generi, il modo democratico di lavorare con gli attori, le scommesse stilistiche come gli interni bui de I Compari, o i dialoghi corali da Nashville in poi.
Tra il ricco repertorio di inediti che il film propone anche tre «home movies», Pot au feu, The Story of Kathryn Reed e The Party, o, meglio, tre corti indipendenti, girati con amici e parenti, tra una pausa e l’altra dei film («Quando non lavorava se ne inventava sempre una, dal mettersi a dipingere, con buoni risultati, a creare una credenza coi ripiani intercambiabili, come fossero tovaglie», dice Kate.). Ron Mann conclude osservando che Altman era un regista antiautoritario e politico; che non ha mai mollato, restando sul pezzo fino alla fine, perché era nel suo carattere e amava il suo lavoro.
Il film Altman, già acquistato dalla Feltrinelli, uscirà in dvd, proponendo tra gli altri i tre notevolissimi corti, e farà parte di una rassegna dedicata al regista che si vedrà a febbraio su Studio Universal, e che forse includerà anche The Delinquents, il primissimo film del nostro, inedito, una sequenza del quale appare nel documentario.