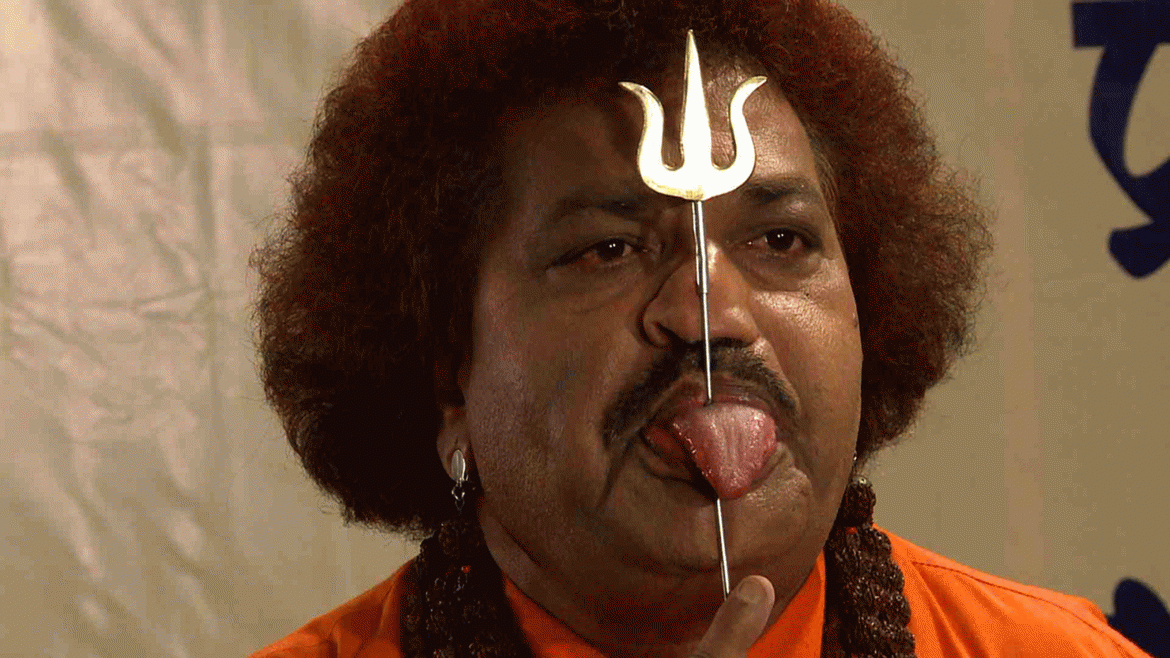Assolutamente da non perdere domani, dalle 11 fino al pomeriggio inoltrato, allo spazio WeGil di Largo Ascianghi 5, l’eccezionale full immersion in un’India di cui le cronache non parlano proprio mai – grazie al lungo e davvero magnifico documentario di Anand Patwardhan, all’interno della rassegna Asiatica, già in corso a Roma da giorni.
Presentato in numerosi Festival internazionali, premiato all’ultimo Festival del Film Documentario di Amsterdam, il film si intitola semplicemente Reason e per circa quattro ore si interroga circa l’allucinante deriva del fondamentalismo induista, in contrasto con quei valori di inclusività e tolleranza tradizionalmente associati all’induismo. Perché «contrariamente alla religione, che predica di avere fede in una qualche edificante verità, l’atteggiamento della ricerca non dovrebbe mai smettere di interrogarsi circa le ragioni», come predica il medico-attivista Narendra Dabholkar nelle immagini iniziali del documentario – che coincidono con una delle sue ultime apparizioni in pubblico, prima di essere assassinato il 20 agosto 2013.
E le ragioni diventano a poco a poco chiare nell’inquietante dipanarsi degli episodi che Patwardhan riesce a intercettare o si precipita a documentare, e che a tratti sembrano incastrarsi l’uno dentro l’altro essendo proprio la stessa storia; in altri momenti ci commuovono per ciò che di umano affiora dalla melma; o più spesso ci turbano per l’insistita esibizione di violenza, e violenza di branco.
Un viaggio nella pancia dell’India che, come tutti gli altri film precedenti di Anand Patwardhan, non nasce da un progetto preciso, ma a un certo punto prende forma intorno all’intuitiva urgenza di essere lì, testimone dell’ultimo scioccante fatto di cronaca – per provare a capire, per ragionare in camera e con chi ci vive dentro. «Tutti i miei film sono il prodotto di mesi a volte anni di riprese, che mi trovo a raccogliere a partire da qualcosa che mi ha riacceso la voglia di filmare», ha spiegato Patwardhan al Festival del Film Documentario di Amsterdam. «Nei primi anni 90 mi trovai a raccogliere ore di girato che praticamente annunciavano l’assalto alla Moschea di Babri ad Ayodhia, nello stato dell’Uttar Pradesh, ferita tuttora aperta per l’India. Ne nacque In the name of God (1992) che tutti ritennero un instant-film, così a ridosso di quei fatti – e invece aveva solo fiutato quei fatti già da prima. Qualche anno dopo l’evento-motore fu l’uccisione di una decina di dalits in uno slum di Mumbai, Ramabay Colony, e la complessità psico-politica di quel pezzetto di mondo che avrei immaginato solo miserabile, e che mi si rivelava invece nel suo intreccio di pulsioni, affetti, voglia di riscatto, mi impegnò per mesi e diventò Jai Bhim Comrade (1997), dedicato ad Ambedkar, che più di Gandhi è il punto di riferimento per 200 milioni di dalits in tutta l’India».
Nel caso di Reason, il film si è messo in moto con lo shock per i fatti di Una e più ancora di Dadri: i primi episodi punitivi ai danni di chiunque fosse ritenuto colpevole di consumo, utilizzo, e quindi decesso della mucca, da sempre ritenuta sacra per l’induismo – ma non al punto da giustificare la pubblica punizione dei ‘colpevoli’ a colpi di bastonate esemplarmente condivise sui social, come successe appunto a Una, sud del Gujarath, nel luglio 2016. Ed era già successa la storia di Dadri, linciaggio in piena regola: un’intera comunità tranquillamente co-esistita fino a pochi mesi prima, pur nella disparità numerica che in tutta l’India vede i musulmani in netta minoranza rispetto agli induisti, e che improvvisamente si avventa armata sul diverso-vicino, sospettato di consumare carne bovina. Le indagini appurarono poi che la carne effettivamente conservata nella dispensa di quel poveretto, era di montone. Il che non modifica le convinzioni di uno degli assassini ripreso in camera: “Falso, fake news… E comunque lui era mussulmano, quante volte avrà mangiato carne di mucca…» e solo poche immagini prima abbiamo contemplato lo scempio di quella casa, e i primi piani dei figli della vittima, le palpebre che si abbassano su ciò che gli occhi hanno visto, l’incredulità che nonostante tutto prevale sull’impulso di vendetta: «siamo sempre stati in pace, mio padre lavorava come fabbro, da lui venivano tutti, mai avuto un litigio…»
E già da prima gli assassinii per eliminare quelle poche voci coraggiose che, lontane dai riflettori, lavoravano per mitigare le sempre più immense disparità: il medico-attivista Narendra Dabholkar di cui abbiamo già detto, fatto secco nel 2013; il comunista scrittore Govind Pansare, nel 2015; e poi l’intellettuale M.M. Kalburgi, nel Karnataka, seguito due anni dopo dalla giornalista-attivista Gauri Lankesh. Tutti finiti nello stesso modo: una motoretta che si avvicina nella notte, un colpo secco di pistola, nessuna seria indagine, nel più sinistro giubilo sui social.
E a un certo punto scoppiano le università, già da tempo in affanno per il taglio di fondi, perché figurati se in India non conviene fare spazio al privato: business colossale. L’incidente scoppia ad Hyderabad per un episodio di esclusione, ai danni di un’esigua minoranza di studenti dalits che a prezzo di sacrifici immensi hanno avuto una borsa di dottorato, ma ahimè sono politicizzati, invisi alla maggioranza del campus che invece è zafferano, ovvero BJP. Tafferugli, misure punitive, ci scappa il suicidio di Rohit Vemula, la protesta dilaga anche a Delhi, disordini per mesi…
E molto, troppo, altro. Impossibile tentare di rendere su queste colonne la straordinarietà di questa esperienza immersiva nel cuore più incandescente dell’India di oggi, anche perché niente potrebbe valere la visione del film domani, allo spazio WeGil di Roma – e recuperabile anche, diviso in parti, su YouTube. Sperando che, sull’esempio davvero coraggioso di Asiatica, qualche altro Festival si decida a dedicare prima o poi una retrospettiva al lavoro di questo vero e proprio pioniere oltre che guruji del cinema documentario indiano che è senz’altro Anand Patwardhan. Sarebbe ora!