Lo scorso 27 aprile Emmanuel Macron ha visitato, schivando ben protetto dai Crs manifestanti e contestatori, il Fort de Joux, nido d’aquile nel quale il 7 aprile del 1803 veniva lasciato morire Toussaint Louverture, l’ex schiavo condottiero imbattuto della rivoluzione haitiana. Attirato nelle mani dei francesi con un tranello, Bonaparte lo aveva fatto deportare e imprigionare in quel tetro maniero, riservato ai più pericolosi nemici della nazione, nel 1802. Nel celebrare il 175esimo anniversario dell’abolizione della schiavitù (27 aprile 1848) il presidente francese ha commemorato in un tripudio di retorica nazionale e repubblicana la figura di Toussaint, «combattente in nome della rivoluzione francese», «difensore dei lumi», «generale franco-haitiano».
MA IN VERITÀ il rapporto tra Toussaint e la rivoluzione parigina, con tutti i suoi ipocriti contorcimenti, le sue omissioni e le sue furbizie, fu tutt’altro che lineare. Vi fu perfino una fase iniziale in cui i capi dell’insurrezione nera cavalcarono il mito di un re buono tenuto in ostaggio dai padroni bianchi per impedirgli di dare la libertà agli schiavi neri, issarono le insegne dell’ancien régime e ne assunsero il linguaggio reazionario e clericale. La sostanza della loro azione restava però rivoluzionaria.
Come recita un celebre passo marxiano del 18 brumaio di Luigi Bonaparte quanti lavorano a trasformare le cose e a creare «ciò che non è mai esistito, proprio in tali epoche di crisi rivoluzionaria essi evocano con angoscia gli spiriti del passato per prenderli al loro servizio; ne prendono in prestito i nomi, le parole d’ordine per la battaglia, i costumi, per rappresentare sotto questo vecchio e venerabile travestimento e con queste frasi prese a prestito la nuova scena della storia». Il brano, che però si riferiva al celebrato esempio delle antiche repubbliche, è citato da Aimé Césaire, poeta e drammaturgo martinicano, nel libro del 1960, dedicato alla rivoluzione haitiana, ora in edizione italiana per la casa editrice Alegre (Toussaint Louverture. La rivoluzione francese e il problema coloniale, a cura di Giuseppe Sofo, traduzione di Michela Nessi, pp. 350, euro 20).
In questo lungo, dettagliato lavoro, il poeta si fa per una volta storico e cronista: attraverso il montaggio di interventi all’Assemblea nazionale e alla Convenzione, proclami, lettere, discorsi, progetti di legge, articoli, raccordati da una ricostruzione letteraria ma sempre politicamente orientata dei fatti, cerca di restituire l’orizzonte e il senso di marcia di uno dei più aggrovigliati e feroci eventi della storia coloniale. Il primo e il solo ad aver condotto una rivolta di schiavi vittoriosa alla fondazione di uno stato indipendente, seppure destinato a un’esistenza decisamente infelice. La Francia, del resto, ha poco da vantarsi, caso unico che dopo aver abolito la schiavitù, tra retorica egualitaria, prudenze e infiniti distinguo, nel 1794, l’avrebbe poi reintrodotta nel 1802 e conservata ancora per più di 40 anni.
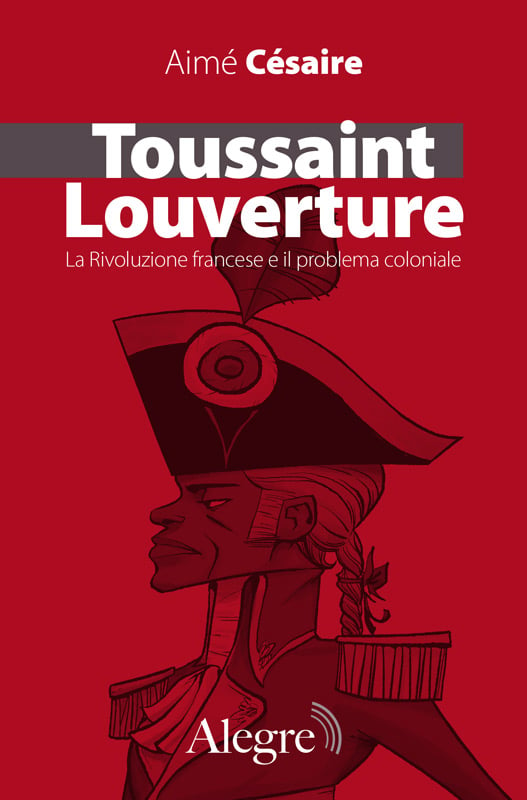
A Santo Domingo, Toussaint, che fino a quel punto aveva condotto la sua guerra per la liberazione degli schiavi contro la resistenza dei coloni francesi sotto gli stendardi della monarchia schiavista spagnola issa ora la bandiera tricolore. Ma, avverte Césaire, Toussaint e le masse che lo seguono non sono, né mai diventeranno, attori esotici della rivoluzione francese. Quella che vanno costruendo, in un percorso frammentato, irregolare e non privo di paradossi, è un’altra storia, quella della lotta anticoloniale che l’autore legge essenzialmente attraverso categorie marxiane.
A PARIGI IL SOLO MARAT, lucidamente radicale, in un articolo del suo Ami du peuple, aveva posto già nel 1791 la questione dell’indipendenza dalla Francia come premessa della liberazione dei neri e dei mulatti dalla tirannia dei coloni bianchi «con ogni mezzo necessario».
La crisi rivoluzionaria nella madrepatria aveva fatto intravvedere a tutte le classi e i gruppi sociali dell’isola l’occasione per realizzare le rispettive rivendicazioni. Per i proprietari terrieri libertà di commercio e autonomia politica, per i mulatti libertà politica e parità di diritti, per i neri libertà tout court. Questi tre movimenti, tra loro conflittuali nel difendere le proprie posizioni di potere, si rispecchiano nella tripartizione dell’opera di Césaire. «la fronda dei ricchi bianchi», «la rivolta mulatta», «la rivoluzione negra». Laddove solo la sollevazione degli schiavi, quella che condurrà all’indipendenza di Haiti proclamata il 28 novembre del 1803 dopo la resa delle truppe francesi al generale nero Dessalines, si guadagna il titolo di «rivoluzione». Nessuna soluzione intermedia avrebbe potuto tenere.
Nelle sue conclusioni lo scrittore martinicano commenta: «il potere derivato dalla Rivoluzione francese non poteva dar seguito alla rivendicazione di libertà di una delle classi della società coloniale senza rimettere in gioco il problema dell’esistenza stessa della società coloniale» (…) «per liberare una delle classi della società coloniale bisognava liberarle tutte e per farlo bisognava liberare la stessa Saint-Domingue». E solo i neri, ultimo anello nella catena dell’oppressione e primo in quella della rivolta poterono farlo.
Con l’indipendenza tornarono alla ribalta le maschere del passato monarchico e autocratico. Dessalines, fattosi imperatore, fu assassinato, dopo aver fatto massacrare tutta la residua popolazione bianca dell’isola, nel 1806. Il generale nero Henri Cristophe (Césaire gli dedicò un’opera teatrale tragica nel 1963) si proclamò monarca di un regno del nord fino al suo suicidio nel 1820. Iniziava così la tormentata esistenza dello stato haitiano, isolato per timore del contagio da gran parte delle nazioni, con qualche occasionale eccezione dettata da interessi commerciali o geopolitici.
QUANTO ALLA FRANCIA, che oggi celebra Toussaint, non si risparmiò l’estrema infamia (ma non fu la sola) di stabilire un gigantesco risarcimento finanziario non per gli schiavi ma per i loro padroni, e di pretenderlo da Haiti la cui indipendenza fu riconosciuta solo dopo essersi piegata a questa imposizione nel 1825. Uno dei paesi più poveri del mondo ha continuato a pagare fino agli anni 50 del secolo scorso, e il debito non è stato certo un fattore irrilevante tra quelli che ne hanno fortemente frenato lo sviluppo.
Ma Césaire, che scrive nel 1960 in piena stagione delle indipendenze e delle lotte di liberazione anticoloniali, non rivolge la sua attenzione a queste derive (se ne sarebbero viste diverse nella successiva storia delle ex colonie divenute indipendenti). Ciò che più precisamente mette a fuoco è la spinta e la potenza espressa dalla classe più oppressa e sfruttata, sia pure quando si manifesta in forme spurie e quasi superstiziose, la contraddizione insanabile tra gli interessi della metropoli e quelli delle terre che ne dipendono, nonché l’ipocrisia di una falsa ragione universalistica.

