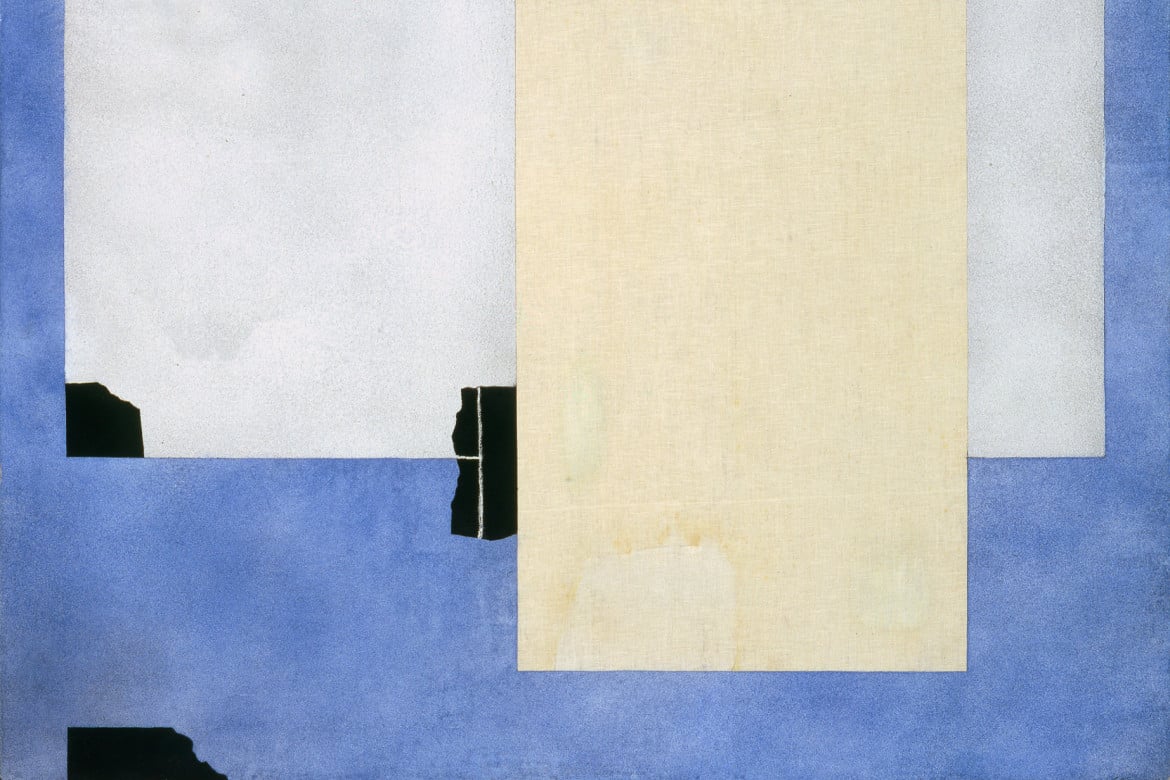I Greci la chiamavano «parresia» e intendevano con essa la virtù di dire il vero, di parlare con franchezza in pubblico: nulla di naturale e immediato, anzi, la verità è spesso ciò che per consuetudine, educazione, costume non è il caso di dire. Tiziano Scarpa ne ha fatto il nucleo del suo ultimo e per molti versi perturbante libro, La verità e la biro (Einaudi, pp.232, € 18,50), dove la biro è evidentemente la scrittura, il modo in cui parla chi scrive: non una scrittura neutra, non quella della comunicazione in cui emittente e destinatario sono soggetti impersonali, bensì la scrittura di un io individualizzato, con la sua grafia, il suo stile, le sue idiosincrasie e le sue ossessioni.
La verità, dall’altro lato, è qualcosa che sembra porsi al di là dell’io, fuori dal suo particolare, in una dimensione di universalità nella quale anche gli altri individui devono riconoscersi. A connettere i due termini – la biro e la verità – è, per Scarpa, la letteratura, che è sempre, e in questo libro forse più che mai, la voce di un io situato e della sua disponibilità a dire il vero.
Incrociando la dimensione del memoir e quella del diario intimo, il testo segue un doppio binario: a brevi capitoli dedicati perlopiù al racconto di episodi che riguardano il passato del narratore si alternano riflessioni al presente, ovvero la rielaborazione di appunti che lo stesso narratore ha annotato durante una vacanza sull’isola greca di Kos insieme alla moglie. Il tutto anticipato da una brevissima avvertenza, che proietta questi racconti e queste divagazioni in un orizzonte decisamente straniante. Nelle righe che precedono il libro vero e proprio e ne determinano al contempo l’orizzonte di attesa, l’autore scrive che dovrà affrontare un’operazione chirurgica che avrà come esito una sorta di transizione sessuale: «da uomo che sono verrò trasformato in qualcosa d’altro». Quando il libro sarà pubblicato, scrive l’autore firmando e datando la rivelazione, «io non sarò più un maschio».
Di cosa succederà, in effetti, il libro non parla. Tuttavia, l’autore chiede a chi legge di partire da questa notizia, come se essa funzionasse da sfondo per le parole scritte, «un colore della carta o dello schermo». Così, i racconti spesso anche molto anatomicamente dettagliati della vita sessuale del narratore, gli incontri con le ragazze con cui si è andata formando la sua «maschilità», le osservazioni sul proprio corpo e su quello degli altri, ma anche le considerazioni intorno al suo essere diventato ciò che è – uno scrittore riconosciuto – e non sarà più – un maschio – assumono una dimensione persino metafisica, descrivendo implicitamente una sorta di indagine intorno al significato dell’essere quell’io che si è, quell’ostinata individualità che non si arrende all’indistinzione.
Per molti versi, questo libro che lo stesso Tiziano Scarpa chiama «bizzarro», dà seguito alla sua indagine, condotta con coerenza e pervicacia, circa il nesso indisgiungibile tra l’io e la letteratura. Decisiva e inaggirabile, la questione dell’io in quanto corpo, storia individualizzata a partire dalla quale assume senso la forma artistica, è forse responsabile dell’accusa che gli è stata mossa, di narcisismo autoriale; ma la faccenda è in realtà ben più complessa e interessante, e riguarda la ribadita concezione radicale della letteratura come forma di resistenza all’omologazione, al già noto, e dunque al potere nelle varie forme che esso assume. L’io che parla nella letteratura non è mai, per Scarpa, un soggetto ideal-tipico, una «bestiolina da allegoria», il rappresentante di qualcosa d’altro da sé, sia esso la società, l’epoca o una qualche condizione esistenziale.
L’io è piuttosto un punto di vista irriducibile, persino arbitrario, che solo esponendosi e rivelandosi può attingere alla realtà, solo aderendo al «proprio punto di parola» può dire quella verità che l’ipocrisia sociale impedisce di dire. Come a dire che solo dicendo «io» la parola raggiunge qualcosa che non è più solo «io».