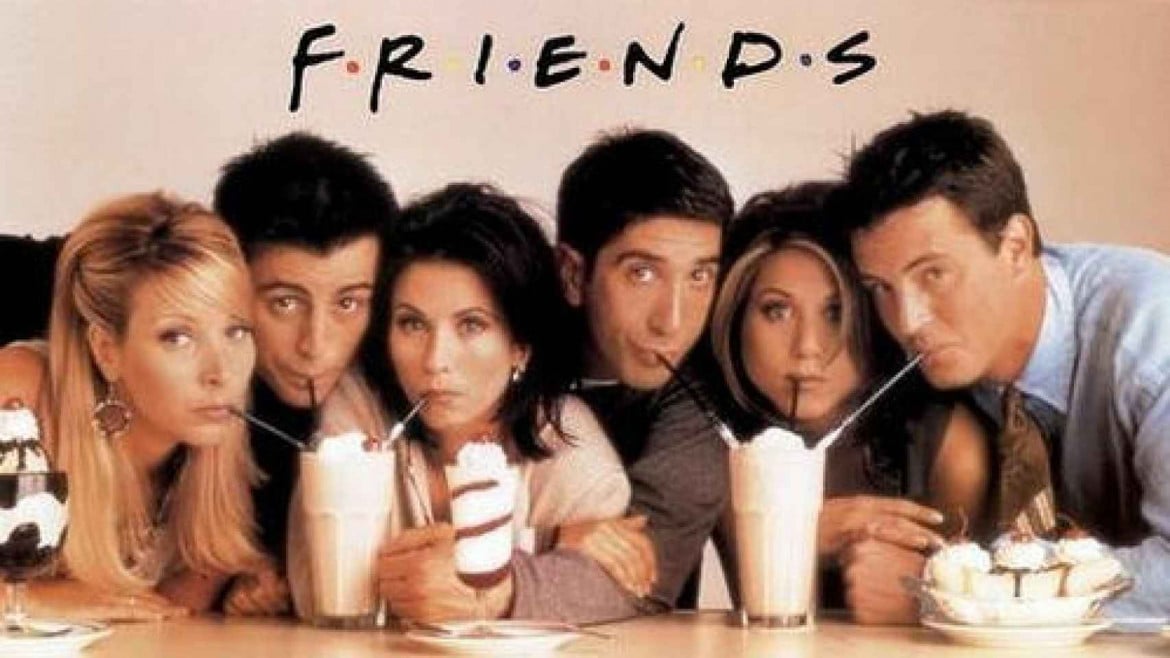La notizia mi ha colto impreparata. Quando ho letto che, sabato scorso, è stato trovato morto a soli 54 anni, nella vasca idromassaggio della sua casa a Los Angeles, l’attore Matthew Perry, il famosissimo Chandler di Friends, e che la cosa ha sollevato un’onda di dolore in mezzo globo, compreso il primo ministro canadese Justin Trudeau che, avendolo avuto come compagno di scuola, gli ha dedicato pensieri dolcissimi, ho pensato: «Ohccheccaspita. Non ho mai visto una sola puntata di Friends. Non so neanche chi sia Chandler. Non so niente nemmeno di Perry. Devo preoccuparmi?». Ammetto che, non sentendo un bisogno viscerale di documentarmi, non sono nemmeno andata a recuperare nel mare magnum internettiano vecchie puntate della serie televisiva durata dieci stagioni (dal 1994 al 2004), di successo planetario e che, ho scoperto leggendo le cronache, narra la quotidianità di sei amici che condividono un appartamento a New York. Quando Friends arrivò in Italia era il 1997, non c’era internet, possedevo una minuscola e ridicola televisione in bianco e nero e a tubo catodico, a lungo rinfacciatami da mio figlio come prova che meritavo di essere segnalata a Telefono Azzurro, la sera avevo da fare tutto tranne che sedermi davanti al piccolo schermo.
IN SEGUITO mi sono lasciata corrompere e oggi sono contenta di aver visto, più e più volte, tutti gli episodi di tutta la serie di Sex and the city di cui non ho mai più trovato epigoni all’altezza, ma confesso la mia scarsa dedizione alle serie televisive e, quindi, i miei buchi documentali. Con l’esperienza ho imparato che quando non si conosce una cosa è bene non parlarne, e che più l’argomento è complesso più è saggio documentarsi, ascoltare, conoscere prima di esprimersi. Per tutte queste ragioni mi sono astenuta dal postare qualunque commento riguardo a Perry e Friends sui social. Non sarebbe servito a nulla. Non avrei detto niente di utile. Negli ultimi mesi, mi capita sempre più spesso il bisogno di restare fuori dalla mischia dei commenti anche su cose che conosco e di cui ho opinioni molto chiare. Leggo riflessioni anche interessanti, mi viene da intervenire ma poi, vedendo che piega prendono le discussioni, il dito si ferma a mezz’aria e me ne sto alla larga. Il gusto dello scontro e l’incomprensione prevalgono il più delle volte sui ragionamenti, i punti di vista si parcellizzano perdendo il senso della complessità, ci si concentra sull’adesso senza considerare la genesi di un evento e si finisce con l’accapigliarsi, bannarsi, offendere, offendersi, fraintendere.
SEMBRA QUASI che ormai si frequentino i social non per conoscere o scambiare opinioni, ma per darsele di santa ragione o applaudirsi, in un’orgia di alternanza amore/odio che fa venir voglia di scappare. Lo è stato sulla guerra in Ucraina e lo è ora più che mai sul conflitto Hamas /Israele, ma può succedere anche sulle cose più semplici come un film, un articolo, una trasmissione, le dichiarazioni di un attore. Di fronte a questo battagliare continuo io mi sottraggo, mi viene voglia di scomparire e di praticare l’arte del silenzio, cosa ben strana per chi viene da una storia le cui maestre di femminismo hanno praticato il diritto di parola.
Qui non si tratta più di parlare o non parlare, perché sappiamo farlo e non ci facciamo intimidire. Il problema, caso mai, è che senso dare alle parole e ai ragionamenti quando sono così bistrattati o misconosciuti. Che valore hanno, oggi, le parole? Quali sono le parole da dire? Quali parole lasciano il segno? Non ho risposte. Solo domande. E comunque tacere, ogni tanto, è bellissimo.
mariangela.mianiti@gmail.com