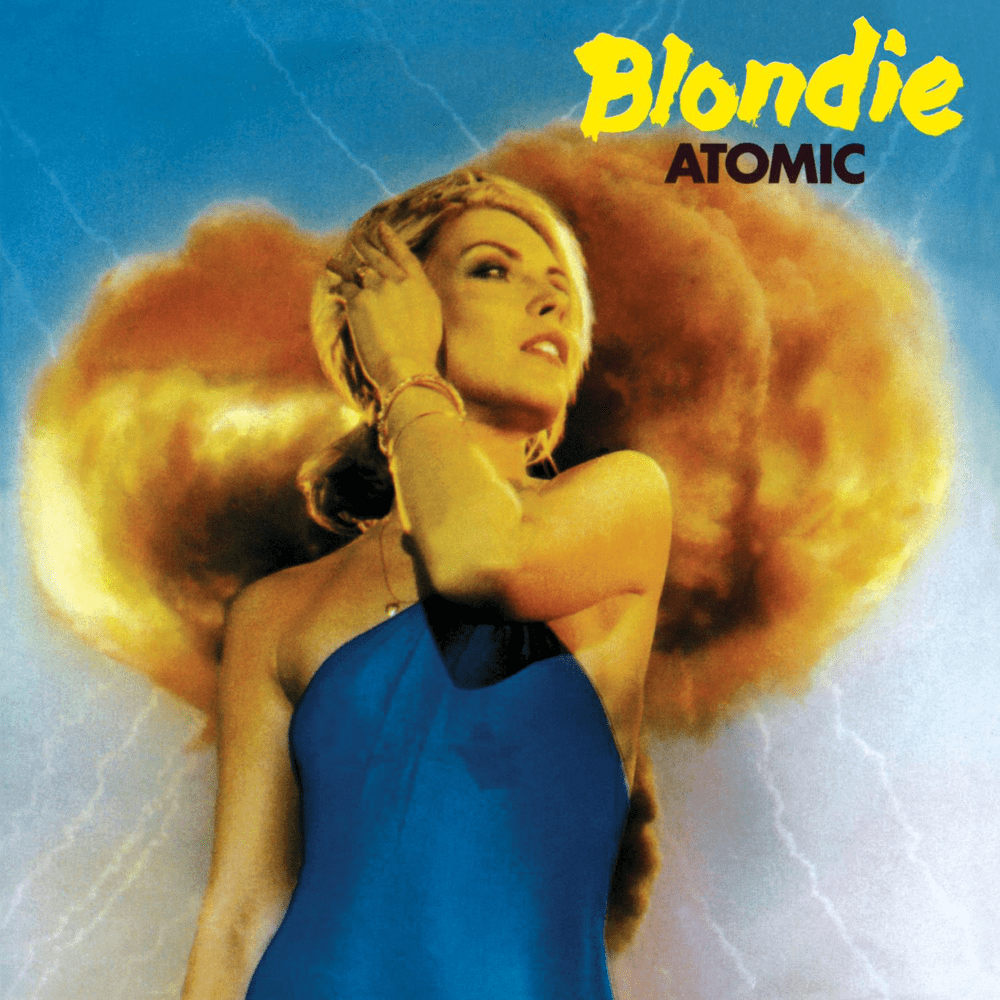Nella guerra contro l’Ucraina in atto da due anni e mezzo gli assetti bellici sono sempre più pericolosi, le forze armate russe conducono esercitazioni della componente nucleare tattica mentre il segretario generale della Nato Stoltenberg ha dichiarato che i paesi dell’Alleanza autorizzeranno l’Ucraina a colpire il territorio nemico con le proprie armi. Si parla di riprendere i test atomici. C’è di che preoccuparsi.
La crisi dei missili di Cuba del 1962, Kennedy, Krusciov e le foto dei missili dell’aereo-spia U2 sembravano appartenere all’Arcadia atomica finché pochi giorni fa un sottomarino russo è emerso nel porto dell’Avana. «Non trasporta armi nucleari», afferma una nota del Cremlino che rievoca Bob Dylan quando nel 1963 dichiarò a un anno dalla scoperta di quei missili: «No. Non è la pioggia radioattiva». Con un’intuizione poetico-musicale degna di un Premio Nobel Dylan immortalò il momento febbrile in A Hard Rain’s a-Gonna Fall. A quei giorni ritornarono gli XTC nel 1980 con Living through another Cuba, efficace ricostruzione dell’atmosfera psicotica che avvolse quei decenni epocali della musica pop rock.
Se l’Avana è lontana (per ora), la vicenda degli Euromissili tra i Settanta e Ottanta lo è meno. In un’epoca di visioni psichedeliche si materializzò la parità nel numero di testate nucleari tra Usa e Urss. Né era lisergica l’immagine del segretario del Pcus Leonid Breznev – solitamente in divisa, onusto di medaglie, il colbacco ben calcato sulla testa e il viso intagliato in una gelida espressione – in costume da bagno, occhiali da sole e orologio d’oro sul suo yacht in Crimea mentre partecipa a un incontro col cancelliere della Germania occidentale Willy Brandt. Il severo «apparatcik» mostrava di gradire la distensione come strategia ma anche come agio e rilassatezza. Breznev amava il jazz e le romanze sovietiche di Leonid Utesov e in gioventù era stato un attore di talento, gli piaceva mettersi in mostra e l’immagine del bacio con Honecker diventerà una delle icone della guerra fredda, riprodotta sul muro di Berlino dal pittore russo Dmitri Vrubel con il titolo Dio mio, aiutami a sopravvivere a questo amore mortale.
CENSURA E LIBERTÀ
Il comportamento ambivalente di Breznev alimentò un’ondata di controcultura rock, punk, new wave. L’Unione Sovietica sapeva da tempo come confezionare musica di contrabbando con le rëbra (costole), microsolchi realizzati con lastre per radiografie contenenti musica censurata degli anni Cinquanta e Sessanta. «Era una musica alternativa distribuita attraverso cassette pirata – ricorda Daniele Zaccaria dalle colonne de Il dubbio – i servizi di sicurezza seguivano passo dopo passo i giovani musicisti quasi tutti schedati che si riunivano nei sottoscala per suonare insieme». Alla fine il governo concesse loro di aprire il Leningradskij rok-klub, nato nel 1981 a Leningrado in via Rubinstein. La censura controllava le band per evitare che facessero propaganda sovversiva e nel contempo offrendo ai musicisti un posto dove esibirsi. Il club assicurò una libertà creativa senza precedenti e diede un importante contributo alla rivoluzione rock russo-sovietica. Sull’esempio di Leningrado si aprirono altri locali simili a Mosca e in altre città e villaggi sovietici. Viktor Tsoi, figlio di un’insegnante russa e di un ingegnere di origine coreana, fu il leader della band Kino, tra le maggiori di quella scena che annoverava Zoopark, Televizor, Piknik, Auktyon e i più noti DDT. A distanza di decenni il sound della band di Tsoi è impressionante, la sua voce trascinante e l’attitudine da idolo bello e dannato (morì a 28 anni), a metà tra Bruce Lee e Jim Morrison, è talmente conturbante che potresti innamorartene senza capire un’acca dei suoi testi.
La dualità di Breznev confuse i politici occidentali cui toccò un brusco risveglio quando i sovietici nel 1977 dispiegarono gli SS20, missili a raggio intermedio modernissimi e armati con tre testate nucleari indipendenti in grado di colpire qualsiasi città europea. L’intento era «disaccoppiare» gli interessi strategici americani da quelli europei e l’SS20 Saber, «sciabola», (RSD10 Pioner il nome sovietico) lo strumento per reciderli. La Nato non aveva nulla di simile nel proprio arsenale. Appena due anni dopo l’Urss invase l’Afghanistan. Un destro-sinistro da KO. Gli Usa erano guidati da Jimmy Carter, l’ultimo germoglio del flower power, delle rivolte studentesche a Berkeley e delle marce contro la guerra in Vietnam. Qualche anno prima Crosby, Stills & Nash avevano registrato Wooden Ships, scritto al culmine delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica durante la guerra del Vietnam. Si descrivevano le conseguenze di una guerra nucleare apocalittica e anche se questo non era l’unico esempio di devastazione nucleare in musica (Eve of Destruction di Barry McGuire) la presenza come co-autore del testo di Paul Kantner dei Jefferson Airplane, emblema dell’era della controcultura, forse giocò un ruolo importante nel rendere questo brano più memorabile di altri.
Carter condannò l’operazione afghana, «il più grande rischio per la pace dal 1945», ma la sua voce non era la più adatta a recapitare contenuti bellicosi: era stato lui a incidere uno dei messaggi di pace contenuti nel Voyager Golden Record, l’ellepì interstellare trasportato dalla sonda omonima nel 1977 e destinato alle intelligenze extraterrestri. C’erano i saluti in 55 lingue compreso il latino e tracce musicali che tra Bach (il più gettonato), Mozart, Beethoven e Stravinsky annoveravano musica popolare russa, blues americano e un’incursione nel mondo della «urgent ethnomusicology» con un canto notturno degli indiani Navajo raccolto da Willard Rhodes.
STRATEGIA EUROPEA
La crisi degli Euromissili giunse nel pieno delle trattative sulla limitazione delle armi nucleari strategiche Salt II. Gli SS20 però non rientravano negli accordi perché non intercontinentali. Definiti «missili da teatro», il loro palcoscenico era l’Europa. Secondo le dottrine di «risposta flessibile» e «limited nuclear option» avrebbero potuto provocare una guerra nucleare confinata al nostro continente: come si affermava in The Day After, film epocale del 1983, gli Usa non sarebbero stati costretti a sacrificare Chicago per difendere Amburgo. Le nazioni europee – in testa Germania e Italia, a più alta concentrazione di basi Nato – decisero di ricorrere a una strategia comune chiedendo all’alleato americano di legare il proprio destino a quello dell’Europa. Al termine di un sofferto negoziato, la Nato presentò «la doppia decisione»: una proposta di trattato all’Urss e allo stesso tempo il dispiegamento entro il 1987 di ordigni atomici che nel nostro paese sarebbero andati a Comiso, in Sicilia.
Le cose accelerarono quando Carter fu sconfitto da Reagan nel 1980. Poche transizioni politiche hanno simboleggiato meglio il passaggio da un’epoca all’altra. Per Reagan, l’Urss era «l’Impero del male», serviva un robusto riarmo. Ai sovietici propose l’«opzione zero», come dire «non mi interessa perché li avete messi ma ora noi tutti leviamo questi missili». Reagan sembrò anche ignorare il trattato che limitava i «missili antimissile», gli Abm. Nella logica nucleare, la pace era garantita dalla deterrenza: chiunque avesse iniziato l’attacco avrebbe ricevuto una risposta certa e uguale e assicurato la distruzione di entrambi. Era la strategia «Mad», ovvero Mutual Assured Destruction ma anche «folle». Un sistema capace di intercettare i missili in arrivo e limitare la rappresaglia avrebbe alterato questo equilibrio. In realtà i sistemi Abm non sono infallibili ma è noto che Reagan amasse la fantascienza: era un avido lettore delle storie di John Carter of Mars di Edgar Rice Burroughs e un fan del film Ultimatum alla terra, tanto da affermare che Usa e Urss avrebbero risolto le proprie divergenze solo di fronte a un comune nemico alieno. Dev’essere stata una gioia per lui quando il 23 marzo 1983 presentò il proprio rivoluzionario quanto inesistente sistema di intercettazione di testate nucleari, l’Sdi, Strategic Defense Initiative, un complesso di Abm, laser orbitali e altre diavolerie che avrebbe dovuto proteggere l’America da qualsiasi attacco. Non c’è arma che rappresenti meglio gli anni Ottanta dell’Sdi o, come fu definito dai media americani, «Star Wars», presto querelati da George Lucas per l’uso improprio dell’omonima saga: «Star Wars is a movie, not a missile zapper» (Star Wars è un film, non un distruttore di missili). Solo in un periodo in cui tutto sembrava possibile si sarebbe potuto pensare a uno strumento impossibile. E poteva immaginarlo soltanto chi aveva inconsapevolmente prestato il proprio nome all’edonismo reaganiano, concetto coniato da Roberto D’Agostino nel programma televisivo Quelli della notte di Renzo Arbore. L’annuncio di Reagan destabilizzò una situazione già complessa, le trattative si arenarono e alla fine di novembre la Nato cominciò il dispiegamento dei missili Pershing in Germania e dei Cruise in Belgio, Italia, Olanda e Regno Unito.
La risposta popolare fu massiccia ovunque, anche in Italia da poco uscita dall’euforia della vittoria al mondiale di Spagna. Imponenti le manifestazioni: 300mila persone a Parigi, un milione a Roma il 22 ottobre 1983 e ancora di più in varie città della Germania, dove partecipò anche il Nobel per la letteratura Heinrich Böll, senza che però riuscissero a smuovere di un millimetro le posizioni dei governi.
Ancora una volta la musica era pronta a registrare la paura del conflitto nucleare con diverse gradazioni di intensità. Ora più di prima. Blondie cantava Atomic Bomb (1980) giocando sull’ambivalenza del concetto di atomico (nel senso di bello e disarmante). L’anno prima i Clash in London Calling dichiaravano di non aver paura dell’era atomica («A nuclear era, but I have no fear») e nel 1980 gli Orchestral Manouvres in the Dark lanciavano uno dei singoli più suonati di sempre Enola Gay, il cui segreto del successo consisteva in quel suo incedere drammatico affidato alla voce di Andy McCluskey e nell’uso insistente di parti strumentali eseguite da sintetizzatori e drum machine che segnano uno dei momenti più esaltanti del pop anglosassone.
Il titolo, come è noto, si riferisce al nome del bombardiere statunitense e il testo cita alcuni termini usati dalle forze statunitensi durante la missione su Hiroshima. Non ci soffermeremo sulla pletora di titoli che partoriti dal mondo del pop rock e della new wave descrivono i timori del mondo intero sull’orlo dell’apocalisse. Il web offre elenchi ragionati di ogni tipo. Mentre rimandiamo al bel libro di Fabio De Luca Oh, oh, oh, oh, oh, i Righeira, la playa e l’estate del 1983 (Nottetempo, 2023) che racconta il posizionamento della scena musicale nostrana nel contesto internazionale partendo dall’analisi dettagliata di un brano simbolo di quel decennio, Vamos a la Playa dei Righeira. Il pezzo è un bagno nel ghiaccio bollente al confronto con i sonnacchiosi ascolti dei giovani italiani nell’estate del 1983, insieme a un altro tormentone Tropicana del Gruppo Italiano, la band capitanata da Raffaella Riva e Patrizia Di Malta.
Tropicana fu un inno alla radio nel giorno della grande manifestazione a Roma il 22 ottobre 1983 contro l’istallazione dei 112 missili cruise nella base di Comiso. Vamos a la playa aveva ottenuto il maquillage dei fratelli Michelangelo e Carmelo La Bionda, i produttori di Amanda Lear dal 1974 e chitarre ritmiche nell’album Volume 8 di Fabrizio de André (tra le infinite cose di cui furono protagonisti). I La Bionda ne fecero un successo assoluto progettando un singolo scanzonato e orecchiabilissimo di cui si ricorderà addirittura Madonna in una trasmissione televisiva, appena incoronata reginetta del pop con il brano Holiday. In realtà l’originale di Johnson Righeira realizzato nel 1981 era una lugubre rievocazione di una spiaggia radioattiva su un motivetto cupo di 4 note in modo minore poi genialmente sostituito da un’intro giuliva nella versione del 1983. Futurismo, Kraftwerk, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, la disco di Chic, Spargo, il funky dei Temptations, i Parliament, le canzoni dell’estate alla Peppino Di Capri (Saint Tropez) e Edoardo Vianello (Abbronzatissima, Guarda come dondolo) erano i riferimenti stesi al sole su quella spiaggia che non era il paradiso del boom economico bensì la landa del nucleare.
Non fu l’abbronzatura atomica del Gruppo Italiano né la sabbia fluorescente dei Righeira a portar via i missili da Comiso. Non è facile dire cosa abbia pesato di più nello sciogliere la crisi; di certo la soluzione fu agevolata dalla morte di Breznev e dalla nomina, dopo i brevi mandati di Andropov e Cernenko, di Mikhail Gorbaciov. Tra lui e i vertici occidentali si riaprì il dialogo sul disarmo come auspicato dagli Squallor in USA for Italy: «Caro Bob Dylan, tu che canti in casa Reagan quando c’è Gromiko oppure Gorbaciov, i soldi di quattro teste nucleari, falli mandare qui, for Italy». L’8 dicembre 1987 a Washington Gorbaciov siglò con Reagan il trattato Inf che imponeva lo smantellamento di tutti i missili a raggio intermedio, mettendo l’Europa al sicuro. Fino ad oggi.
IN QUEI MINUTI
Nel 2007 non c’erano nuvole radioattive all’orizzonte eppure i Linkin Park chiamano il loro album Minutes to Midnight, i minuti che mancano alla fine del mondo causata da un conflitto nucleare, esplicito riferimento al Doomsday Clock, l’orologio del giorno del giudizio tenuto e aggiornato dal Bulletin of the Atomic Scientists, un’organizzazione che ha avuto Albert Einstein tra i suoi fondatori e che offre memoria storica e previsioni sulla minaccia nucleare.
Il 2 agosto 2019 Trump, con la Cina nel mirino, formalizza il ritiro degli Usa dal trattato Inf, abbattendo uno degli ultimi simboli della pace faticosamente raggiunta mentre il conflitto ucraino ci ricorda che le armi nucleari sono ancora lì, un demone dormiente nei missili e non un oggetto ornamentale dal gusto vintage. E torna la paura. La differenza col passato è il rapporto tra potenze che sembrano aver smarrito la capacità di parlarsi: le rivalità nazionalistiche sono un fatto nuovo, nella Guerra fredda il confronto era anzitutto ideologico e le popolazioni di Usa e Urss si vedevano reciprocamente come vittime dei sistemi comunista e capitalista, conservando ancora una certa vicinanza: non troppi anni prima avevano combattuto insieme il nazismo. Oggi, la Russia non è stata invitata da Macron per la commemorazione dello sbarco in Normandia.
Zaccaria ricorda che nel 2021 durante le manifestazioni di protesta in Bielorussia contro il presidente Lukashenko, i ragazzi in piazza gridavano i versi di Peremen (Cambiamento) uno dei brani più celebri di Tsoi: «Cambiamento! chiedono i nostri cuori/Cambiamento! chiedono i nostri occhi/Nelle nostre risate e nelle nostre lacrime/E nelle pulsazioni che attraversano le vene/Aspettiamo il cambiamento». Oggi, la scena musicale russa è del tutto diversa, il nazionalismo dei gruppi trap e rap è un dato acclarato, si tessono le lodi del presidente Putin e della potenza militare russa. Yaroslav Dronov, 32 anni, più noto come Shaman, è una delle popstar russe più famose dopo l’invasione dell’Ucraina. A settembre dell’anno scorso anziani e giovani accorsero alla Gazprom Arena, lo stadio principale di San Pietroburgo (la città di Putin, non già la Leningrado di Tsoi), in attesa dell’arrivo dell’idolo, creatura della propaganda del Cremlino, almeno a detta di molti osservatori critici. Le sue canzoni nazionalistiche sono state utilizzate per galvanizzare i russi attorno alla bandiera e rafforzare il sostegno all’invasione. Nel frattempo, i fan di Shaman (sciamano, in inglese) apprezzano i suoi testi perché trasudano orgoglio nazionale in un momento in cui il paese affronta un isolamento politico e culturale senza precedenti in Occidente. Alcuni avevano la bandiera russa dipinta sulle guance, mentre altri indossavano il drappo giallo, nero e bianco dell’Impero russo e intonavano le parole di Ya Russky (Io sono russo), il titolo della canzone più popolare dell’artista. Durante il concerto del 4 novembre 2023 a San Pietroburgo, giornata dell’unità nazionale, Shaman ha concluso la canzone premendo simbolicamente il «bottone rosso» di una finta valigetta nucleare, dando il via a uno spettacolo pirotecnico.
All’indomani dell’attentato alla Crocus City Hall, il musicista in un video postato sul social network russo VKontakte si è rivolto ai suoi 600mila follower offrendosi di pagare i funerali delle vittime in nome della solida unità nazionale alla quale ci si appella costantemente in questi anni di guerra: «Tutti i problemi e le disgrazie hanno sempre unito il nostro paese. Rendono la Russia sempre più forte. Neanche adesso sarà possibile intimidirci. Siamo tutti una grande famiglia». Le voci di dissenso sembrano timide e arrivano a noi attraverso canali trasversali. Chi non supporta la linea del presidente Putin, come il trapper Husky, ostile alle politiche del Cremlino e alla guerra in Ucraina, viene duramente censurato. Ricordiamo l’ondata di cantanti arrestati e di concerti annullati nel 2018. Stesso discorso per le Pussy Riot collettivo femminista rigorosamente anonimo, impegnato nella diffusione della cultura della democrazia, la cui vicenda giudiziaria che portò in carcere alcune di loro nel 2012 ha tenuto alto l’interesse in tutto il mondo occidentale.
* Parte di questo articolo è tratto da «Oppenheimer, Putin e altre storie sulla bomba», di Francesco Dall’Aglio e Carlo Ziviello (Ad Est dell’equatore, Napoli 2023).