Il 3 febbraio 2018 papa Francesco ha proclamato beato il partigiano Teresio Olivelli, definendolo «martire in odio della fede». Lo ricorda Alessandro Santagata in un libro (Una violenza “incolpevole”. Retoriche e pratiche dei cattolici nella Resistenza veneta, Viella, pp. 328, euro 28) che si segnala per avere posto all’attenzione dei lettori una questione fin qui relativamente trascurata: cosa significò per i cattolici imbracciare un fucile e uccidere nel quadro della guerra civile? Quanto contò la fede nel determinare le scelte e la «moralità» dei partigiani moderati in una regione storicamente conservatrice come il Veneto?
SANTAGATA privilegia un’area geografica non circoscritta (il padovano e il vicentino) e riparte da alcune osservazioni di Claudio Pavone, che in alcuni rapidi passaggi del suo classico lavoro sottolineava già come i moderati e i cattolici avessero giustificato il loro impegno nella Resistenza come esercizio di una «violenza incolpevole», dettata non dall’odio ideologico o di classe ma dal mero dovere di difendere la patria e la gente comune dall’occupazione del «barbaro» tedesco. E tuttavia, si può prendere alla lettera quest’icona del partigiano cattolico, che fu sapientemente edificata nel corso del conflitto e ribadita più tardi, nelle celebrazioni e nella memorialistica successive alla Liberazione? O la realtà fu ben più complessa?
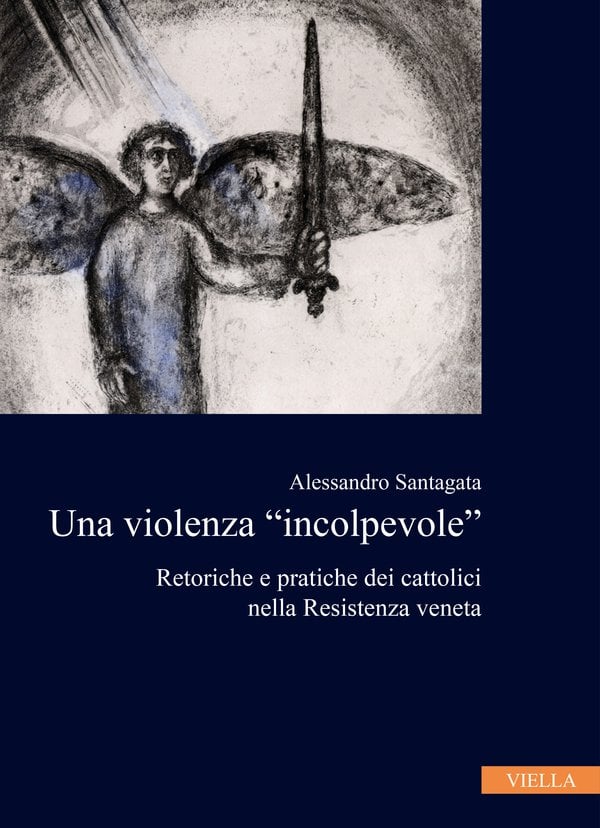
CON GRANDE FINEZZA Santagata sottolinea quanto il dubbio sulla legittimità di combattere abbia agitato uno schieramento che aborriva la categoria di guerra civile e fratricida; quanto abbiano contato nella costruzione del soldato cristiano non solo il modello militare alpino, ma anche la tradizione teologico-pastorale che distingueva la guerra giusta da quella illecita, il conflitto combattuto per vertigine del sangue dall’impegno asettico proprio del cristiano combattente. Uccidere, certo, in qualche caso si doveva; ma come insegnava una catechesi risalente a sant’Agostino, il soldato cristiano in guerra doveva operare alla stregua di un chirurgo, senza odio per il nemico e senza provocare inutili violenze sui civili.
Su questo terreno si misura la polemica con le formazioni garibaldine e con la presunta tendenza dei comunisti a ignorare le reazioni innescate da mosse troppo avventate. Il dibattito sulle sanguinose rappresaglie nazifasciste, com’è noto, attraversa da sempre la memoria divisa della Resistenza; ma Santagata cala le controversie nel fuoco della lotta partigiana in Veneto, mettendo in luce non solo le diverse posizioni della gerarchia e del clero (e il ruolo dei cappellani a fianco dei partigiani), ma i dubbi che agitarono i cattolici e la loro lungimiranza nel percepire che i rapporti di forza all’interno del fronte antifascista avrebbero determinato le sorti politiche dell’Italia futura.
Se si vuole comprendere come si sarebbe costruita l’egemonia moderata nel Veneto (e nell’Italia) del dopoguerra è anche al modo di fare guerra dei partigiani cattolici che occorre guardare. E alla produzione a stampa del tempo, dove poteva leggersi che i cattolici ben capivano che non tutti gli italiani potevano mostrarsi coraggiosi; che la rivoluzione rossa era temuta da un universo di piccoli proprietari e di contadini imprenditori. Beninteso, vi furono cattolici che militarono nelle brigate Garibaldi (come Luigi Pierobon); che non esitarono a sparare, a sabotare e a manifestare odio verso i nemici. E che invocarono la discontinuità sociale e istituzionale con il passato. Ma a prevalere furono la retorica del combattente per amore e del fedele patriota che lotta per il secondo Risorgimento, nonché un anticomunismo ben evidente già nei lunghi mesi della Resistenza.
PIÙ TARDI, a guerra finita, mentre il clero tuonava contro le vendette e Pio XII individuava nel partito cattolico l’argine al bolscevismo, i vertici della Dc seppero fare uso di questa visione della Resistenza per guadagnare egemonia, disinnescando le aspettative palingenetiche che pure la guerra partigiana, con il non marginale contributo dei cattolici, aveva acceso. E se le gerarchie trasfigurarono la lotta antifascista dei cattolici come sacrificio e come martirio, se il ruolo attivo delle donne nella lotta partigiana fu quasi occultato (si pensi a Ida d’Este, di cui si riportano vibranti passi dal suo Croce sulla schiena), la strategia dei vertici della Dc e della Chiesa romana riscosse un indubbio successo, indebolendo il fronte antifascista che pure insieme aveva combattuto. Mentre il culto dei caduti si configurava come ricordo-espiazione per il male destoricizzato del fascismo, al cui consolidamento la Chiesa aveva contribuito.

