Quella sobria cura della verità
Teoria critica Pubblicati da Aragno gli scritti di Tito Perlini, uno dei più importanti studiosi della «Scuola di Francoforte» e del nichilismo. Ma anche originale filosofo che ha operato per sganciare il marxismo dallo storicismo
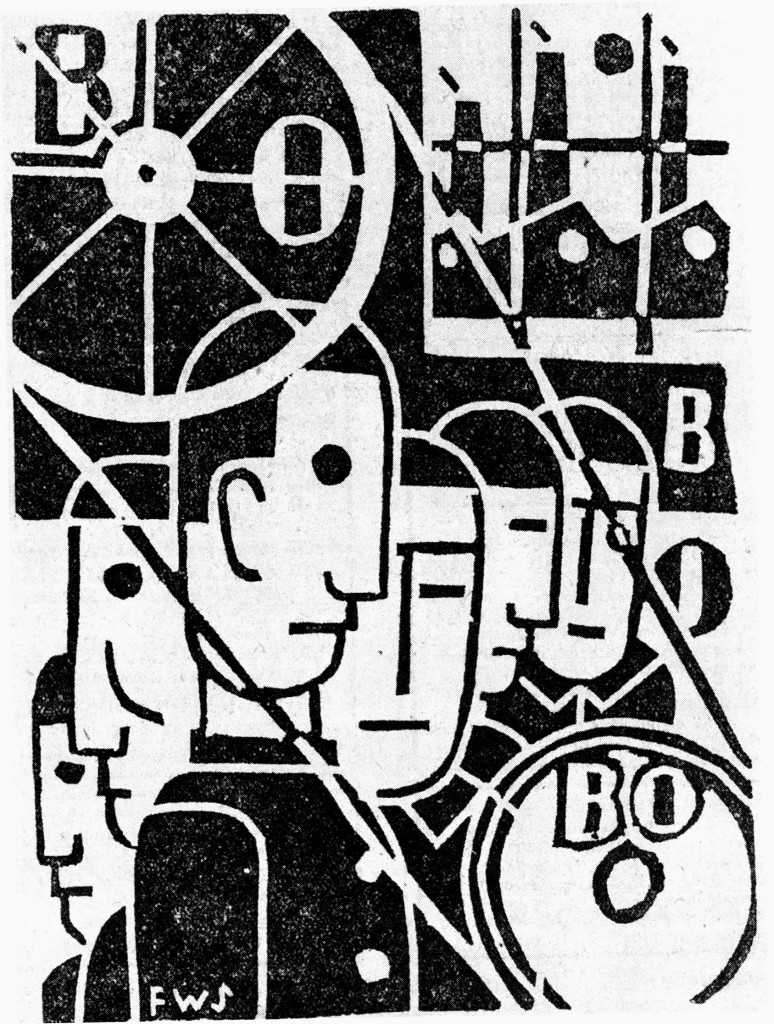 Un’opera di Franz Wilhelm Seiwert
Un’opera di Franz Wilhelm SeiwertTeoria critica Pubblicati da Aragno gli scritti di Tito Perlini, uno dei più importanti studiosi della «Scuola di Francoforte» e del nichilismo. Ma anche originale filosofo che ha operato per sganciare il marxismo dallo storicismo
Quello dell’intellettuale critico e non conformista non è mai stato un mestiere facile. Uno che lo ha praticato con coerenza e lucidità dagli anni Sessanta del Novecento fino alla sua scomparsa avvenuta nel 2013 è stato Tito Perlini, di cui esce in questi giorni, per l’editore Aragno, una cospicua raccolta di scritti (Attraverso il nichilismo. Saggi di teoria critica, estetica e critica letteraria, prefazione di Claudio Magris, introduzione e cura di Enrico Cerasi, pp. 800, euro 40). L’itinerario intellettuale di Perlini, che l’ampia raccolta consente di ripercorrere nel suo complesso, è stato molto interessante e singolare. Perlini, che era nato a Trieste nel 1931, appartiene infatti a quel gruppo di studiosi italiani che, verso la metà degli anni Sessanta, scoprirono e importarono nel nostro Paese le tematiche della Scuola di Francoforte, allora sconosciute ai più e, anche in Germania, note molto parzialmente.

A frequentare intellettualmente e anche fisicamente Francoforte furono, in quegli anni, studiosi come Renato Solmi (di cui Quodlibet ha appena ripubblicato l’Introduzione del 1954 ai Minima moralia di Adorno), Furio Cerutti, Carlo Donolo, Gian Enrico Rusconi, che tutti diedero un contributo alla ricezione italiana del francofortismo. Ma il lavoro che, in questo campo, fu svolto da Tito Perlini, ebbe un’ampiezza senza pari.
Libertario e antiortodosso
Il punto fondamentale della questione si può ricordare in poche parole: nella ripresa del pensiero critico e nel contesto del rinnovamento della discussione marxista degli anni Sessanta, alcuni intellettuali italiani (molto diversi l’uno dall’altro per gusti e formazione) videro nella elaborazione dei francofortesi e degli autori ad essi vicini (soprattutto il giovane Lukacs ed Ernst Bloch) l’unica via teoricamente aperta per proporre un marxismo che fosse intellettualmente avanzato e politicamente libertario e antiortodosso. Ciò significava rompere con lo storicismo degli intellettuali legati al Pci, rifiutando però anche, al tempo stesso, quei tentativi di rinnovamento dove la sostanza critica e dialettica del pensiero di Marx, la sua radicalità emancipativa andava perduta: e cioè il dellavolpismo in Italia (nemico acerrimo del francofortismo) e l’althusserismo in Francia.
Molto più complesso e meno in bianco e nero era il rapporto con l’altra grande operazione di rinnovamento del marxismo italiano, e cioè l’operaismo, soprattutto di Panzieri. Qui infatti non vi era culturalmente una così radicale distanza dal francofortismo; le differenze passavano piuttosto sul piano dell’analisi sociale, perché mentre il francofortismo metteva al centro delle sue riflessioni i temi dell’industria culturale e della manipolazione consumistica, l’operaismo enfatizzava le nuove potenzialità conflittuali della classe operaia italiana.
In dialogo con le avanguardie
Tra questi diversi tentativi di rinnovamento il francofortismo era, almeno sul piano della teoria generale e filosofica, quello di gran lunga più attrezzato, perché, mentre riscopriva la genuina sostanza dialettica di un Marx letto insieme con Hegel, cercava di portarlo a fusione con tradizioni teoriche totalmente diverse; non solo Freud, ma anche Nietzsche, di cui i francofortesi evidenziavano la spietata lucidità critica, mentre per altri restava ancora un tabù. E poi, il francofortismo riusciva anche a parlare ai movimenti, come dimostrò, a un certo punto, l’incredibile successo del Marcuse de L’uomo a una dimensione, di Eros e civiltà, di Psicanalisi e politica, che proponeva un linguaggio dove si saldavano perfettamente emancipazione sociale e liberazione individuale.
I libri e i saggi di Tito Perlini furono uno strumento intellettuale molto utile nella stagione «euforica» tra la fine degli anni Sessanta e i primi Settanta. Il suo approccio teneva insieme teoria critica ed estetica; e valorizzava perciò anche un’altra grande peculiarità del pensiero francofortese, la capacità di interagire con la letteratura d’avanguardia (e la grande musica) del Novecento. L’autore sul quale Perlini dette il meglio di sé fu senza dubbio Adorno; e gli aspetti della sua filosofia che Perlini decifrò e discusse con maggiore penetrazione furono la Dialettica dell’illuminismo e l’estetica.
Non aveva torto, perché effettivamente è in questi due poli che si raccoglie il meglio della produzione adorniana. In un breve giro di anni cruciali a cavallo tra i Sessanta e i Settanta Perlini scrisse e pubblicò una quantità impressionante di pagine: in una buona collana di alta divulgazione dell’editore Ubaldini, che si chiamava «Che cosa ha veramente detto», apparvero nel 1968 i volumi dedicati a Kierkegaard e a Marcuse, nel 1971 quello su Adorno; anche se il più bello e pionieristico lavoro adorniano di Perlini resta il saggio Autocritica della ragione illuministica, che apparve nel 1969 sulla rivista «Ideologie» e che avrebbe meritato di essere incluso nella raccolta ora pubblicata. Sempre nel solco di questa impressionante produttività Perlini pubblicava, nel 1968, un ampio studio lukacsiano (Utopia e prospettiva in Gyorgy Lukacs, Dedalo, Bari); nel ’71 e nel ’74, per le edizioni Accademia, uscivano due profili dedicati rispettivamente a Lenin e a Marx: un Marx libertario e «utopico», antitetico rispetto a quello degli storicisti e degli strutturalisti.
L’emancipazione che non c’è

Ovviamente, in una così grande mole di lavoro vi sono cose più riuscite e altre meno, ma resta il fatto che Perlini ha dato un apporto primario alla conoscenza di temi e approcci teorici fondamentali, che ha percorso e indagato come pochi. Questa particolarissima stagione, però, va poi gradualmente a chiudersi. La dialettica sociale si spegne, la stagione dell’emancipazione tramonta, il clima intellettuale cambia completamente, arrivano il pensiero debole e il postmoderno. Che ne è allora del pensiero critico, e in particolare di quello d’impronta francofortese? Qui il discorso si fa più complicato. Se non riusciamo a cambiare il mondo, dobbiamo cambiare noi? E come? I percorsi degli intellettuali critici in questo passaggio di fase non sono semplici: c’è chi muta bandiera, chi lascia le vecchie strade per cercare direzioni di ricerca differenti. E chi, seguendo il modello habermasiano, si dedica pazientemente a capire cosa non funzionava nel pur affascinante modello dell’emancipazione dialettico-critica francofortese.
Tito Perlini (e anche qui sta la sua originalità) non abbraccia nessuna di queste vie d’uscita. Non quella della autoriflessione critica (e qui secondo me sbaglia, perché bisognava pur capire cosa non aveva funzionato), non quella del «pentimento». Non prende neppure la strada del silenzio, anche se la sua presenza è, dagli anni Ottanta, molto più discreta. Continua invece, come mostrano i saggi raccolti in Attraverso il nichilismo, a pensare sobriamente sulla linea della teoria critica.
Umanismo autoironico
Esemplare, da questo punto di vista, è uno degli ultimi saggi, Verità relativismo relatività, dove da buon dialettico Perlini prima demolisce senza pietà quello che chiama il «relativismo volgare», poi difende ciò che vi è di valido in tutte le relativizzazioni del nostro sapere, a cominciare da quelle che si fondano sulla prospettiva antropologica, e infine conclude che l’atteggiamento più onesto è quello di prendersi cura della verità, nella consapevolezza che cercarla è una cosa, possederla un’altra. Intenso è il confronto anche col nichilismo nicciano, che il dialettico Perlini non esorcizza ma attraversa fino in fondo, mettendone in risalto ambiguità e contraddizioni. Ben lontano è però Perlini dallo sposare Nietzsche o l’uso che ne hanno fatto i postmoderni; perché la sua prospettiva rimane, come scrive con espressione felice, quella di un «umanismo fragile e autoironico».
Non manca però, soprattutto nell’ultimo Perlini, anche un avvicinamento a filosofi che, probabilmente, ad Adorno sarebbero riusciti molto indigesti. Perlini si accosta decisamente, infatti, alla critica della modernità formulata dal pensatore cattolico Augusto Del Noce: per cui quella contemporanea sarebbe ormai una non-società, tecnocratica e «naturalmente irreligiosa», dove si sono realizzate tutte le negazioni di cui il marxismo era portatore, ma senza la parte propositiva che lo caratterizzava.
Le riflessioni di Perlini su Del Noce non sono prive di interesse e anche di forza di provocazione. Per quanto mi riguarda, però, continuo a preferire il Perlini adorniano; è nel confronto col grande francofortese che il filosofo triestino ha dato il meglio di sé e ha scritto pagine che resistono all’usura del tempo.
I consigli di mema
Gli articoli dall'Archivio per approfondire questo argomento
