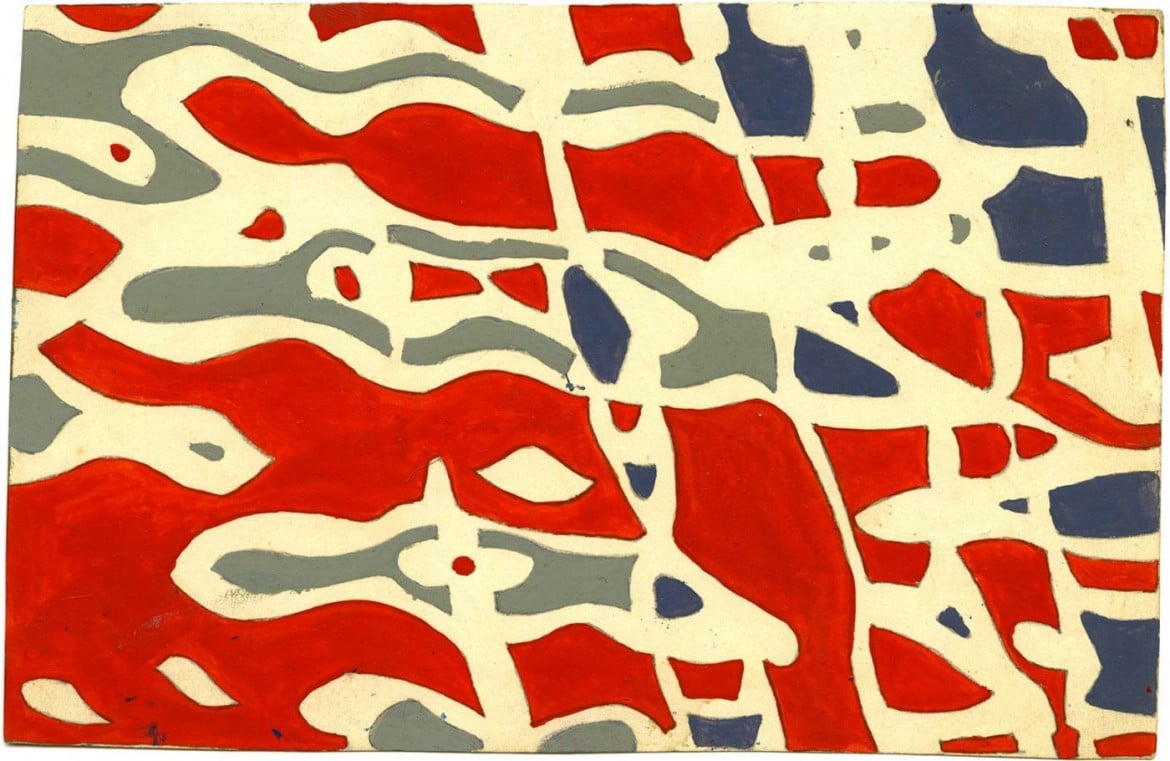Secondo una idea pericolosa, ancora oggi dominante, la funzione evolutiva ed etico-politica del linguaggio consisterebbe nel comunicare informazioni. Simili a navette aeroportuali, le parole trasferirebbero bagagli psichici preconfezionati da un terminal all’altro, cioè dalla mente del parlante a quella dell’ascoltatore. Il che significa considerare le parole come etichette da incollare su misteriosi pensieri preverbali che non si sa da dove trarrebbero il loro significato (dall’istinto? dall’anima?).
A questa semplificazione se ne contrappone spesso una seconda che, suo malgrado, integra la prima: la convinzione, diffusa tra i critici del capitalismo neoliberale, che contro la riduzione della parola a veicolo informativo sia opportuno insistere sulla purezza della poesia. Solo il verso ispirato funzionerebbe da antidoto contro il lavoro linguistico che caratterizza l’automatismo del call center o le ingegnose peripezie della formazione permanente. Peraltro, anche l’esaltazione che fa Noam Chomsky, della creatività propria di ogni atto linguistico sembra andare nella direzione di chi allude a una misteriosa capacità innovativa di tipo universale.
In un panorama così intricato l’ultimo libro di Daniel Heller-Roazen, Lingue oscure L’arte dei furfanti e dei poeti (Quodlibet, pp. 237, euro 19,00) è uno strumento formidabile, che si serve di una splendida silloge di esempi. Tra questi, un manoscritto del XV secolo, caso classico e, insieme, sorprendente in cui emerge il gergo clandestino di un gruppo criminale processato nel 1455. Il «linguaggio raffinato» è utile a garantire la segretezza di intenti dei «Coquillars», i «compagni della conchiglia», una banda di scassinatori e vagabondi. Quel che scopre Marcel Schwob, il linguista che nel 1890 si mette sulle tracce di questo idioma da malfamati, illumina di senso due forme d’uso che fino a quel momento sembravano tra loro estranee: la rapina e la poesia. Dai nomi deformati della banda attinge François Villon, nelle cui ballate arrivano a cinquantotto i termini nei quali la parlata del brigante si sovrappone all’arte del poeta.
Del resto, il linguaggio che si presta a un duplice uso non è affatto un’eccezione: ce ne sono esempi ovunque. Per sfuggire all’orecchio di rivali o carcerieri, «l’arte della pinza e del piede di porco» sfrutta variazioni lessicali di uno stesso termine oppure altera il profilo sonoro della parola. Oggi, nel gergo metropolitano della capitale la cannabis diventa «drella», «miccia», «canna», «bomba», mentre il verlan francese inverte «fumer» in «méfu», «moi» in «ouam». Un diverso caso è il celebre indovinello della Sfinge che chiede a Edipo quale sia la «creatura che cammina con quattro gambe al mattino, due durante il giorno e tre la sera»: un esempio istruttivo, secondo Heller-Roazen, perché riabilita l’indovinello, che non è un genere espressivo riducibile al divertimento infantile, bensì il gioco linguistico tramite il quale dare rappresentazione della parlata di chi non appartiene alla nostra specie.
Ecco che il puzzle di Heller-Roazen comincia a profilare la sagoma di una soluzione. L’argot dei furfanti di Francia, la lirica sublime dei «trovatori» o il risolutore di enigmi teologici manifestano un tratto distintivo della stessa facoltà, la facoltà di linguaggio. Per lodarne la potenza, si sottolinea di solito la possibilità propria della parola di segmentare discorsi per unirli in combinazioni inedite. Quando il parlante in erba scopre che la frase «Paolo mangia la pastiera» può esser rovesciata in «La pastiera mangia Paolo», gli si dischiude un orizzonte di combinazioni verbali inesauribile. Anche quando il linguaggio svolge una funzione comunicativa lo fa alle dipendenze di usi delle parole pratico-conflittuali; gli usi informativi (ad esempio fornire le coordinate che indicano la presenza della polizia nel centro città) sono impiegati da alcuni parlanti a scapito di altri. Il caso più eclatante, trascurato dalla linguistica di marca chomskyana o computazionale, è costituito dalla varietà delle lingue storico-naturali.
Se compito del linguaggio fosse trasmettere informazioni, perché affidarsi a istituzioni così divisive come le lingue? Ai parlanti d’oltralpe, l’italiano appare più estraneo del guaito canino, visto che il Labrador o il Golden Retriever emettono il medesimo verso tanto a Torino che a Parigi. Altrettanto errato sarebbe fare dell’oscurità la marca del sommo poeta e delle sue aristocratiche intenzioni espressive, tentazione che ha perseguitato anche grandi linguisti. Tra il 1906 e il 1909, racconta Heller Roazen, Saussure dedicò addirittura «novantanove quaderni» all’illustrazione di «una speciale conoscenza», tramandata in segreto, che avrebbe accomunato i poeti indoeuropei.
L’ossessione per gli anagrammi criptati non trae origine solo da una tendenza paranoide. Affonda le radici in un errore filosofico: ritenere che la funzione poetica del linguaggio, così la chiama Roman Jakobson, coincida con un sapere specializzato o con la raffinatezza di una classe sociale baciata in fronte dal genio della lingua. Poeticità sublime dell’espressione verbale e segmentazione conflittuale della massa parlante, ribadisce Heller-Roazen, sono l’alfa e l’omega della capacità di prendere la parola.
Se il criminale, per salvare la pelle, fa un uso poetico della lingua, il poeta – dal canto suo – è un criminale in miniatura perché divide l’uditorio tra chi può comprenderlo e chi non può, usando armi espressive prossime a quelle del brigante. Lungi dall’esser strumento di concordia universale, anche la poesia è arte della divisione.