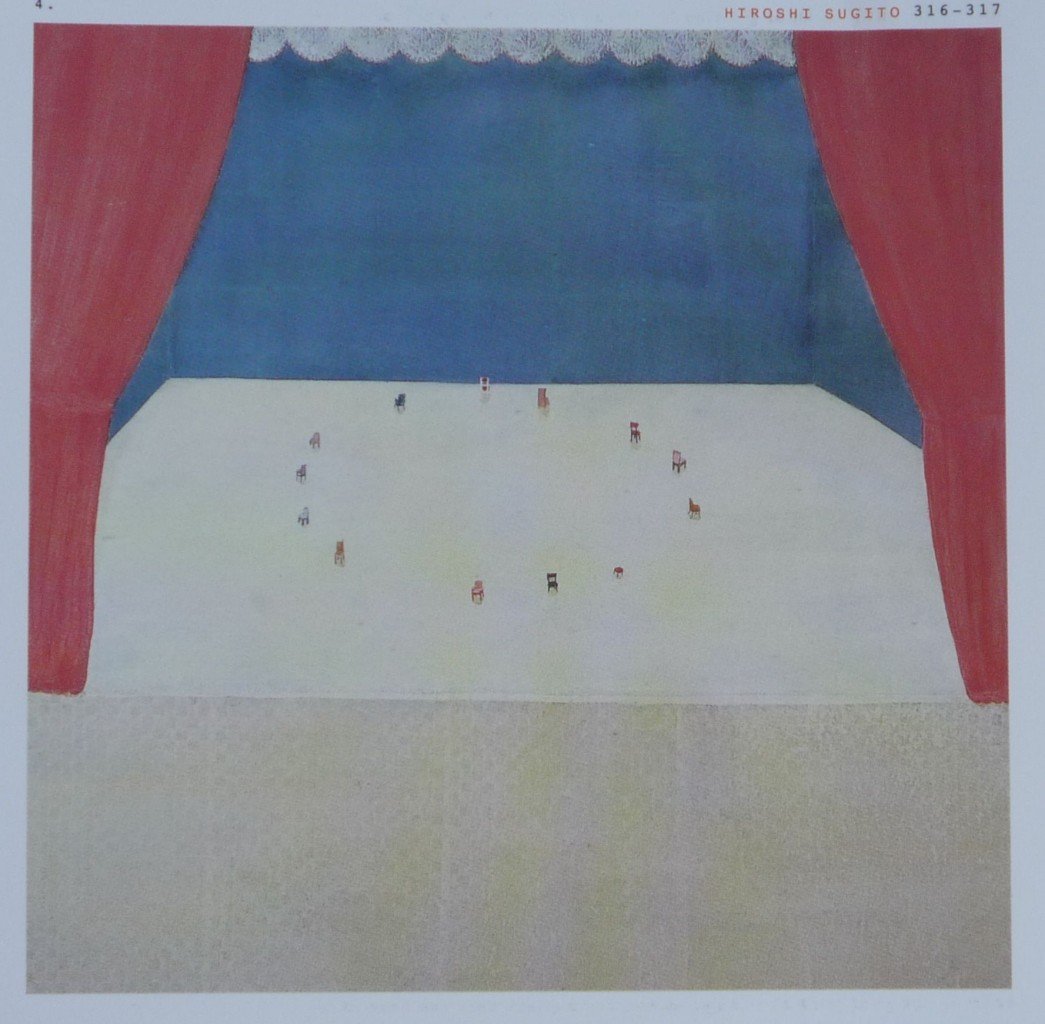Ormai in tarda età, lo scrittore Choko Kogito vuole mettere insieme un romanzo sul proprio padre e per farlo si affida al contenuto di una valigia di pelle rossa a lungo custodita dalla madre. La storia del padre di Choko risale alla Seconda guerra mondiale, ne condivide i tanti punti oscuri, e scriverne si rivelerà per lui un’ardua impresa. Il riferimento diretto del protagonista dell’ultimo romanzo di Oe Kenzaburo, La foresta d’acqua (traduzione di Gianluca Coci, Garzanti, pp. 480,€ 25,00) a una storia familiare sembrerebbe un tentativo di legittimare il racconto che segue, innestandolo in una narrazione già coesa la cui autorità, però, interrompe il discorso, fa per dominarlo, talvolta ci riesce e sempre e comunque lo influenza.
I familiari dell’Io narrante si propongono al lettore in modo didascalico, a volte con un linguaggio incongruo al parlato, semmai più consono alla forma scritta: «Ultimamente non mi pare che tu abbia così tanti impegni – dice la sorella Asia al protagionista –. Per quanto ne sappia, hai smesso di scrivere romanzi e ti occupi solo di una rubrica mensile per un noto quotidiano nazionale, o sbaglio?».
Autocitazioni a fantasia
La strategia narrativa di Oe mira a generare distanza, impedendo al lettore di immergersi nella storia e identificarsi con i personaggi: è un tentativo di difendere quelle barriere e quegli intervalli necessari a una lettura raziocinante e oggettiva. Al tempo stesso, proprio per contrastare la linearità derivata dal dominio di un’autorità narrante imposta al romanzo, l’autore ricorre all’espediente della rivelazione infantile, la visione della «morte per acqua», introdotta sotto forma di sogno fatto all’età di dieci anni e rincorsa poi nella sofferta gestazione del «romanzo» che ossessiona Choko. Simulacro del principio di simultaneità che unisce passato e futuro nel presente, esso è affine al tempo messianico nell’accezione di Benjamin, che scardina il mito borghese del romanzo come genere autoreferenziale e lo colloca in una dimensione altra, più ampia e inclusiva.
La stessa volontà di spezzare qualsivoglia principio di autorità narrante si legge anche nella commistione, a volte confusiva, di reale e fittizio, dove elementi autobiografici dei quali l’autore è certo che il suo pubblico abbia contezza – i titoli di precedenti opere di Oe, l’ambientazione nell’isola di Shikoku e la figura di Akari, il figlio disabile del protagonista, tra i più emblematici – privano l’io narrante di solidità conferendogli un senso del reale intermittente, che mette in crisi il metro di giudizio del lettore e lo incoraggia a riflettere sulla dissoluzione dell’umanità tra le maglie coercitive della storia.
Sembrerebbe dunque che in questo romanzo Oe Kenzaburo tenti per l’ennesima volta di superare il disagio che ha sempre caratterizzato, come affermò lui stesso durante il discorso di accettazione del Nobel nel 1994, il suo rapporto con la famiglia, con la società giapponese e con l’esperienza di vivere nella seconda metà del ventesimo secolo. Prendendo in prestito le parole di Nils Holgersson al termine del suo meraviglioso Viaggio, «Papà e mamma, sono grande, sono di nuovo un essere umano!», Oe attribuiva alla scrittura un’importante funzione, quando non salvifica o catartica, sicuramente formativa. Scrivere è sempre stato, per lui, strumento essenziale di una ricerca volta a decifrare e possibilmente superare il disagio.
Per questo, continuava nel discorso all’Accademia di Svezia, i suoi romanzi presentano un nucleo autobiografico che si fa punto di raccordo tra la propria storia personale e i confini del mondo, oggetto di meditazione continua; d’altronde Oe è uno degli intellettuali giapponesi più dichiaratamente engagé, che poco (troppo poco, forse) si concede a letture critiche e dove la componente etica si dissolve in quella estetica trasfigurando i problemi e sacrificando l’impegno a quella che, a suo avviso, è mera ricerca di consenso; da ciò deriva la sua sfiducia nel romanzo giapponese contemporaneo e in particolare negli autori di maggiore successo: Murakami Haruki e Yoshimoto Banana.
Tutto, in questa come nelle altre opere di Oe, è subordinato a un’inflessibile etica del romanzo, finalizzata a recuperare il senso di un’umanità perduta. Il titolo originale, ripreso in altre traduzioni tra cui quella inglese, è La morte per acqua, citazione del quarto canto della Terra desolata, in cui T.S. Eliot racconta un corpo morto e vivo al tempo stesso, che affiora e affonda attraverso i diversi stadi della vita: Phlebas è dimentico di «profitto» e «perdita», mentre Eliot ricorre alla dimensione mitica per piegare la retorica del moderno capitalismo alla ricerca di una dimensione metastorica, antica, umana.
Le nostre storie parziali
All’affiorare e affondare del corpo del Fenicio corrisponde, nel romanzo di Oe, la caratterizzazione discontinua di Choko e della sua interiorità, la discrepanza tra la verbosità dei racconti che gli altri fanno di lui e l’immaterialità della visione che orienta la sua vita di scrittore e di uomo, i rallentamenti e le accelerazioni di un racconto dove il valore del tempo è più che mai relativo.
Con la realtà sospesa di Choko, dove il passato è nebuloso e il futuro incerto, coincide forse l’oggetto principale dell’impegno di Oe in questo romanzo: restituire al lettore lo spazio per una riflessione profonda sulla frammentazione della coscienza nel mondo contemporaneo, esortandolo a incrementare la propria consapevolezza di quanto parziali e strumentali siano le storie grazie alle quali vorrebbero legittimarsi le comunità in cui viviamo.