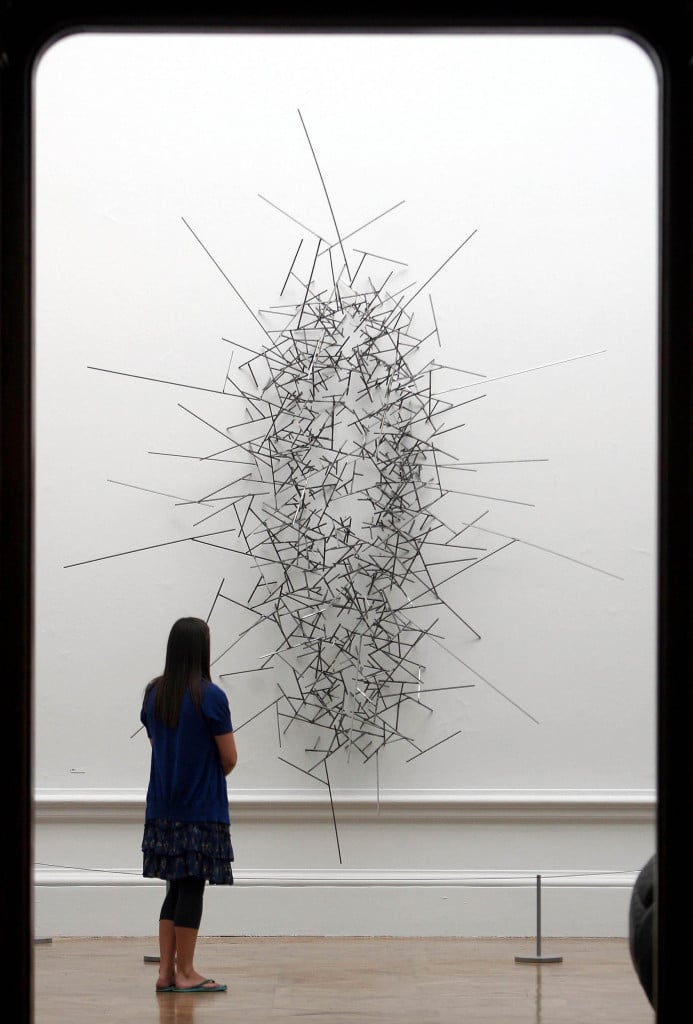Non ce la sfangheremo tanto facilmente. Ciò che più offende i molti, a conti fatti, è l’interdizione, nel discorso pubblico, dal mero insulto gratuito. Quell’invettiva liberatoria che è tale non tanto per il target che – di volta in volta – viene identificato, bensì per il bisogno di avere comunque un bersaglio contro il quale esercitare, in maniera apotropaica, i propri riti di sublimazione, depurazione, bonificazione. Se a tale riguardo parliamo poi del conflitto israelo-palestinese, la matassa, ad onore del vero, è molto complicata. Poiché somma in sé non solo corpi, massacri, carneficine ma anche, e soprattutto, antisemitismo, antisionismo, islamofobia, delegittimazioni, de-umanizzazioni al pari di immaginari geopolitici non meno che fantasie mitopoietiche. Quindi, illusioni come illazioni, insieme a molto d’altro. Il tutto condito dal bisogno di militanze, non importa di quale genere e a favore di chi.
DA DOPO I FATTI del 7 ottobre dell’anno scorso, e posto tutto quel che da ciò ne è conseguito a tutt’oggi, non solo il conflitto in sé ma, anche, e soprattutto, le necessarie distinzioni tra soggetti in campo (israeliani, palestinesi, ebrei, arabo-musulmani e così via), sono nel mentre saltate. Come in una sorta di macedonia universale, laddove tutto si confonde rabbiosamente, semmai eguagliandosi e raccordandosi solo nell’intercambiabile categoria di «vittima». Che è tale in quanto, al medesimo tempo, tanto ambiguo nonché appetibile rimando alla condizione di oppresso universale. Sempre e comunque. Tutto ciò, non a caso, ha generato una sorta di competizione che è parte stessa del conflitto in corso. La competizione ad essere «più vittima» degli «altri».
Poiché, ad oggi, sono elementi di uno scontro inconciliabile – in Medio Oriente così come nei paesi a sviluppo avanzato – non solo le questioni delle risorse, della terra, delle sovranità ma anche quella che rimanda al lemma «identità». Quest’ultima è infatti una parola tanto tagliente, quindi seducente, quanto ingannevole. Soprattutto laddove essa segnala comunque il bisogno di darsi, una volta per sempre, un riparo in confini certi, che siano individuali come collettivi, dalle temperie del mutamento costante, della trasformazione ineffabile, dell’angoscia dettata dall’imprevedibile. Ossia, in sé una sorta di difesa, non importa quanto illusoria, rispetto a quelli che sono altrimenti percorsi collettivi di impoverimento, defraudamento, disemancipazione, come anche di impotenza politica, che come tali attraversano il nostro tempo. Se nel passato si sarebbe detto che il patriottismo «è l’estremo rifugio delle canaglie» (Samuel Johnson, 1775) ad oggi il rimando al rapporto tra sovranismo e identitarismo è l’ultima trincea plausibile e praticabile di quanti si vivono come espropriati del proprio status sociale. Gli «ebrei», in tutto ciò, c’entrano molto. Poiché dal 1789 costituiscono uno dei paradigmi simbolici, loro malgrado, di quanto conosciamo come «modernità». Ossia, il combinato disposto tra trasformazione dei rapporti sociali di produzione della ricchezza e, a stretto seguire, spossessamento personale. Laddove quest’ultimo è il suggello delle diseguaglianze.
A CONTI FATTI – quindi – tra cambiamento e marginalità, ovvero tra modernizzazione ed emarginazione. Ne sono quindi, a modo proprio, una sorta di cartina di tornasole. Per una tale ragione, il rimando al volume di Piero Stefani e Davide Assael, Storia culturale degli ebrei (il Mulino, pp. 335, euro 26) può risultare utile. In quanto non introduce nuove categorie interpretative ma ragiona sul lungo calco di una relazione complessa, quella che fa sì che la maggioranza sociale e culturale (in questo caso costituita da non ebrei) venga immediatamente influenzata, nel suo manifestarsi storico, dalle minoranze. In una sorta di dialettica capovolta, dove l’indirizzo di fondo non è quello prescritto da un presunto comune sentire, quello per l’appunto manifestato da una «maggioranza silenziosa», bensì dall’eco potente dei gruppi ai margini. Come se questi costituissero dei segnavia, delle tracce lasciate sul terreno, oltre le quali c’è solo il vuoto per tutti. Detto questo, bisogna comunque tenere separati i diversi piani della riflessione, soprattutto se ci si esercita sul nostro presente. I quali rischiano, altrimenti, di soverchiarci, imbrigliarci e sbaragliare l’orizzonte della ragionevolezza. In sé si tratta di un’impresa tanto necessaria, nonché irrinunciabile, quanto – in franchezza – molto difficile. Poiché ciò che piace non è mai il piano inclinato dell’interpretazione della complessa realtà dei fatti bensì il suadente suono dei pifferai di turno. Se nella percezione dei protagonisti (ossia di coloro che in un conflitto armato ne sono direttamente chiamati in causa), tanti distinguo sono al limite dell’impossibilità, per chi osserva dall’esterno certi processi storici è invece imposto l’obbligo, se vuole essere in sé obiettivo, di non confonderli deliberatamente tra di loro.
ANALIZZARE E CAPIRE il tempo trascorso, così come quello presente, corrisponde esattamente a ciò. Quindi, allo sforzo non solo di cogliere le evoluzioni storiche e sociali, discontinue in quanto tali, bensì la necessità di non corrispondere, da subito, ad una posizione precostituita. Posto che essa soddisfi essenzialmente non tanto il riscontro oggettivo dei fatti bensì quello dei propri bisogni di identità. I secondi gabellati per il primo. Bisogni d’identità che spesso si definiscono non in termini positivi («io sono») bensì negativi ed esclusivisti («non voglio essere»). Nelle guerre, infatti, non necessariamente si cerca la migliore parte, posto che essa si dia a prescindere. Semmai ci si adopera per quella che meglio aderisce ai propri preconcetti. Al riparo di queste necessarie considerazioni, bisogna quindi sforzarsi di fare chiarezza. Soprattutto dal momento che il tutto si sovrappone, si mescola, quindi si confonde in un frullatore senza alcuna distinzione: israeliani, ebrei, semiti, palestinesi, arabi, musulmani e quant’altro. Detto ciò, la domanda di fondo non rimanda necessariamente a «chi è ebreo» ma a cosa ciò concretamente implichi, nel nostro tempo. Il libro di Sergio Della Pergola, Essere ebrei oggi (il Mulino, pp. 224, euro 16) si rivolge in tale senso. Quand’anche ebrei non si sia ma, del materiale esserlo, se ne faccia una qualche diretta esperienza. Poiché se è incontrovertibilmente riscontrato che le diverse definizioni di ebraicità, dall’Ottocento in poi completamente intrise di politicità, portano con sé un elevato grado di discutibilità, se non di mera fallacia, non è meno evidente che nell’immaginario collettivo di ciò che conosciamo – con un buon grado di etnocentrismo – come «Occidente», l’ebraismo sia divenuto il paradigma della sofferenza e, con essa, del «vittimismo».
In una sorta di cortocircuito totale tra realtà ed immaginazione. Si tratta, infatti, di una questione maledettamente complicata. In quanto gli «ebrei», come gruppo a sé stante, inteso quindi come tendenzialmente secessionista, pertanto potenzialmente sleale in quanto corporativo, comunque opportunista e separato, al pari di ciò che viene detto da una martellante propaganda propendente a presentarlo come tale – quanto meno dal 1789 in poi – nei fatti invece non esiste. È semmai il prodotto di una mera costruzione antisemitica.
COSÌ, TANTO PER CAPIRCI, scrive Gadi Luzzatto Voghera, che nel suo volume Sugli ebrei. Domande su antisemitismo, sionismo, Israele e democrazia (Bollati Boringhieri, pp. 144, euro 13,00), cerca di fare faticosamente luce nel buio, letteralmente navigando tra cliché, stereotipi, archetipi di antica o nuova genesi. Semmai, la persistenza, tra Ottocento e il nostro tempo, di una minoranza integrata, ci interroga sul significato di quello che rimane del pactum societatis, ovvero quell’accordo attraverso cui gli individui, tra di loro altrimenti diversi e distinti, liberamente danno vita ad una nuova entità giuridica, lo Stato unitario, capace di autonoma volontà e titolare di diritti e obblighi distinti da quelli dei singoli membri che lo compongono.
Poiché tra Ottocento e Novecento quel che conta non è la sopravvivenza di entità residuali, come invece potrebbe essere inteso lo stesso ebraismo, bensì il riscontro che la sua storica alterità possa altrimenti costituire una delle architravi della costruzione di un’identità collettiva. Non si tratta, a conti fatti, del medesimo perdurare di una minorità, altrimenti schiacciata dal rullo compressore degli eventi storici, bensì del riuscire a riconoscere come l’universalismo democratico sia composto anche del particolarismo di singole esperienze. Le quali, a conti fatti, sono l’unico ammortizzatore rispetto all’omologazione mercatista. Quanto meno ad oggi.