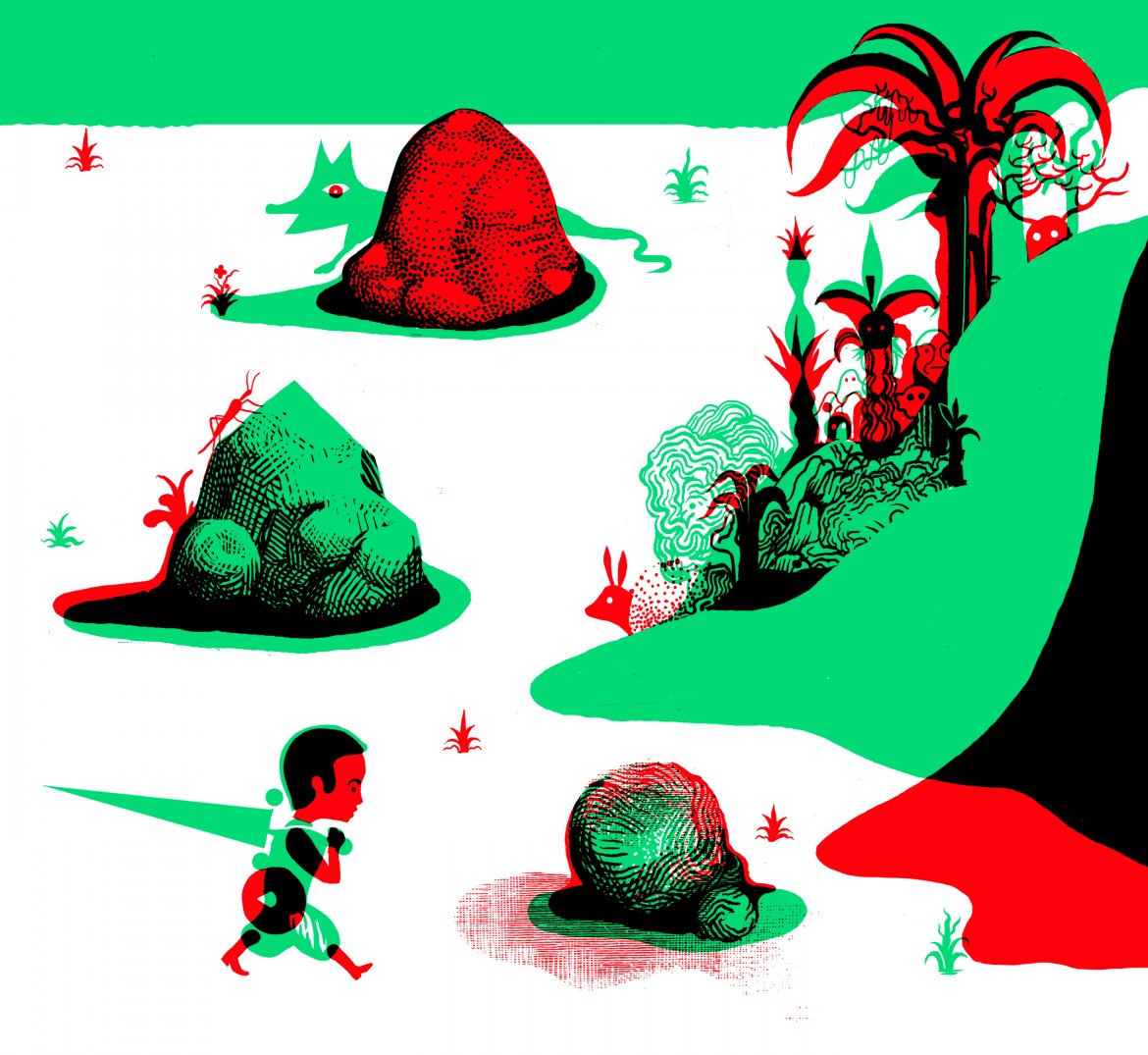A partire dalla crisi del 2008, le politiche dell’eurozona sono state un fallimento su tutti i fronti. Ora tutti gli sguardi sono rivolti al tempio della Banca centrale europea (Bce), in attesa di un miracolo del suo supremo sacerdote.
Dopo un dibattito, acceso quanto confuso, durato due settimane, seguito alla riunione dei capi delle banche centrali a Jackson Hole nel Wyoming, su come si dovesse interpretare l’oracolo di Mario Draghi, il responso è stato chiaro e inequivocabile.
Diamo uno sguardo alle due misure principali. La prima è un nuovo, simbolico, taglio di un decimo di punto (da 0,5 a0,05) del tasso di sconto principale, avvertendo che questo è l’ultimo.
La seconda misura è centrata sull’acquisto di Abs, «Asset-backed Securities»: in sostanza, obbligazioni emesse dalle banche, sulla base di pacchetti di prestiti alle imprese e alle famiglie. Questa misura, alla quale si aggiungono il possibile acquisto di titoli garantiti dalle banche («covered securities»), e la messa in atto dei prestiti diretti al finanziamento delle piccole e medie imprese, già decisa nei mesi scorsi, sono dirette a favorire l’espansione del credito.
I commentatori si sono chiesti se si tratti del famoso «Quantitative easing», sull’esempio delle Banche centrali degli Usa, della Gran Bretagna e del Giappone. E Draghi ha puntualizzato che è più corretto parlare di un «credit easing», dal momento che l’acquisto dei titoli bancari, a differenza del «quantitive easing», implica come garanzia i prestiti effettuati dalle banche in questione.
Draghi, tuttavia, non ha escluso che in futuro, se fosse considerato necessario, il governo della Banca centrale potrebbe prendere in considerazione l’acquisto diretto di titoli sovrani a lungo termine, che è il centro del «quantitive easing».
Dunque, Draghi, dopo l’icastico «to do whatever it takes», dell’estate del 2012, quando annunciò la decisione della Bce «di fare qualsiasi cosa per preservare l’euro», ha dato fondo alle concrete possibilità di intervento della politica monetaria. Questa freccia è stata scoccata. Importante per tagliare gli artigli alla grande speculazione, ma non è sufficiente a invertire la tendenza. Lo ha spiegato lo stesso Draghi, in occasione del discorso programmatico di Jackson Hole, quando ha avvertito che nelle attuali circostanze di stagnazione e disoccupazione di massa «la politica monetaria perde di efficacia nel generare domanda aggregata».
Non a caso, molti commentatori hanno notato che, con la caduta verticale degli investimenti e dei consumi, il problema fondamentale non è la mancanza di liquidità, ma la sostanziale mancanza della domanda di credito da parte delle imprese e delle famiglie. Di fronte alla freccia spuntata della politica monetaria, Draghi evoca la seconda freccia, la politica fiscale, la cui responsabilità ricade sui governi nazionali. Misure di politica fiscale fondamentalmente dirette a ridurre le tasse che gravano sulle imprese.
Ma Draghi aggiunge una postilla non trascurabile: l’abbassamento delle tasse deve avvenire «in a budget-neutral way», cioè nel rispetto dei vincoli di bilancio imposti dalla Commissione europea. Operazione complicata, riconosce Draghi, dal momento che «l’alto livello del debito…inevitabilmente riduce lo spazio dei bilanci pubblici».
Di fronte ai limiti della poltica monetaria e fiscale, Draghi punta sulla terza freccia: le riforme strutturali e, più precisamente, la riforma del lavoro. Un tema presentato generalmente in modo confuso e ingannevole, com’è il caso del «Jobs act» in Italia. Ma nella conferenza stampa del 4 settembre a Francoforte, rispondendo alle domande di un giornalista, Draghi fa un’operazione verità. Sentiamo. «Vi sono tre strumenti per rilanciare la crescita. Riforme strutturali, politica fiscale e politica monetaria». La gerarchia degli strumenti non è casuale. In testa vi sono le riforme strutturali. Infatti, Draghi chiarisce: «Durante la presentazione (delle nuove scelte della Bce), ho iniziato dalla politica monetaria per passare a quella fiscale, ma ho poi concluso che non esiste nessuno stimolo fiscale o monetario in gradi di produrre alcun effetto senza ambiziosi, importanti e forti riforme strutturali.
Pertanto, in un certo senso, il punto chiave è l’attuazione delle riforme strutturali». Tra le quali, specifica, la «priorità» spetta alle riforme strutturali dirette all’eliminazione delle «rigidità del mercato del lavoro» (…). In parole povere, la flessibilità verso il basso dei salari a livello aziendale; e la libertà di licenziare per favorire la produttività aziendale.
Niente di nuovo, da questo punto di vista, sotto il cielo dell’ortodossia neoliberista. Ma la novità sta nell’esplicitazione, dall’alto della cattedra della Bce, del rilievo relativamente secondario attribuito alle misure monetarie e fiscali rispetto alla centralità nevralgica della riforma del lavoro. Il discorso qui è chiaramente rivolto all’Italia e alla Francia, dal momento che gli altri paesi dell’eurozona si sono disciplinatamente adeguati al dogma della deregolazione delle condizioni di lavoro, del salario e delle forme di occupazione.
Non a caso, Draghi fa l’elogio dell’esperienza irlandese e spagnola. In Spagna, il governo di Mariano Rajoy ha risolto la questione dando libertà alle aziende in difficoltà di cancellare il contratto nazionale di settore, ponendo i lavoratori di fronte all’alternativa fra la riduzione, fino al venti per cento, del salario e l’auto-licenziamento. Eppure, la Spagna come modello ed esempio da imitare, rappresenta un paradosso assoluto. Considerate tre cifre che ci forniscono un’idea della conclamata efficacia del modello. Prima della crisi, la Spagna aveva un debito di poco superiore al 40 per cento del Pil, il più basso fra i grandi paesi dell’eurozona; nel 2014 si avvicina al 100 per cento. Il disavanzo di bilancio, inesistente prima della crisi, per i 2014 è previsto intorno al 6 per cento del Pil, pari al doppio di quello italiano. E la disoccupazione ha raggiunto, esattamente come quella greca, la spaventosa cifra del 25 per cento Questo il modello che, in ultima analisi, Draghi in sintonia con Berlino e Bruxelles, propone a Italia e Francia.
Eppure, Draghi e, per quanto ci riguarda, Padoan non esitano a riconoscere che queste riforme del lavoro sono destinate nel breve-medio periodo non a migliorare, ma ad aggravare le condizioni di crescita e di occupazione, dal momento che, inevitabilmente contribuiscono a ridurre la domanda, sia dal lato dei consumi, che degli investimenti, in una lunga prospettiva di stagnazione, sulla scia di quella che è considerata una forma di “giapponesizzazione” dell’economia dell’eurozona.
Ma allora perché l’ossessiva insistenza sulla riforma del mercato del lavoro (che simbolicamente riappare in Italia con la definitiva cancellazione dell’art. 18)? Dal punto di vista strutturale, la riforma del lavoro indica un cambiamento a lungo termine, profondo e radicale dei rapporti sociali di potere. È l’affermazione di una gestione autoritaria nei luoghi di lavoro, sostanzialmente liberata dai vincoli della contrattazione collettiva e della funzione di rappresentanza, di intervento e di controllo dei sindacati sulle condizioni di lavoro e salariali.
Un ritorno agli albori del XX secolo, spacciato come tributo da pagare alla rivoluzione tecnologica e alla competizione globale del XXI secolo.
*La versione completa di quest’articolo è su www.sbilanciamoci.info