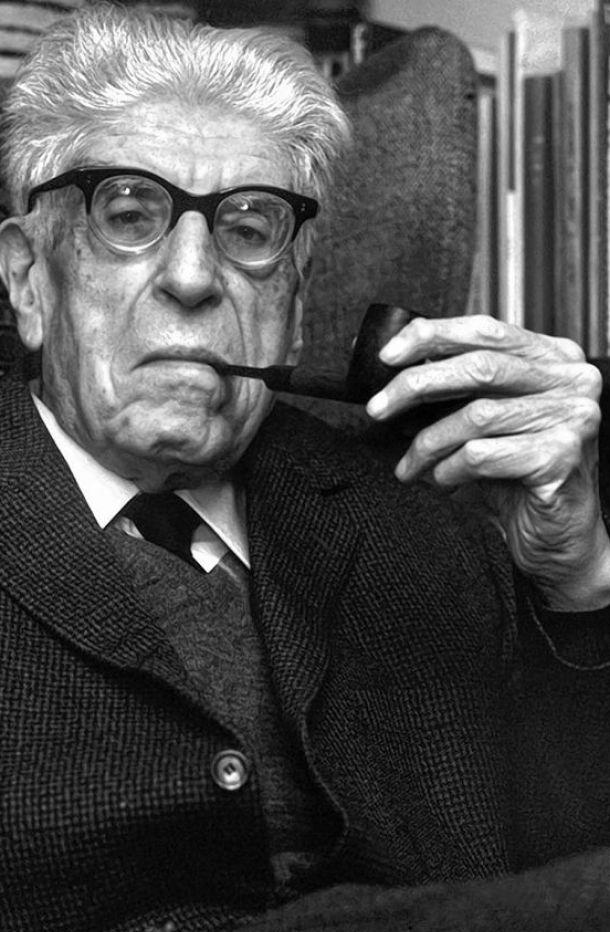Frutto di una grande effervescenza del pensiero collettivo, il classico di Ernst Bloch, Eredità di questo tempo, ora riproposto in una bella edizione sapientemente introdotta da Laura Boella (Mimesis, pp. 480, euro 32,00), non può essere letto isolatamente: è, infatti, uno tra i prodotti migliori di una eccezionale leva di intellettuali critici, che sbocciò nella Germania e nella Mitteleuropa degli anni venti e trenta del Novecento. Ne fecero parte, tra i maggiori, Gyorgy Lukács, che scrisse il libro più «forte» fra tutti quelli del periodo, Storia e coscienza di classe, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Siegfried Krakauer. Il minimo che si possa dire è che quella fu una stagione intellettuale incredibilmente creativa; ed è evidente che, nel fecondare questa creatività, l’effetto elettrizzante della rivoluzione russa del 1917 ebbe un ruolo assolutamente decisivo. Sarà interessante, quando tra poco verrà celebrato (o forse, più probabilmente, «dannato») il centenario della rivoluzione bolscevica, misurare la sua incisività dal punto di vista della innovazione intellettuale (filosofica, letteraria, artistica). Ma ciò che risulta ancora più interessante notare è come, all’interno di questo gruppo di intellettuali, le influenze e i legami di amicizia fossero fittissimi. Non solo: al di là di tutte le differenze e le polemiche, che pure non mancarono, c’era forse addirittura un tessuto ideale comune.
Uno dei punti fondamentali, infatti, attorno a cui molte riflessioni di quell’epoca si intrecciarono, stava nella volontà di costruire una teoria critica che, pur essendo fortemente legata al marxismo, si contrapponesse frontalmente a tutta la componente progressista e storicista che nel marxismo socialdemocratico era diventata preponderante. Insomma, il Lukács weberiano di Storia e coscienza di classe, Benjanim, Adorno, il Bloch di Eredità di questo tempo, hanno in comune l’idea assolutamente inedita di fondere due temi non così facilmente componibili: da un lato la lettura marxiana del capitalismo, dall’altro una visione radicalmente critica della modernità tecnicizzata, industrializzata e razionalizzata. Due aspetti che riescono a stare insieme solo se, sulla scorta di quanto aveva sostenuto Lukács nel 1923, al centro dell’analisi del capitalismo vengono posti i concetti di feticismo e di reificazione.
È questo il nodo attorno al quale le riflessioni di questi straordinari intellettuali si intrecciano e si aggrovigliano; con molte feconde intersezioni ma anche con aspetti meno gradevoli: polemiche, accuse, incrinature o rotture dei rapporti personali. Per esempio, come racconta Laura Boella nella sua introduzione, Benjamin ritrovò nei testi di Bloch così tante sue idee che si urtò e lo accusò di plagio (ma non tardò la riconciliazione); con Adorno ci furono tensioni ancora più forti. Anche i tempi, tuttavia, contribuivano a non rendere le cose facili. Per questi intellettuali antinazisti ma anche anti-accademici, quasi tutti ebrei, la vita negli anni trenta era drammatica: l’esilio, la precarietà economica, il fatto che alcuni (come l’Istituto per la Ricerca Sociale di Horkheimer) disponessero di risorse e altri no, tutto ciò non semplificava le cose. Inevitabile che nascesse qualche invidia e qualche polemica; anche Bloch non se le faceva mancare, quando per esempio apostrofava l’Istituto per la ricerca sociale (in tedesco Sozialforschung) come Istituto per la falsificazione sociale (Sozialfälschung), riprendendo uno scherzo di Kracauer. (Ma la migliore battuta di Bloch è la definizione degli Stati Uniti: il Paese dove i miliardari cominciano la loro carriera come lavapiatti, e i filosofi la finiscono così).
A guardarli oggi, da lontano, i grandi «marxisti romantici» degli anni venti e trenta sono tra loro molto più vicini di quanto pensassero; o, meglio, costituiscono una sorta di galassia dove ogni stella ha una sua spiccata originalità, pur dentro una certa aria di famiglia. La specificità di Bloch, come emerge benissimo dalla lettura di Eredità di questo tempo, si concentra soprattutto attorno a due nodi, il primo dei quali è quello della non-contemporaneità. Proprio la riflessione sulla ascesa e sulla vittoria del nazismo, che è uno degli assi attorno a cui ruotano i testi eterogenei raccolti in Eredità di questo tempo, pubblicato nel 1935, spinge Bloch a sviluppare una concezione del tempo storico multiversa e plurale, particolarmente calzante per un paese come la Germania, intreccio di arcaicità e modernismo. E la sua tesi è che, ferma restando la grande contraddizione contemporanea, ossia quella tra capitale e classe operaia, è altrettanto importante la contraddizione non-contemporanea, cioè quella che oppone la modernità capitalistica alle classi e alle forme di vita che essa travolge, soprattutto quelle di tipo agrario e contadino e quelle della piccola borghesia urbana pauperizzata. L’idea di Bloch, in sostanza, è che non tutto quello che viene cancellato e polverizzato dalla modernizzazione industrialista e capitalista merita la sorte che questa gli riserva; anche le contraddizioni definite non-contemporanee hanno, infatti, una influenza decisiva sulla dialettica e sul conflitto sociale, e il non aver capito questo aspetto è una delle cause che hanno portato al fallimento della sinistra rivoluzionaria, anti-socialdemocratica, la quale ha lasciato che su queste contraddizioni attecchissero e prosperassero la reazione e il nazismo. Ciò che invece si dovrebbe comprendere è che il passato pre-capitalista non è solo un residuo giustamente liquidato dalla modernità, ma anche una riserva di alterità che deve essere salvata da coloro che vogliono l’emancipazione. La forza che ha attratto le masse vero il nazismo è stata proprio la sua capacità di essere, come scrive Bloch, «ad un tempo ardente e miserabile, contestatario e non contemporaneo».
Ma il tema del passato che non passa si lega strettamente al vero filo conduttore di tutto il lavoro di pensiero di Bloch, cioè la questione dell’utopia. Non c’è momento del passato al quale si attribuisca il sogno di un’epoca di redenzione e di riconciliazione a venire che non abbia espresso l’insoddisfazione per la vita mutilata e che non abbia dunque manifestato una tensione verso qualcosa di altro. La terribile intuizione dei nazisti, quando si presentarono con la bandiera del Terzo Regno (in tedesco Reich), è stata proprio quella di utilizzare, rovesciandola in modo perverso, quella sotterranea corrente utopica che aveva attraversato per secoli la storia d’Europa: l’attesa millenarista di un Terzo Evangelo (dopo il vecchio e il nuovo testamento), di una Terza Età di redenzione e di felicità anche terrena per tutti gli uomini, già sognata da personaggi come Gioacchino da Fiore o Thomas Müntzer, il capo della rivolta dei contadini tedeschi del Cinquecento cui Bloch aveva dedicato un libro nel 1921. Perciò la rivoluzione di Bloch (dove si rendono evidenti i punti di intersezione con Benjamin) non si risolve solo in una marcia verso il futuro, ma anche, se non soprattutto, nel riattivare le potenzialità soffocate del passato.
Nel complesso il testo di Bloch ci appare oggi lontanissimo e al tempo stesso vicino. Remoto Bloch lo è perché tutto pervaso dall’idea di vivere in un’epoca di grandi cambiamenti, di rivoluzioni realizzate e possibili, non meno che di incombenti catastrofi. Tutt’altro che remota, invece, è l’indagine sulla non contemporaneità delle contraddizioni e sul multiversum del tempo storico. Anzi, è proprio nella nostra età globale che questi dislivelli temporali si toccano e si scontrano minacciosamente; ed è nell’attualità che siamo costretti a misurarci ogni giorno con le paure e con i rancori che la più recente ondata della modernizzazione globalizzante suscita nei ceti e nei gruppi sociali che essa travolge e impoverisce, innescando dinamiche che con quelle studiate da Bloch hanno più di qualche somiglianza.