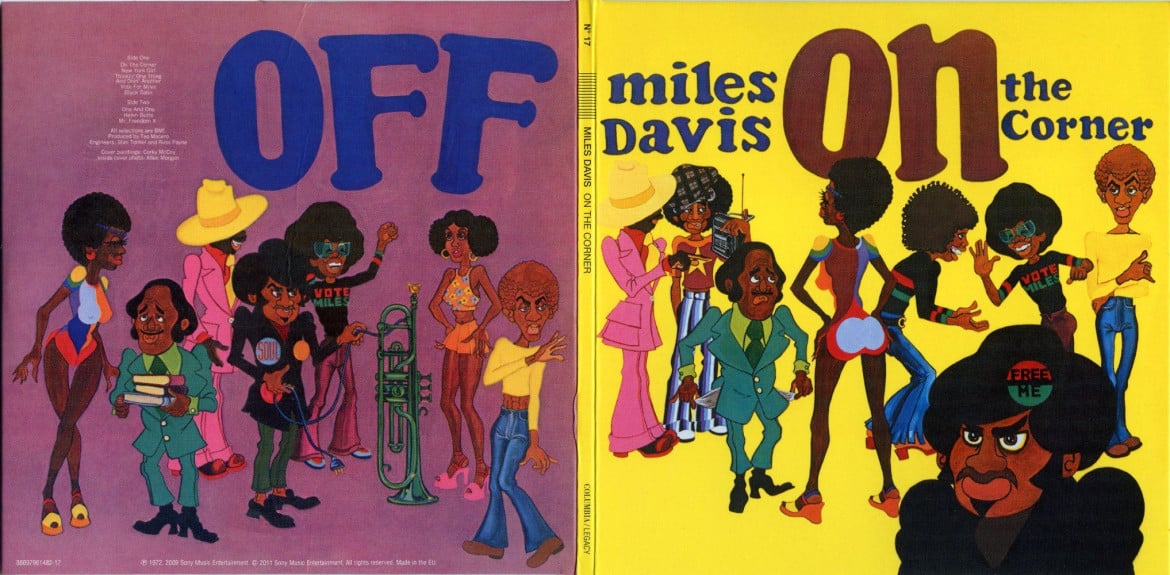Pubblicato 2 anni faEdizione del 8 ottobre 2022
«C’è qualcuno seduto all’ombra oggi perché qualcun altro ha piantato un albero molto tempo fa», ha detto un tempo Warren Buffett, economista e filantropo. L’immagine potrebbe tornare utile anche ragionando sulla musica, e in particolare sulle note che hanno saputo muoversi con intelligente ambiguità tra forme d’arte e forme esplicitamente «popular», più vicine alle logiche di mercato. Per riprendere la frase iniziale, non è detto che chi di mestiere e d’indole pianti metaforici alberi giovani nel terreno delle note a rischio inaridimento poi possa, egli stesso, godersi un meritato riposo all’ombra. Lo faranno altri. Spesso non va proprio così. Normalmente...