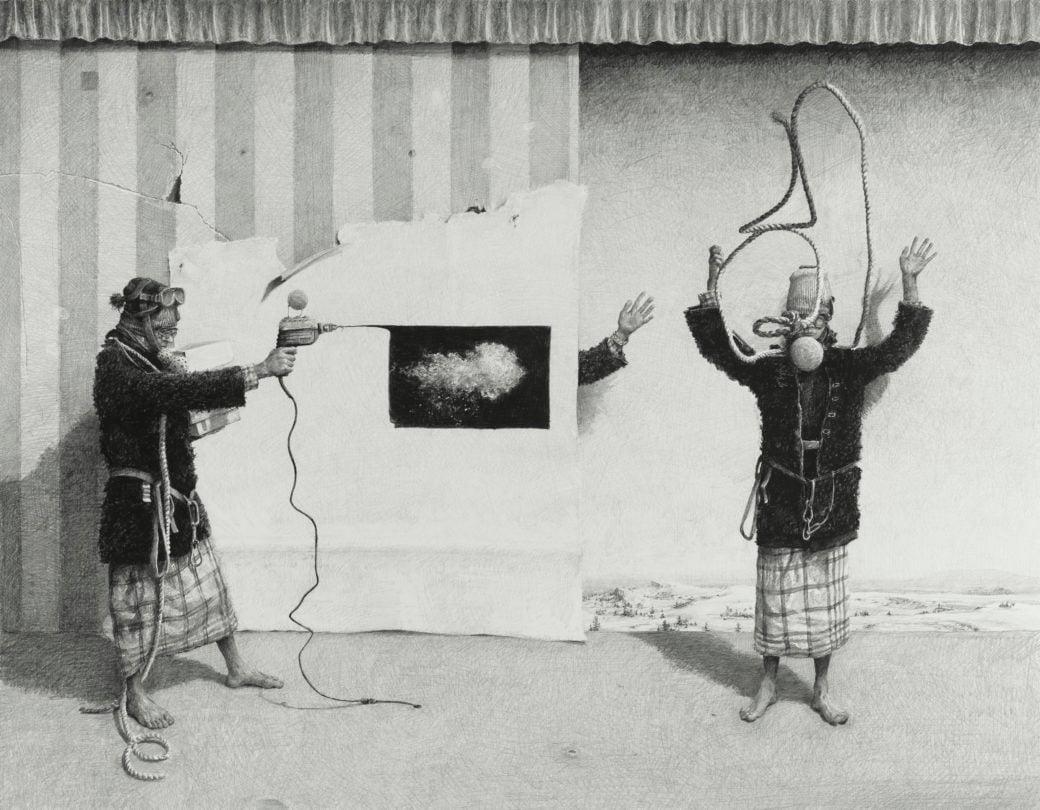Il grande tema del classico racconto di Natale di Charles Dickens A Christmas Carol è il rapporto innanzitutto individuale tra l’orientamento acquisitivo e predatorio del «buon» capitalista, e quello spirito religioso originario del capitalismo stesso – più tardi magistralmente analizzato da Max Weber – che vede nel servizio verso la comunità da parte dell’imprenditore di successo, la manifestazione di una spiritualità più alta e persino necessaria. In altre parole, la tensione che si rinnova continuamente nella modernità capitalista tra l’etica utilitaristica e l’etica della responsabilità; tra una legittimazione basata unicamente sulla ricerca dell’efficienza economica e una legittimazione fondata sulla promozione, privatistica, del benessere collettivo oltre che individuale.
NELL’EPOCA del trionfo della globalizzazione neo-liberale e di quella che Luciano Gallino ha acutamente definito «l’impresa irresponsabile», questa tensione non ha solo ispirato movimenti e analisi critiche. Essa ha anche alimentato due filoni tutti interni al cuore del sistema politico-economico: il primo, fortemente legato all’economia digitale, ha cercato di risolvere questa tensione promuovendo una netta separazione tra lavoro creativo (design, software) e lavoro manuale che produceva concretamente i dispositivi venduti sul mercato (hardware). Il primo segnato da una retorica della condivisione, del ritorno alla dimensione umana del lavoro e alla bellezza dei luoghi in cui questo lavoro si svolgeva. Il secondo relegato, in qualche lontana mega-fabbrica della Cina o del sud-est asiatico, a forme neo-schiavistiche di organizzazione del lavoro e ad ambienti di vita e di produzione brutti e malsani. L’altro grande filone che ha cercato di ricomporre al livello istituzionale la tensione tra le varie etiche del capitalismo è stato quello della responsabilità sociale d’impresa che, dagli anni Cinquanta dai quali origina il suo discorso, fu riportata in auge addirittura dalle Nazioni Unite (iniziativa «Global Compact», 1999). Al di là dei successi e insuccessi di questi approcci, la domanda che dopo la crisi del 2007-2008 ripropone tutta la sua attualità è: possono spiritualità, etica ed estetica convivere tra loro e costruire un nuovo modello di capitalismo? A questa domanda ha cercato di dare una risposta Brunello Cucinelli.
IMPRENDITORE umbro attivo nel campo della moda, tra gli uomini più ricchi d’Italia e propugnatore di un nuovo modello socio-economico al centro del suo libro Il sogno di Solomeo. La mia vita e l’idea del capitalismo umanista (Feltrinelli, pp. 176, euro 15). Cucinelli, come egli stesso afferma, non è in alcun modo un nuovo Adriano Olivetti. Olivetti era un borghese di nascita profondamente radicato nella modernità e che, in ultima analisi, sognava l’equilibrio perfetto tra industrializzazione e comunità, tra lavoro e capitale, in un equilibrio che sarebbe dovuto diventare da locale (Ivrea) a generale (l’Italia e non solo), anche grazie all’azione politica e statuale. L’imprenditore umbro è invece una figura integralmente postmoderna e in fondo post-politica: «il sogno di Solomeo» (nome del Borgo dove ha sede l’azienda di Cucinelli) è quello di un uomo di origini contadine che, seguendo i valori umanistici scoperti nella vita rurale e nella filosofia, diventa un grande industriale. Un sogno in grado anche di mostrare che si può restituire vita ai centri antichi e, forse, nobiltà alle periferie e ai suoi abitanti. Attraverso la riscoperta della saggezza dei classici greci e latini e l’importanza della bellezza e dell’equità nell’organizzazione del lavoro e nel rapporto tra fabbrica e territorio circostante. Se i mitici 3 fantasmi del racconto di Dickens andassero a far visita a Cucinelli si annoierebbero e, forse, si convincerebbero a lavorare per lui, che offre oggettivamente condizioni di lavoro ottime in un posto meraviglioso come Solomeo: il mondo e il percorso auto-biografico raccontato nel suo libro si pone sin dall’inizio come pacificato, armonico, privo di contraddizioni insanabili. Tutti elementi che sembrano transitare direttamente dalla civiltà contadina alle sfide del mercato globale. Vinte grazie a questa serena saggezza che non minaccia né l’uomo né l’ambiente né la sua memoria ma, al contrario, li promuove. L’idea dell’utopia realizzata sta dunque alla base, come meta-testo, della narrazione cucinelliana. Fornendo una particolarmente affascinante versione della responsabilità sociale d’impresa non limitata alle sole operazioni di marketing.
QUELLO CHE INVECE i tre fantasmi dickensiani forse non amerebbero e che non potrebbero mai permettersi sono i prodotti venduti da Cucinelli. Capi di alta moda riservati ad una clientela globale estremamente danarosa. E qui sta il vero nodo problematico del modello Cucinelli e del libro che lo racconta: l’elusione del rapporto tra il «locale» e il globale. Come accade a tutte le attività che partono dalla valorizzazione capitalistica del territorio italiano con il suo immenso patrimonio culturale (si pensi al modello dello «slow food»), bellezza, qualità del prodotto e salubrità sul territorio si legano spesso al presupposto (necessario) di un mondo più vasto profondamente diseguale e stratificato; nel quale chi vive nelle periferie mangia fast food e compra cinese, separato da quei ceti sociali che possono permettersi di mangiare, vestire e abitare in un sogno come quello di Solomeo. Ecco perché il modello proposto da Cucinelli non è un modello alternativo e generale poiché parte dall’implicita accettazione e anzi dal profondo rinforzo di quel capitalismo neo-liberale che, per funzionare, ha bisogno di far circolare e in fondo esternalizzare lontano dal mondo dei ricchi, la bruttezza, l’immoralità e l’alienazione che continua, massicciamente, ad alimentarlo.