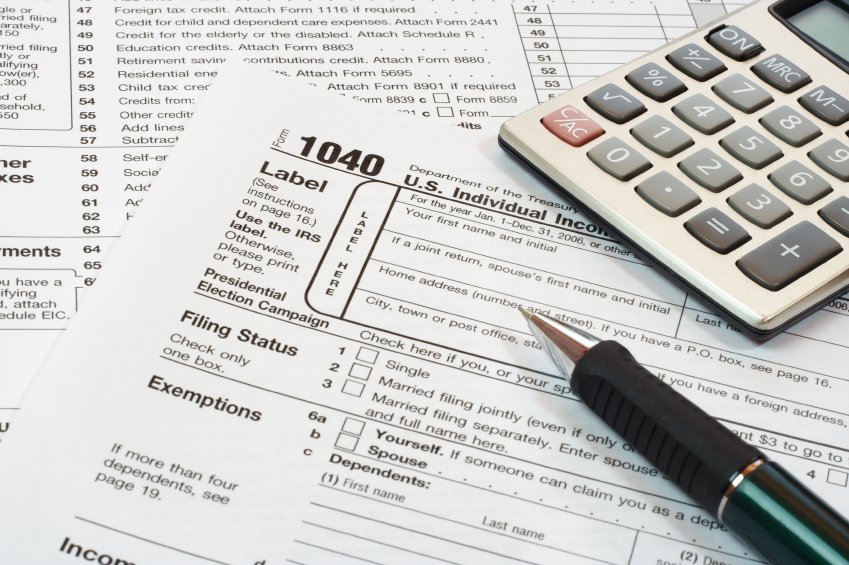Gli economisti Emmanuel Saez e Gabriel Zucman hanno proposto un’imposta patrimoniale dello 0,2% sul valore delle azioni delle grandi imprese del G20. L’imposta è «piatta» ma avrebbe effetti progressivi perché la proprietà delle azioni si concentra tra i cittadini più ricchi: negli Stati Uniti l’1% delle famiglie più ricche possiede circa il 33% di tutte le azioni societarie. Il gettito stimato di una modestissima tassa di questo tipo sarebbe ingente: 180 miliardi di dollari ogni anno, circa lo 0,18% del Pil del G20. Si tratta di una proposta ben calibrata rispetto alla situazione post-pandemica, che ha rafforzato la disuguaglianza di ricchezza tra il top e il resto della distribuzione: l’86% dei miliardari mondiali ha visto la propria ricchezza crescere dal 2020 al 2021. Numeri che confermano come la stragrande maggioranza dei contribuenti non avrebbe che da guadagnare da una redistribuzione del carico fiscale, come scrive Francesco Pallante su questo giornale.
L’effetto post-pandemico si inserisce in una situazione pregressa dove la distanza tra il vertice e pancia della piramide non era certo piccola: nel 2018 la remunerazione mediana di un Ceo di una grande corporation era pari a 72 volte la remunerazione mediana di un lavoratore-tipo della stessa organizzazione e 117 volte quella di un lavoratore di ceto medio a tempo pieno e indeterminato. Inoltre, le aspirazioni di ceto medio sono frustrate dall’aumento dei costi dei beni e dei servizi necessari per tradurre queste aspirazioni in risultati. Istruzione, abitazione, servizi sociali e salute sempre più care; così come posti di lavoro a media qualificazione e professioni sempre più scarse e meno tutelate (Göran Thereborn, Inequality and the Labyrinths of Democracy, Verso, 2020).
Con un chiaro effetto tra coorti di nascita. Negli Stati Uniti, il 95% dei nati nel 1940 guadagna – alla maggiore età – più del padre; contro il 41% di chi è nato nel 1984. Nei paesi Oecd, il 70% dei nati tra il 1943 e il 1964 vivono in una famiglia con un reddito di ceto medio, contro il 60% dei millenials nati dopo il 1983. Diventare di ceto medio e restarci è, oggi, sempre più difficile. Per il futuro, molte analisi convergono nel delineare uno scenario dove automazione e informatizzazione saranno sostitutive delle attività lavorative intermedie, di complemento per i lavori a bassa qualificazione e con effetti più limitati su lavori qualificati. Il risultato complessivo è quello per cui i lavori di media qualificazione scompariranno gradualmente, con un processo di polarizzazione sia dei salari che delle competenze (si veda lo splendido scritto di Giovanni Dosi e Maria Enrica Virgillito).
La direzione, del resto, non è determinata dalla tecnologia, ma può (e deve) essere governata dalla politica e dai processi di costruzione del consenso. Nel passato, nei paesi avanzati, le fasce centrali si sono molto differenziate, a seconda delle specializzazioni produttive e dei servizi, come conseguenza delle innovazioni tecnologiche, delle politiche pubbliche riguardanti i sistemi di istruzione, i mercati del lavoro e i sistemi di welfare-state. Soprattutto, classi e ceti medi sono politicamente ambivalenti: nel caso italiano, per esempio, li troviamo come leve del controllo sociale e dello scambio clientelare, con conseguenze negative per la modernizzazione del paese, ma anche come motore dello sviluppo delle regioni (rosse e bianche) a economia diffusa.
Come mostrano gli eventi recenti, la pressione della protesta di matrice destrorsa dell’#ioapro e la concorrenza tra Salvini e Meloni per intestarsi il ruolo di “difensore del ceto medio” e di quelle che Paolo Sylos-Labini definiva le classi medie urbane (e che ammontano ancora a più del 50% della popolazione italiana), ha indotto Mario Draghi a piegare la testa. La radicalizzazione del ceto medio autonomo e la rabbia contro i #culialcaldo, gli «statali garantiti pro-lockdown», è un segnale pericoloso per la tenuta della democrazia.
Per contrastarla, occorre seguire la strada indicata da Emmanuel Saez e Gabriel Zucman: tassare le grandi corporation, lavorare a livello di istituzioni sovranazionali per armonizzare i regimi fiscali, combattere il potere di rendita e la concentrazione proprietaria. E utilizzare le risorse così generate per una politica di sinistra per il ceto medio: beni e servizi fondamentali, istruzione libera e gratuita, politiche per la casa, riforma degli ammortizzatori sociali e del welfare. Ricostruire l’infrastruttura della cittadinanza sociale e governare il cambiamento tecnologico. Per le forze del (prossimo?) «campo progressista» si tratta di passare da una politica di centro per la classe operaia – strada seguita post ’89 – a una politica di sinistra per il ceto medio.
Twitter: @FilBarbera