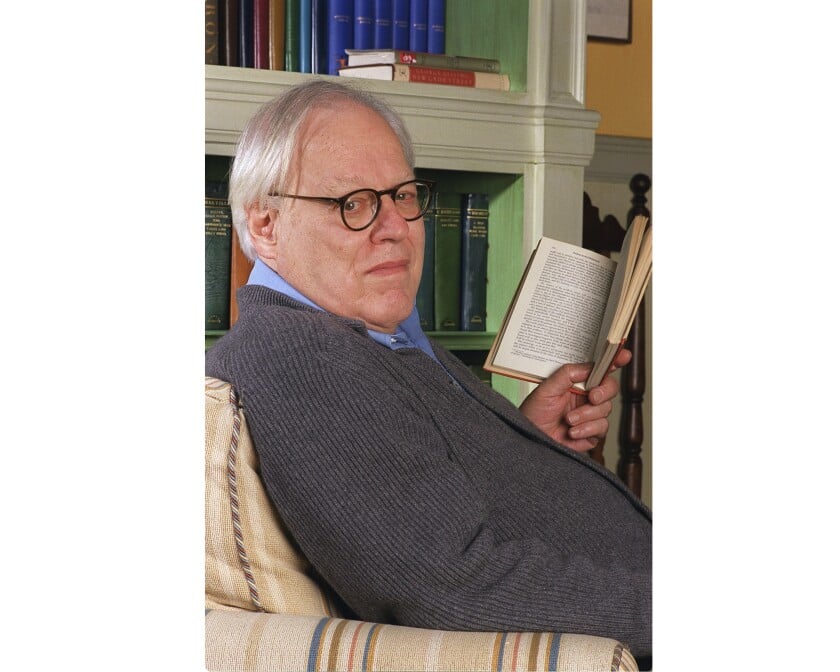Il nome di Jason Epstein in Italia è noto solo a chi si occupa di editoria, e forse neanche a tutti. Nulla di strano, quindi, che la notizia della sua morte, avvenuta qualche giorno fa a 93 anni, non abbia trovato eco nei nostri media. Non così negli Stati Uniti, dove gli obituaries per Epstein si sono susseguiti a colpi di «leggendario», «titanico», «geniale». E per quanto si possano detestare le iperboli, in questo caso si è autorizzati a indulgere – o perlomeno a ricordare con reverenza una figura che ha avuto un ruolo chiave nell’editoria statunitense, e non solo. Come ha scritto Christopher Lehmann-Haupt sul New York Times «Epstein potrebbe essere descritto come un uomo di lettere con un grande fiuto per il commercio o come un uomo d’affari con un gusto per la buona letteratura, ed entrambe le definizioni sarebbero corrette».
Le sue doti apparvero evidenti molto presto: approdato all’editoria come tirocinante per Doubleday, ebbe nel 1952 la prima delle tante portentose idee che avrebbero costellato la sua carriera. Lasciamo ancora la parola a Lehmann-Haupt: «Se i costosi classici rilegati fossero stati resi disponibili in veste di tascabili economici, avrebbero trovato un mercato redditizio in una popolazione universitaria in grande espansione nel dopoguerra. Epstein ne parlò con il capo di Doubleday, Ken McCormick, durante una passeggiata a Central Park, e nel 1953 McCormick gli diede il via libera per una linea di tascabili».
Era nata Anchor Books: copertine disegnate da Edward Gorey, fra le uscite iniziali La Certosa di Parma di Stendhal, Idea di un teatro di Francis Fergusson, i saggi letterari di DH Lawrence. Fu un trionfo: i primi quattro titoli andarono a ruba, vendendo ciascuno più di diecimila copie in due settimane. Ma Epstein non era tipo da restare fermo. Nel 1958 passò a Random House, dove diventò l’editor, fra gli altri, di Philip Roth, Gore Vidal, Norman Mailer.
Intanto le idee continuavano a fluire: fu Epstein, tra l’altro, cogliendo un suggerimento del critico Edmund Wilson, a lanciare il seme di quella che sarebbe diventata la Library of America, tuttora viva e vegeta, una sorta di equivalente statunitense della Bibliothèque de la Pléiade francese, splendidi volumi rilegati che proponevano – e propongono – i grandi classici americani. Né possiamo trascurare un’altra “invenzione” di Epstein, nata quasi per caso nell’inverno del 1962 durante una cena a casa sua e della prima moglie, Barbara. Era in corso in quei giorni uno sciopero dei giornali e l’editore osservò con rammarico che i lettori statunitensi avrebbero sentito la mancanza delle recensioni del supplemento letterario del New York Times (erano altri tempi). «Ci vorrebbe una nuova rivista», disse – e il primo febbraio 1963, eccola: la New York Review of Books approdò nelle edicole degli Usa, sciorinando nel primo numero fra gli altri i nomi di Dwight Macdonald, Susan Sontag, Mary McCarthy.
Neanche la vecchiaia, naturalmente, riuscì a domare Epstein: su The New Republic Siva Vaidhyanathan ricorda un incontro nei primi anni Duemila con l’editore che, dopo avergli servito un’omelette deliziosa (la cucina era una sua passione), si lanciò in un peana del print-on-demand, oggetto poi di una sua ennesima impresa.
In realtà, non tutto è andato secondo le sue previsioni, come lui stesso ha in parte ammesso nel libro Il futuro di un mestiere, tradotto da noi per Sylvestre Bonnard. Ma nonostante tutto, dobbiamo continuare a sperare che fra i giovani editori, anche da questa parte dell’oceano, qualcuno abbia voglia di seguire l’esempio di Epstein, di emulare (citiamo dalla motivazione del Poor Richard Award che gli fu assegnato nel 2010) «la sua creatività e la sua instancabile devozione alla parola scritta».