Una scena rock leggendaria e tragica, un anniversario importante. Nella primavera di 30 anni fa la città di Seattle, profondo nord-ovest degli Stati Uniti, era solo un pallido puntino luminoso nel panorama della musica americana e internazionale. Ci si ricordava del suo indimenticabile figlio, Jimi Hendrix, e di qualche sporadico acuto (il garage dei Sonics, l’hard rock melodico delle Heart) e si registrava un dinamico fermento artistico che rimaneva però relegato a quello che all’epoca veniva definito «underground». Un’etichetta locale, la Sub Pop, si stava distinguendo per intraprendenza e coraggio e alcune band si stavano facendo conoscere. Il termine «grunge» iniziava a circolare. Ma il 1990 fu l’anno della svolta. Quella città piovosa e remota diventerà in pochi mesi capitale di una rivoluzione musicale e culturale. Una rivoluzione che non ha mai smesso di affascinare, che ha prodotto artisti diventati icona di un’era e dischi ormai storici, ma che deve esser ricordata anche per la sofferenza che portò con sé. L’interesse per quell’epoca e per l’intensità e i drammi che la accompagnarono è testimoniata da una serie di nuove pubblicazioni che raccontano a un pubblico di nostalgici e a una nuova generazione gli anni in cui il rock riscoprì la sua energia. Ma dopo trent’anni forse possiamo porci la domanda: a che prezzo?
LA GRANDE SVOLTA
Una serie di eventi segnarono la grande svolta del 1990 per la città della Boeing, che ai tempi aveva anche una squadra di basket chiamata «i supersonici». Nel marzo di quell’anno i Mother Love Bone, già scritturati dalla major Polygram stavano dando alle stampe, con grandi aspettative, l’album Apple. Ma il frontman della band, Andy Wood, morì improvvisamente di overdose, gettando subito un presagio maledetto su tutto un ambiente. Un altro momento cardine fu l’album di debutto degli Alice in Chains, Facelift. Il disco, edito dalla Columbia, uscì nell’estate di quell’anno un po’ in sordina. Ma, in un’epoca in cui le etichette costruivano il successo e non credevano nell’usa e getta, si fece strada nel panorama rock fino a diventare, un anno dopo, il primo lavoro di quella stagione musicale a raggiungere prima il disco d’oro e poi il disco di platino. Facelift riaccese i riflettori su Seattle. Quello di nord-ovest non era un passaggio, ma un approdo. Si aprirono le porte ai successi planetari di Nirvana, Soundgarden, Screaming Trees, Pearl Jam e di altre band che furono in grado di cavalcare l’onda. La storia degli Alice in Chains, ma soprattutto del suo carismatico e tormentato leader, Layne Staley, è raccontata nel documentatissimo In catene, libro del giornalista e musicista siciliano Giuseppe Ciotta uscito per l’editore genovese Chinaski nella collana Vices. Ciotta, fan di lunga data del gruppo, racconta in 350 pagine con un rigore da saggio accademico la storia di un frontman che ha saputo condensare meglio di chiunque altro il tormento e l’estasi di un movimento che diede al rock un’energia e un’attualità che si credeva smarrita. La parabola di Staley è stata trionfale e straziante. Ragazzo timido e schivo, trovò nella musica la sua valvola di sfogo, nella sua vocalità particolarissima la sua inconfondibile caratteristica e nella collaborazione con Jerry Cantrell, chitarrista e songwriter, un’affinità artistica che porterà gli Alice in Chains a essere una delle realtà più autorevoli degli anni Novanta. Ma fu una fiammata. Il gruppo pubblicò in sei anni tre album (tra cui il capolavoro Dirt del ’92), due ep e un live. Al culmine della fama e del successo Staley, che guidava anche il fortunato side project dei Mad Season, si perse inesorabilmente in una dipendenza da eroina che lo accompagnava da tempo e che lo condusse prima a un esilio autodistruttivo e poi a una morte solitaria nel 2002. Giuseppe Ciotta ha raccolto storie e testimonianze, andando a Seattle e parlando con molti protagonisti di quel periodo.

La figura di Layne Staley diventa, nella pagine del volume, sempre meno enigmatica e stereotipata e sempre più umana. Dopo 30 anni dalla sua consacrazione che cosa ci ha lasciato? «Da un punto di vista stilistico – spiega Ciotta – Staley ci ha lasciato innanzitutto una pletora di imitatori, anche se in pochi hanno saputo raggiungere gli stessi vertici espressivi. Da un punto di vista contenutistico la sua disarmante sincerità, il suo modo di porsi totalmente senza filtri; nel libro ho scritto che forse solo Lou Reed era stato così spietatamente sincero anche se in modo decisamente più poetico e sfumato. Infine, la qualità consolatoria della sua voce. Quando lo ascoltavi, indipendentemente dalla comprensione delle parole, capivi che quello che cantava proveniva da un luogo reale». Una star, ma non un divo, un ragazzo vulnerabile. «Durante gli anni Novanta – prosegue l’autore – una certa stampa scandalistica lo rappresentò come l’epitome della rockstar tossica, quella fu una cosa che gli pesò molto. Aveva sensi di colpa verso i fan per questa distorsione. Le rockstar ai tempi erano inavvicinabili semidei, ma con l’avvento del grunge questo cambiò. La distanza si ridusse. La scena rock californiana anni Ottanta era tutta sesso, dollari e macchine. Fu sostituita da una musica che parlava di divorzi, di alienazione giovanile e di solitudine, creando un’immedesimazione tra star e pubblico».
Gli Alice in Chains, che si sono riformati nel 2005 con un nuovo cantante, guidati da Staley collezionarono 16 dischi di platino in patria. Nel luglio del 1996 dopo un concerto a Kansas City con i Kiss, Staley andò in overdose. Nell’ottobre dello stesso anno Demri Parrott, la donna che amava, morì. Da quel momento in poi la sua vita divenne una corsa verso il precipizio. Il cantante scomparve quasi completamente dalle scene, su di lui girarono voci incontrollate. Fu la cinica cronaca di una morte annunciata. Il 20 aprile 2002 il suo corpo venne ritrovato in casa sua. Era morto, in una straziante solitudine, due settimane prima. Il racconto dei suoi ultimi anni è la parte più toccante del libro. Forse nessun altro ha indagato su questo periodo con l’accuratezza (e anche il rispetto) di Ciotta. Sorge quindi la domanda: poteva essere salvato Staley? «La prima cosa da chiarire – spiega lo scrittore – è che Layne non era solo. Aveva allontanato da sé le tante persone che gli volevano bene. Come accade spesso ai tossicodipendenti i veri amici divennero per lui i peggiori nemici. Nessuno fu in grado di fare nulla. La stessa madre non fu legalmente nella possibilità di costringerlo a curarsi. Per Staley la droga non era un vizio, era una medicina. Lui si stava automedicando. Sia Gary Lee Conner degli Screaming Trees che Kevin Wood, il fratello del compianto Andy, mi hanno confermato come all’epoca a Seattle le droghe pesanti erano usate come un farmaco. Staley era capace di una grandissima empatia e tendeva a incolparsi di cose che non dipendevano da lui. Solo alla fine del mio studio sono riuscito a capire che questo senso di colpa in lui nacque durante l’infanzia in seguito dell’abbandono del padre. Finì poi per incolparsi per la crisi della band e soprattutto per la morte per droga della sua ragazza Demri. Si malediceva perché, come disse ad alcuni suoi amici, avrebbe avuto i contatti e le risorse economiche per salvarla, ma non ci era riuscito. Era l’amore della sua vita. Se la sua depressione fosse stata compresa in tempo e curata con i metodi di oggi però forse si sarebbe potuto salvare».
UN’ALTRA TRAGEDIA
Ma un’altra tragedia anni prima aveva sconvolto la scena musicale di Seattle. Era ovviamente quella di Kurt Cobain suicidatosi il 5 aprile 1994. Il libro Kurt Cobain Dossier. Indagine su un suicidio sospetto, scritto da Epìsch Porzioni, sempre edito da Chinaski, cerca di fare il punto su un episodio che ha cambiato la storia del rock. L’autore, che ha già firmato diverse biografie di star musicali, ha svolto un lavoro a suo modo unico, raccogliendo tutti gli episodi, reali o aneddotici, documentati o complottisti che si sono accumulati nel corso degli anni attorno alla fine del frontman dei Nirvana. Porzioni lo ha fatto forse nell’unico modo possibile, con uno stile da hard boiled. Attorno agli ultimi giorni della rockstar si sono infatti raccolti miriadi di personaggi che neppure la penna di un giallista allucinato potrebbe inventare: un baby sitter spacciatore, un cantante di porno punk alcolizzato morto misteriosamente sotto un treno, un investigatore privato senza scrupoli, un poliziotto ucciso in un regolamento di conti. E al centro di tutto Courtney Love, la vedova di Cobain. Tutto incredibile, ma tutto vero. «Io già una dozzina di anni fa avevo fatto un libro simile – spiega l’autore – e mi sono sempre tenuto aggiornato sui vari sviluppi della vicenda. Il recente processo, non ancora concluso, tra Courtney e l’ex marito e padre della figlia mi ha fatto capire che c’era tanto nuovo materiale per poter tornare sulla vicenda. Sono così andato a scavare e a verificare ogni nome, ogni data, ogni circostanza, anche andando nelle paludi dei complottisti perché questa vicenda ha affascinato molto un certo mondo amante delle cospirazioni. Ho cercato di raccogliere tutto, con il massimo rigore e la neutralità possibile, e di fare qualcosa che non ha ancora fatto nessuno».
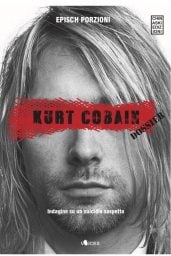
Porzioni non prende per buone le teorie più folli sulla morte dell’artista, ma le cita anche perché, si scopre, alcune furono proprio messe in circolazione dalla Love in tante delle sue torrenziali esternazioni. «La morte di Cobain, che era comunque un ragazzo di 27 anni, coinvolse tutti emotivamente – racconta Porzioni -. Rispetto alle morti di altre star del passato (Hendrix, Morrison o Elvis) nel ’94 stava nascendo una comunità online. E proprio Courtney Love fu una delle prime ad avere su internet una message board molto attiva e molti dubbi sulla morte di Cobain nacquero proprio in questo ambiente». La teoria del suicidio rimane comunque la più accreditata, ma le ombre in effetti c’erano e ci sono. Il vero dubbio è che Cobain fosse stato messo dalle circostanze (o dalla volontà di qualcuno) in una situazione da cui la sua fragilità emotiva non gli avrebbe mai permesso di uscire. Al centro di tutto lei, Courtney Love, ormai inseritasi nell’epopea rock come un incrocio tra Yoko Ono e Lady Macbeth: «Credo che Courtney – dice l’autore – abbia subito una serie di traumi orribili fin dalla più tenera infanzia. Traumi che si portò per tutta la vita e anche lei in questa vicenda è una vittima. Come meccanismo di difesa mise in campo una spietata caccia al successo. Spietata. Senza nessuna remora, neppure nei confronti della sua famiglia. A tutto questo va aggiunto il degenerare delle sue condizioni pisco-fisiche».
Ma, per chi ha amato la musica di Cobain è giusto anche immaginare un se. «Se Cobain fosse sopravvissuto la sua carriera sarebbe stata molto diversa – ritiene lo scrittore -. I Nirvana erano praticamente già finiti. Avevano avuto contrasti economici ed erano già andati in tribunale per rinegoziare i diritti. Cobain aveva in piedi un progetto con Michael Stipe e aveva realizzato dei nastri con un repertorio solista. Non credo avesse ancora voglia di fare il frontman, forse pensava a una musica molto diversa, a qualcosa di acustico. Magari oggi i Nirvana sarebbero stati però oggetto di una reunion…». «La vera eredità di Cobain – conclude Epìsch Porzioni – è una grande musica che suona ancor fresca. Smells Like Teen Spirit fu una canzone che riuscì a unire le tribù musicali giovanili dell’epoca. Lui aveva qualcosa che riusciva a entrarti nelle orecchie. La sua musica ha resistito alla prova del tempo. Non ho comunque voluto fare un santino o un ritratto abbellito riguardo alla sua vita, è per questo che quel sottobosco che si accompagnava a lui è una parte importante del libro».
OLTRE I LIBRI
I due volumi di Chinaski non sono però le uniche iniziative che ci ricordano oggi di quella stagione. Quest’estate il giornalista musicale Corbin Reiff, originario di Seattle, pubblicherà una nuova e aggiornata biografia su Chris Cornell, leader dei Soundgarden morto suicida nel 2017, intitolata Total F@#king Godhead (il titolo si riferisce a un’espressione diventata gergale tra i musicisti dell’area). «Mi sono focalizzato soprattutto sulla crescita artistica di Cornell – ha spiegato il giornalista -. Spero che dal libro emerga un’idea più compiuta di come si è evoluto come musicista e cantante dai Soundgarden e oltre. Chris una volta disse “I miei album sono i diari della mia vita”. Ogni comprensione di chi fosse deve partire da lì».
Il grande fotografo musicale Danny Clinch, già assistente di Annie Liebovitz e autore di scatti di tutte le maggiori star del rock, ha co-diretto un nuovo documentario intitolato All I Can Say su Shannon Hoon voce solista dei Blind Melon. Hoon, non era originario di Seattle ma vi si trasferì per lanciare la sua carriera. Con la sua band incise nel 1992 con Rick Parashar, il produttore di Ten dei Pearl Jam, un album omonimo che arriverà a vendere 4 milioni di copie e a produrre un singolo, No Rain, che negli States divenne un tormentone. «Era un personaggio affascinante – ha spiegato Clinch annunciando il lavoro, che ha raccolto più di 100mila dollari con il crowdfunding -. Poteva diventare istantaneamente il tuo miglior amico. Aveva un’incredibile energia. Gli piaceva divertirsi, gli piaceva la vita del rock’n’roll». Ma anche lui cadde prigioniero delle dipendenze. Diventato padre tentò di ripulirsi, ma in una sciagurata ricaduta morì di overdose di cocaina il 22 ottobre 1995. Aveva 28 anni.
Il documentario, che è stato presentato in anteprima al Tribeca Film Festival, si basa in gran parte su tantissimi video privati che lo stesso Hoon girò. «I filmati – ha detto Danny Clinch – sono un’autobiografia e sono un’anticipazione dell’era dei video che stiamo vivendo oggi. Hoon testimoniò la sua vita familiare, il suo processo creativo, la scalata al successo dei Blind Melon e la sua lotta contro le dipendenze».
Tutto nacque a Seattle e a Seattle ritorna. La città grigia dell’inizio degli anni Ottanta è diventata la sede della Microsoft, di Amazon, di Starbucks, un punto di riferimento a livello globale. Perché questa città riuscì a essere la scintilla di qualcosa di epocale? Ce lo spiega Giuseppe Ciotta: «Negli anni Ottanta Seattle era solo la città della Boeing e dell’industria del legno. I ragazzi o erano campioni dello sport scolastico o erano outsider e si dedicavano alla musica. Non c’è casa in cui non ci sia uno strumento musicale. Nonostante il clima da città di provincia c’era una scena culturale dinamica e soprattutto un grandissimo spirito di sinergia e collaborazione. Si raccoglievano storicamente in quell’area anche tante persone che non si trovavano d’accordo con il sistema, gli spiriti liberi. Questa comunità innovativa e creativa è nata da questi spunti. Gli stessi che anni prima erano stati alla base del sogno californiano».
Il sogno musicale di Seattle ancora sopravvive in tanti artisti in attività: Pearl Jam, Mudhoney, Melvins, gli stessi Alice in Chains con un nuovo frontman. Ma quella stagione iniziata 30 anni rimarrà nella memoria degli appassionati di musica. Le tragedie umane che l’hanno scandita non ne hanno diminuito la portata, l’hanno resa, nel ricordo, ancora più preziosa.

