Nella notte del 24 marzo 1736 Pietro Giannone fu arrestato in Savoia assieme al figlio, e trasferito in un luogo sicuro nella cittadina di Chambéry. Già da diversi anni le tesi anticlericali espresse nell’Istoria civile del Regno di Napoli e nel Triregno gli avevano attirato l’ostilità della Curia romana, che aveva messo la sua opera all’indice e l’aveva condannato a una vita di peregrinazioni. Giannone fu sacrificato sull’altare della diplomazia: a ordinare il suo arresto era stato Carlo Vincenzo Ferrero, marchese d’Ormea, che sperava di rinsaldare così i rapporti con Roma. Poco dopo il suo arresto, Giannone fu trasferito in alta Savoia e rinchiuso nel castello di Miolans. A dominare questi primi, difficili giorni di prigionia fu soprattutto l’angoscia al pensiero di essere tenuto separato dalle sue carte e dai suoi libri. Spinto da queste angustie, durante il trasferimento da Chambéry a Miolans Giannone riuscì a recarsi da un libraio, dove si imbatté in un’edizione delle Storie di Tito Livio, autore amatissimo fin dagli anni universitari, che gli sarà «indivisibil compagno» durante la detenzione. Fu così che, poggiando su quest’edizione «cattiva e scorretta» dello storico patavino, Giannone diede principio ai Discorsi sopra gli Annali di Tito Livio, l’opera cui anni più tardi avrebbe affidato l’ultimo, disperato tentativo di ottenere il perdono dall’Inquisizione romana e riabilitarsi così a corte.
Sull’affascinante e per molti versi tragica vicenda compositiva dei Discorsi di Pietro Giannone getta oggi nuova luce una poderosa edizione dell’opera a cura di Paul van Heck, docente all’Università di Leida (Nino Aragno Editore, euro 100,00): i tre volumi riescono nel non facile intento di coniugare acribia filologica e una prospettiva di ampio respiro sul retroterra storico-culturale da cui nacque l’opera giannoniana. La genesi dei Discorsi, su cui siamo eccezionalmente ben informati grazie all’autobiografia di Giannone e a molte missive, fu tormentata quanto la vita del loro autore: composti durante la permanenza in almeno tre diverse carceri, essi furono sottoposti a un’infinita serie di ripensamenti, aggiunte e integrazioni, che spinsero l’autore a confezionarne due belle copie nell’arco di dieci anni, entrambe pervenuteci in autografo. Diciotto mesi dopo l’arrivo a Miolans, Giannone fu trasferito al carcere di Porta del Po, a Torino, dove si convinse infine ad abiurare le sue tesi anticlericali. Il riavvicinamento alla Chiesa coincise probabilmente con la decisione di dare all’opera abbozzata nei mesi precedenti una fisionomia più definita e, soprattutto, di offrirla a Carlo Emanuele III come ammaestramento per il figlio Vittorio Amedeo, allora undicenne.
Venne così a delinearsi un capitolo importante, e finora meno noto, della lunga fortuna di Tito Livio nella storia del pensiero politico moderno. Una fortuna nata, certo, dai Discorsi sopra la prima Deca di Machiavelli, ma sviluppatasi anche nei decenni successivi del XVI secolo, benché con esiti diversi e in generale più modesti (si conservano Discorsi di Vincenzo Dini, Aldo Manuzio il Giovane e Antonio Ciccarelli). A questa tradizione Giannone si riallaccia con consapevolezza fin dalla Prefazione all’opera, riconoscendo l’importante ruolo svolto da Livio nella formazione dei «più rinomati e famosi capitani d’esserciti ed i più savi prìncipi di Europa». Ciò che rendeva gli Ab urbe condita libri un terreno ideale per la formazione della classe dirigente era, naturalmente, la possibilità di illuminare le istituzioni che avevano permesso lo sviluppo della potenza romana. Ma al di là delle ragioni contenutistiche, Livio offriva soprattutto un modello di pedagogia morale da riattivare e ricollocare nel nuovo contesto geo-politico europeo. Questo aspetto emerge chiaramente nella Prefazione giannoniana. A interessare l’autore è soprattutto l’obiettivo didattico che distingue l’opera liviana dal resto della storiografia romana e, soprattutto, da Tacito, altro grande autore in voga alla sua epoca, che tuttavia non offriva lo stesso slancio esemplare, dal momento che la sua opera si era concentrata sul lento disfarsi dell’impero romano, anziché sul suo avvento.
A dominare il programma pedagogico giannoniano è la questione religiosa, certamente il motivo di maggior preoccupazione per l’autore. Nei tredici discorsi del I libro, Livio è principalmente impiegato per ricostruire le istituzioni religiose di Roma antica, allo scopo, in qualche modo paradossale, di tracciare un itinerario storico che culmini con il trionfo del Cristianesimo. Questa peculiare prospettiva, che determina un allargamento dell’indagine oltre i confini cronologici delle decadi liviane superstiti, è imposta a Giannone dalla necessità di liberarsi del marchio di eterodossia e ritrovare così il proprio posto nella classe intellettuale europea. La sottomissione alla Chiesa di Roma, peraltro, non gli impedisce di propugnare anche nei Discorsi la propria visione laica della società. Nella storiografia liviana, infatti, Giannone non vede soltanto un modello di pedagogia morale e politica, ma soprattutto una lezione di lucido scetticismo nei confronti della religione, naturale riflesso dell’«aureo (…) secolo di Augusto» dominato dalla filosofia e dall’onestà intellettuale, che agli occhi dell’autore sembra per certi versi anticipare l’epoca dei lumi.
I Discorsi offrono così l’occasione di gettare uno sguardo entro i confini di una provincia peculiare del vasto Fortleben liviano, quella legata alle dispute sulle posizioni religiose dello storico. Già negli ultimi decenni del Cinquecento, la notevole mole di resoconti di prodigi inclusa nell’opera liviana aveva attirato l’attenzione degli studiosi, senza dubbio influenzati dalla temperie controriformista. Nella sua Bibliotheca selecta del 1593, il gesuita Antonio Possevino aveva additato Livio come autore superstizioso, e la stessa posizione fu assunta da due grandi nomi della nascente filologia classica: Giusto Lipsio e Gerhard Voss, che pure riconosceva che nell’era pagana la superstizione era pur sempre preferibile all’ateismo.
A questa lettura si era opposto, alcuni anni prima della composizione dei Discorsi, il deista irlandese John Toland, che nel suo Adeisidaimon (Amsterdam 1708-’09) aveva individuato in Livio un rappresentante insigne di laicità, che guardava alla religione con lucido distacco, come a uno strumento essenzialmente politico, e sulla base di questa apologia aveva inteso sfidare la religione tradizionalmente intesa e proporre il proprio ideale materialistico-panteistico. Spinto proprio dall’opera di Toland, anche Giannone elegge Livio a propria guida nella costruzione di un razionalismo illuminato, che elevi l’uomo al di sopra dell’oscura superstizione, ma tenta anche di far collimare questa immagine dello storico con la propria adesione all’ortodossia cattolica.
Un’operazione di sintesi ardua, che mostra fino a che punto la figura intellettuale di Livio abbia influenzato il dibattito culturale di età moderna ben al di là della mera erudizione, infiltrandosi tra le pieghe delle grandi dispute dottrinarie fino all’avvento dell’Illuminismo. In quanto storico della repubblica romana per eccellenza, Livio offrì alla classe intellettuale europea non soltanto una fonte ricchissima di dati storici, antiquari e culturali, ma l’occasione di un’interlocuzione feconda e ineludibile con l’età che aveva plasmato l’unità politica e culturale dell’Occidente. Se è vero che più di ogni altro genere letterario antico la storiografia ha bisogno dei suoi lettori, cui è affidato il compito di interpretare i fatti storici e, in definitiva, di dotarli di senso, la ricezione di Livio attraverso i secoli non può che rappresentare la prova tangibile di questo dialogo incessante.
Giannone, razionalismo liviano per sopravvivere al carcere
Illuminismo italiano. Un’edizione «di fortuna» di Livio fece compagnia a Pietro Giannone, messo all’Indice e detenuto in Savoia: i suoi Discorsi sopra gli Annali escono in tre tomi da Aragno, a cura di Paul van Heck
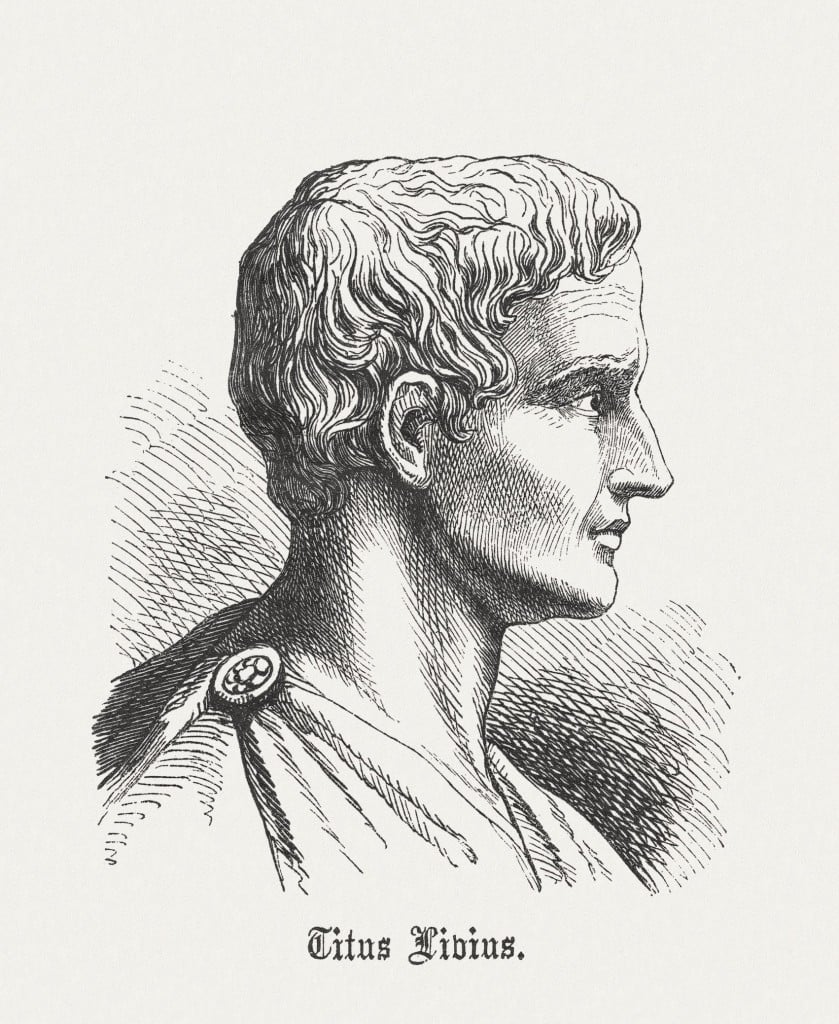
Xilografia con il profilo dello storico romano Tito Livio,1864
Illuminismo italiano. Un’edizione «di fortuna» di Livio fece compagnia a Pietro Giannone, messo all’Indice e detenuto in Savoia: i suoi Discorsi sopra gli Annali escono in tre tomi da Aragno, a cura di Paul van Heck
Pubblicato 5 anni faEdizione del 14 luglio 2019
Pubblicato 5 anni faEdizione del 14 luglio 2019
