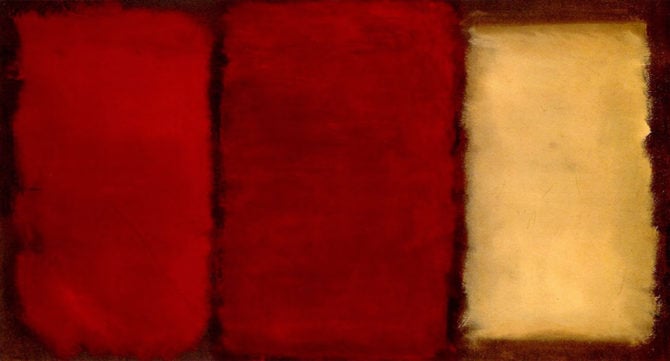Pare che fra tutte le opere prodotte dal suo genio eclettico, Goethe fosse particolarmente orgoglioso della teoria dei colori, trattato che considerava un importante passo in avanti nel progresso della filosofia e dell’ottica. «Sono stato l’unico che ha visto chiaro in questa difficile scienza del colore, e sono cosciente di essere superiore a molti saggi», ebbe a dire. Notevole esempio di trattatistica romantica, e quindi non riducibile a un’opera di pura divulgazione scientifica, lo studio prende in considerazione anche la dimensione soggettiva e spirituale del colore, e quindi il ruolo attivo dell’osservatore nella messa a punto di una simbologia e di una poetica legate a particolari sfumature cromatiche.
Due secoli dopo, con Antropologia del turchese Riflessioni su deserto, mare, pietra e cielo (traduzione di Sara Reggiani, Black Coffee, pp. 356, € 18,00) la scrittrice naturalistica Ellen Melloy si dedica a un personale viaggio nel panorama e nel colore, scegliendo di focalizzarsi sul turchese, tonalità sfuggente carica di storia e di storie. Al posto dell’Italia di Goethe, il deserto infuocato del sudovest americano: un territorio che, con le sue mesas e i suoi canyon rossi immersi in una luce abbacinante, è «un mondo di bellezza e violenza». Il deserto occupa da sempre un peso simbolico notevole all’interno dell’immaginario naturalistico statunitense di ascendenza europea.
Come scrive Henry Nash Smith nel suo classico studio, Virgin Land, se la prima immagine che venne associata al Nuovo continente fu quella del giardino dell’Eden, con l’epoca della frontiera si contrapposero a questa utopia le distese aride e letali del deserto americano. Ma grazie alla sua penna, la geografia disseccata dello Utah dove Ellen Melloy spese gli ultimi anni di vita in una casa costruita insieme al marito, brulica di vita: impariamo a conoscere il carattere dei corvi, osservatori astuti e ironici, e le schive pecore Bighorn, animali che sembrano apparire dal nulla come se abitassero le pieghe del tempo. Nello sguardo della autrice si ritrova la lezione di Ralph Waldo Emerson che raccomandava di farsi «occhio trasparente», assorbendo tutto ciò che la natura ha da offrire.
Persino il mondo delle rocce e dei minerali acquista una vita nella visione radicalmente olistica del libro: da qui la fascinazione con la turchese, pietra dai poteri benigni venerata dai Nativi, che risponderebbe all’anima di chi la indossa cambiando colore. Turchesi sono anche le centinaia di migliaia di piscine sparse nel paesaggio riarso della California, stato natio che la scrittrice sogna di attraversare a nuoto, saltando da un rettangolo d’acqua azzurra all’altro. Colore transitorio, lo definisce Melloy, come la striscia intermedia che unisce il blu del cielo al rosso del terreno; un limbo esperienziale che, proprio grazie alla natura sfuggente, si apre a una pluralità di simboli e a emozioni complesse.
Ma il libro si muove anche nella storia famigliare dell’autrice, sulle tracce di un ricco antenato schiavista nei Caraibi, o nei quadri evanescenti dei ricordi d’infanzia, in una dimensione personale, emotiva e spirituale sempre messa al servizio dell’ecologia, o meglio, di una eco-elegia, perché, come scrive la stessa Melloy, la scrittura naturalistica è «la letteratura della perdita, un’elegia, un lamento funebre». Nel suo primitivismo tipicamente americano ma non ciecamente avverso al progresso, la scrittrice sembra voler fermare sulla carta un mondo che si sta sgretolando, da una parte a causa della scellerata gestione delle risorse naturali, dall’altra perché, come scopriamo già dal primo dei quindici saggi che compongono questo libro, le è stata diagnosticata una «riduzione dell’acutezza mentale», con il rischio concreto di scivolare in ogni momento e all’improvviso nel vuoto cognitivo della demenza.
Ogni parola si fa, allora, registrazione febbrile della psiche sull’orlo della dissoluzione, drammatica ma anche celebrativa della vita. Nella riverenza nei confronti del mondo naturale e dei suoi misteri, che si riflettono nell’onnipresente, feconda ambiguità del turchese, c’è la volontà di ritrovare una dimensione sacra nel rapporto con il pianeta, distrutta da quella macchina impazzita che è l’odierna società del consumo. Come in Walden di Henry David Thoreau, inevitabile metro di paragone per qualsiasi scrittore statunitense votatosi alla natura, c’è in Antropologia del turchese il desiderio di tornare a «succhiare il midollo della vita», spogliandosi del superfluo e del nocivo, e partecipando, come i pionieri europei che per primi si addentrarono nelle foreste e nei deserti del continente, a quella che la critica Sara Spurgeon ha definito «l’eucarestia della natura selvaggia», archetipo psicologico e letterario di un rinnovamento simbolico dell’unione tra uomo e natura.
Simbolico ma nel caso di Melloy anche schiettamente concreto, perché rendendo la scrittura prassi di vita, diventa un esempio mirabile della forza dell’ideale pastorale statunitense e della sua sopravvivenza, sospeso a metà tra la corruzione della civiltà in espansione e la forza primordiale e rigenerante dell’ambiente minacciato.