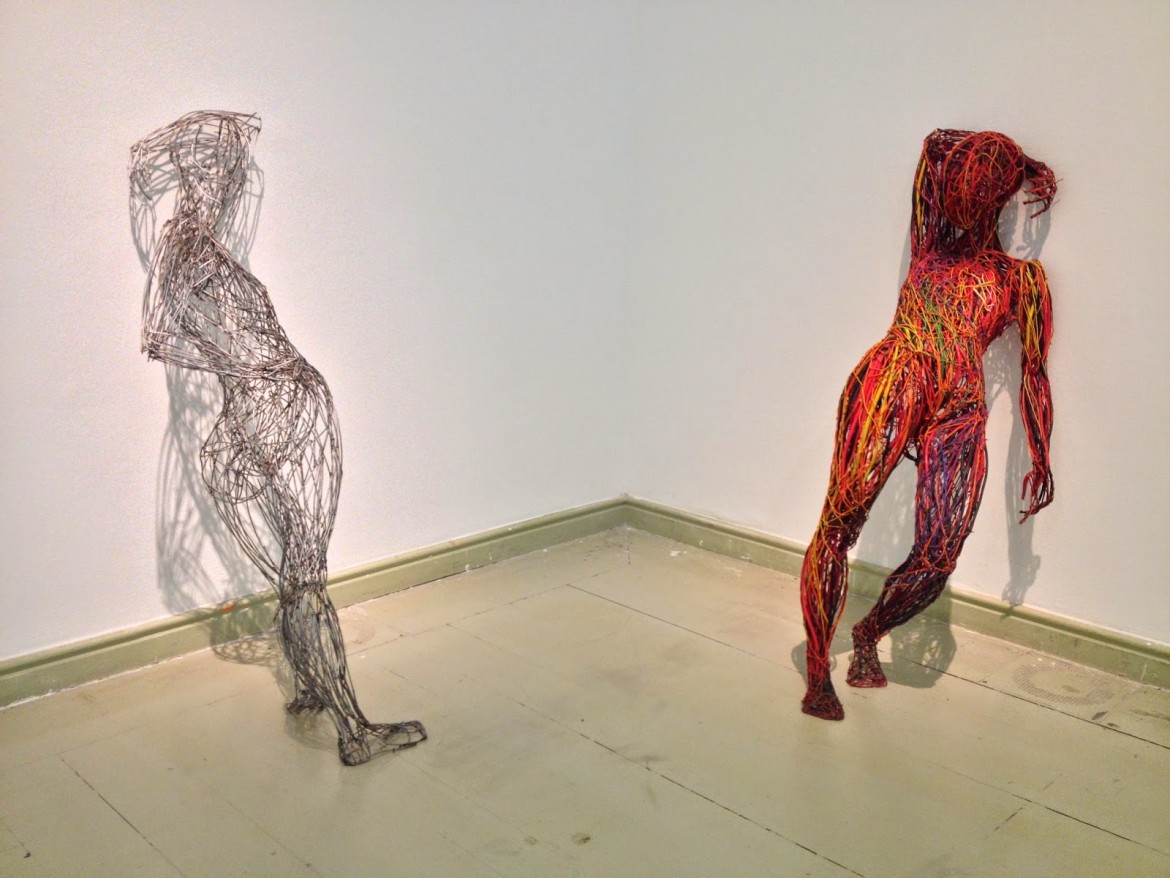Il ritmo della scrittura di Edina Szvoren rimanda alla musica, che è peraltro parte integrante della sua vita: per formazione e per lavoro, infatti, la scrittrice ungherese insegna solfeggio e teoria musicale al Liceo Bartók di Budapest. Ora, nella preziosa e curata collana Elit di Mimesis – che quest’estate aveva pubblicato anche il Montecristo comunista di Noémi Szecsi e che apre spazi letterari europei centro-orientali e balcanici nuovi – è appena uscito, (anch’esso nella traduzione di Claudia Tatasciore) Non c’è e non deve esserci (pp. 262, euro 18), un volume di racconti.
Come nelle tre precedenti raccolte di prose brevi finora pubblicate in ungherese e tradotte in diverse lingue, Pertu (Diamoci del tu, 2010), Nincs, és ne is legyen (Non c’è e non deve esserci, 2012) e Az ország legjobb hóhéra (Il miglior boia del Paese, 2015), anche qui uno dei temi principali riguarda il sistema dei rapporti famigliari e interpersonali e dei difetti di fabbricazione non riparabili che sono loro intrinsechi.
Ne domandiamo conferma a Szvoren: «Non so, direi piuttosto che i protagonisti dei miei racconti si fanno illusioni sulla famiglia, anche grandi illusioni». Il mondo cambia a seconda di come lo si guarda, da vicino o da lontano, il segreto e il mistero della nostra esistenza è anche questo, come ci dice la prima voce narrante del racconto che dà il titolo al volume: «Ho il pianto in gola. A Mamma voglio più bene di ogni altra cosa al mondo, ma da vicino tutto cambia, come i pois del fazzoletto, che in verità sono dei quadratini pelosi. Per via di Mamma devo fingere la verità». Le parole, come anche la verità può essere minacciosa.
Come definirebbe la sua lingua letteraria, che appare severa, netta, precisa eppure «salvavita», come la chirurgia ricostruttiva?
Non credo che la lingua letteraria possa salvare la vita, che sia la mia o quella di un’altra persona, e neanche che sia capace di aiutare il lettore se è davvero nei guai. Il modo in cui la letteratura ci influenza è più indiretto, impalpabile, inafferrabile. Ci aiuta a immaginare altre prospettive che nella vita quotidiana sono forse troppo minacciose per noi. Per quanto riguarda la mia lingua, mi piace la prima persona singolare, perché da lei spero mi giunga intensità, incisività, e mi permette di non fare il nome della voce narrante. Da quando ho cominciato a scrivere, mi piace evitare che la figura al centro del racconto abbia un nome, forse perché le cose, le persone importanti e tanto vicine da toccarle, le persone non equivocabili, non hanno un nome. In realtà non c’è un nome per l’amore, per la rabbia e neppure per la sofferenza, che sentiamo come imprecise e grossolane, tanto che a volte il fatto stesso di essere costretti a dar loro un nome ci sembra un atto di violenza.
Finora ha pubblicato esclusivamente racconti. A cosa si deve questa sua scelta? Lei sa bene che il racconto ha fama di genere letterario più povero del romanzo…
Non capisco perché non mi chiedono mai la ragione per cui scrivo racconti e non poesie, sebbene quel che ho scritto a partire dal mio secondo volume sia abbastanza vicini alla poesia. I miei sono racconti densi, ellittici: adatto gli elementi epici alla frase e non il contrario, come avviene nel romanzo. In un certo senso è come se questi elementi si inserissero in una sequenza sdrammatizzata, la mia attitudine non è quella dello story-telling. Nello stesso tempo a quanto pare non sono capace di rinunciare all’elemento temporale proprio dei generi narrativi.
Il tempo nella narrazione mi è necessario. Sviluppo la mia riflessione secondo altre strutture, non mi attrae la totalità, i dettagli che vanno a collocarsi all’interno di un tutto. Anche come lettrice, quel che amo nel romanzo è che un testo sappia di se stesso che il Molto non è il Tutto. Lo dico perché ci sono innumerevoli esempi di romanzieri che sembrano credere in una sorta di pienezza, di assoluto, sembrano dare per scontato un punto di vista da cui vedere l’Intero, mentre a me capita, piuttosto, di vedere frammenti, macerie, detriti. Tuttavia, scrivere racconti non è stata la conseguenza di una scelta consapevole, e anche riconoscerlo è stato un lavoro, che mi è costato del tempo, non ci sono arrivata prima dei trent’anni.
Continua a considerare la scrittura un «compito», come ho letto in una sua intervista?
Non so a cosa pensassi, quando l’ho detto, so solo che la scrittura è una delle cose più importanti nella mia vita. E so con certezza che non esiste come «compito», perché non ne abbiamo altri, nella nostra vita, se non quelli di nascere e morire. E fino alla fin dei miei gironi passerò il tempo scrivendo e leggendo.
Un tema molto importante nella sua raccolta «Non c’è e non deve esserci» è la convivenza, tanto nella società quanto nella vita privata, di verità e menzogna, che si alternano o si presentano in contemporanea.
Sì, è un tema davvero molto importante, anche se a me pare che in un certo senso ogni libro ne parli. Se posso permettermi di essere categorica, ogni libro parla degli stessi temi, e ciò che differenzia noi scrittori sta non tanto nella scelta dei tempi, né in quella degli elementi di superficie, né nei motivi letterari, bensì nella ampiezza del nostro angolo visuale, nella precisione con cui mettiamo a fuoco quanto vediamo, in come strutturiamo le parti del discorso, nella scelta del ritmo, o del modo in cui facciamo combaciare i confini del mondo del testo con i confini delle conoscenze del lettore. Non è la scelta il tema a influenzare il lettore, almeno non tanto quanto queste caratteristiche più strutturali e al tempo stesso meno visibili, anche se non sempre ne è consapevole.
*
Edina Szvoren oggi alle 17.30 sarà a Milano (presso la Fondazione Stelline, Sala Verdi corso Magenta 61) per presentare il suo libro appena tradotto da Mimesis nell’ambito di Bookcity. In dialogo con l’autrice: Claudia Tatasciore, Eugenio De Caro, Chica Bighé. In collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore Cremona e con l’ufficio Informazione del Parlamento Europeo