Nelle fiammeggianti vicende del cinema latinoamericano degli anni Sessanta e Settanta, tra Glauber Rocha e il cinema cubano, e in particolare nel cinema argentino tra La hora de los hornos di Solanas e Getino, la scuola di Santa Fé di Fernando Birri che rivoluzionava il documentario, le proiezioni clandestine del cinema militante, il nome di Edgardo Cozarinsky è tra quelli che gli appassionati di cinema associano al cinema dell’esilio, del cinema nomade, ma soprattutto a un artista che fa del cinema e della letteratura un territorio senza confini delimitati. Autore di romanzi, saggi e film, nato a Buenos Aires nel 1939, figlio di immigrati ebrei ucraini arrivati in Argentina nell’Ottocento da Odessa e Kiev, è scomparso all’età di 85 anni, tornato nella sua città natale dopo essere vissuto a Parigi tra il 1975 e il 1989.
TRA I GIOVANI cineasti cresciuti in un clima di avanguardia, una generazione chiamata dei «cineclub», di un underground dalle diverse sfumature, con l’uso del passo ridotto, come Miguel Bejo, Hector Lescovich, Rafael Filippelli, Edgardo Cozarinsky fa il suo esordio con un film dove è evidente l’influenza letteraria, Puntos suspendidos presentato a Cannes nel 1971. Quei punti di sospensione saranno emblematici di tutto il suo percorso creativo effettivamente «in sospensione» tra varie culture e lingue, tra due continenti (America Latina ed Europa, Buenos Aires e Parigi), tra diverse forme d’arte, dove il montaggio entra nella frase scritta e i personaggi in scena devono fare i conti con il tempo sospeso, sequenze di sovrapposizioni e assonanze.
SECONDO una linea letteraria tracciata da lui stesso («leggevamo libri che nessuno leggeva» alludendo a Roth e Danilo Kis), è passato da Stevenson a Sebald, da Silvina Ocampo, Adolfo Bioy Casares che gli fanno incontrare Borges con cui collaborerà, fino a rileggere negli ultimi anni tutto Dostojevski, per poi passare «forse» a Conrad (ma non sappiamo se abbia fatto in tempo). Un saggio sul «pettegolezzo» come forma letteraria in Henry James e Proust viene premiato nel 1973, nel 1974 pubblica un saggio su Borges e il cinema, ripubblicato e ampliato più volte.
Poi esce dal paese un anno prima del colpo di stato del 1976 ma quando già erano ben presenti le avvisaglie per quanto riguarda la stretta sulla vita culturale, le cancellazioni dei risultati raggiunti su sviluppo, organizzazione e produzione, dove le organizzazioni sindacali potevano discutere i progetti in lavorazione.


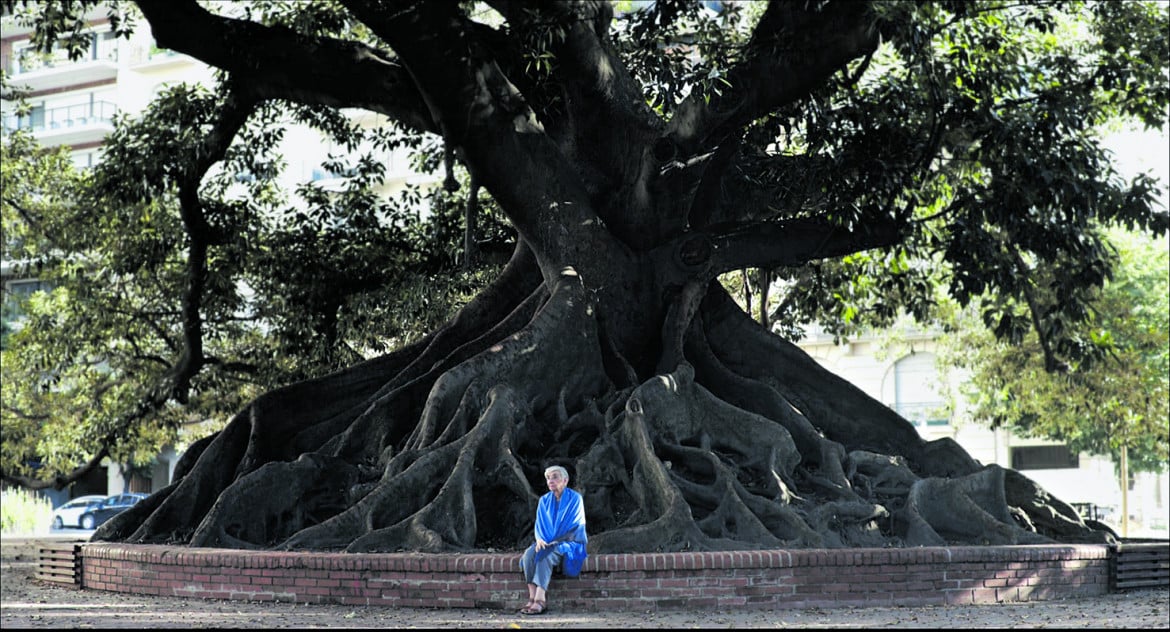
In Francia Cozarinsky si dedica inizialmente a progetti tra finzione e documentario, tra saggio e riflessione, come La Guerre d’un seul homme (1981), dove mette a confronto di diari di Ernst Junger durante l’occupazione tedesca in Francia e i notiziari francesi, e parecchi altri videosaggi per la televisione negli anni ’80 e ’90 dove la materia letteraria e artistica giocano il ruolo principale come Jean Cocteau: autoportrait d’un inconnu, adatta da un racconto di Borges Guerriers et captives (1989), Entretiens du Louvre, La barraca.Lorca sobre los caminos de España, Citizen Langlois sul grande conservatore della Cinémathèque come anche Le cinéma des Cahiers (2001) cinquant’anni di storia d’amore per il cinema, Chaplin e Chaplin Today, collana curata da Serge Toubiana, crea un doppio gioco emblematico di musica e immagini con Le violon de Rotschild (1996) dal racconto di Cecov che aveva ispirato il compositore Benjamin Fleischmann, poi orchestrato da Shostakovich e proibito nel 1968.
Firma al ritorno in Argentina Tango deseo nel 2002, sulle coreografie di Ana Maria Stekelman, tra tango e danza contemporanea, riscoperta di un genere musicale che la nuova generazione relegava ai tempi passati, alla visione convenzionale e anche un po’ reazionaria del paese (e che solo recentemente è stata accettata r rivisitata anche dai giovani). Nello stesso anno per ribadire la riscoperta scrive il romanzo Milongas.
Torna alle atmosfere di Buenos Aires con le storie intrecciate di Apuntes para una biografia imaginaria (2003) che sembrano appunti di personaggi per un romanzo con le note malinconiche di Ronda nocturna (2005) dove il giovane Victor tra prostituzione e droga cerca di difendersi dalla violenza, un film che rimanda alle atmosfere del romanzo En el ultimo trago nos vamos alla ricerca dell’ultimo bar aperto, dell’ultimo bicchiere, moltiplicazione di immaginario, vincitore del «Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez».
CON IL ROMANZO Vudu urbano aveva creato un caso letterario nel 1985 accompagnato dagli scritti di Susan Sontag e Guillermo Cabrera Infante, la personale esperienza dell’esilio «come in uno specchio deformato», «l’esperienza autobiografica come saggio, il saggio come narrazione».
È sarà negli anni del ritorno in patria che la sua produzione letteraria si fa più intensa, con una vasta produzione di saggi, racconti e romanzi tra cui aggirarsi come in un labirinto di rimandi: tra gli ultimi Dark, dove ci muove in una città che non esiste più, il ricordo della Buenos Aires degli anni ’50, tra i primi degli anni duemila La novia de Odessa, passaporti rubati, morti che non perdonano, destini erranti tra Vienna Buenos Aires, Lisbona, Budapest e Odessa.

