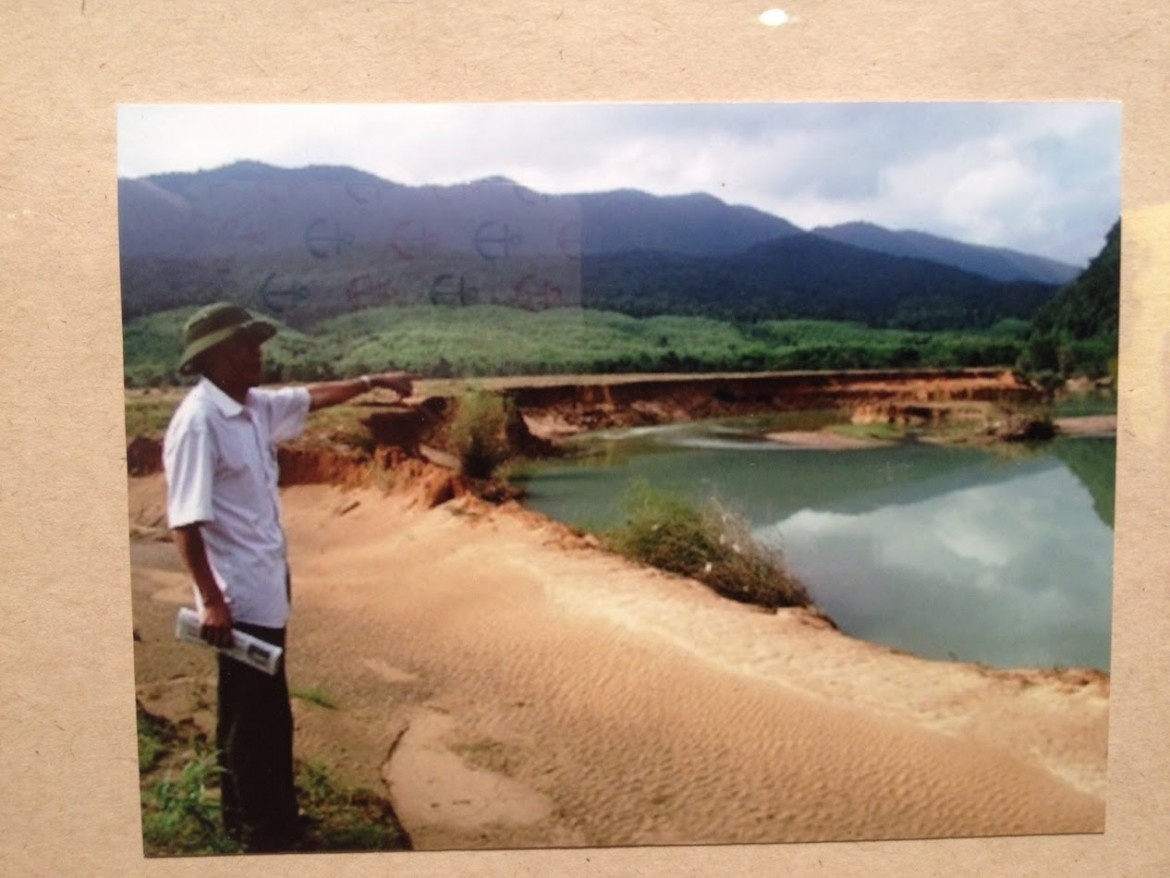Li vedi in sequenza, in foto sgranate, sporche, prese per caso, anche se quegli uomini e donne – soprattutto neri – sono smaccatamente in posa. Guardano l’obiettivo e alzano la «merce», in un misto di orgoglio e imbarazzo: una lattina, un involucro con cibo congelato, un pacchetto di qualcosa di commestibile. Non si conoscono uno con l’altro, eppure condividono tutti lo stesso destino: sono finiti sulle immagini segnaletiche che i gestori dei negozi di alimentari di Brooklyn hanno attaccato alle pareti, sono «thielves of food», ladri di misere cose da mangiare e sono usciti dall’anonimato il giorno in cui hanno dovuto interpretare una sorta di segnaletica umana. I padroni delle drogherie li mettono in bella vista, còlti in flagranza di reato, li usano come monito per chi sta in procinto di varcare la soglia. Solo che quei ritratti di «criminali per fame», quegli identikit della disperazione metropolitana adesso sono usciti dall’angusta prigione dello sguardo riprovevole di quartiere e sono sbarcati dritti dritti alla Biennale di Lione. Hanno viaggiato fino in Francia. Ci è voluto l’occhio addestrato a cogliere la precarietà della strada dell’algerino Mohamed Bourouissa (1978, Blida, vive e lavora a Parigi) per far loro cambiare tragitto fisico e concettuale.

Da personaggi casuali di una galleria di micro-fuorilegge si sono trasformati in un archivio vivente sociale, andando a comporre una tassidermia americana dell’illecito non soltanto individuale ma collettivo: il loro aspetto stralunato non è altro che un’accusa allo Stato e al degrado e abbandono in cui il potere governativo li obbliga a vivere. È così che gli artisti ribaltano i segni della realtà contemporanea, spesso cogliendo frammenti dispersi e ricucendoli insieme lì dove gli altri tirano dritto, senza vedere. Bourouissa lo fa anche in un gioco di specchi deformanti sui cofani delle macchine, serigrafando immagini scattate a Filadelfia, nel Fletcher Street Urban Riding Club: qui si diventa cow-boy per trovare uno spazio nella vita, per reinserirsi in qualche binario che non porti alla disperazione («mi interessa molto la mitologia americana e le sue declinazioni», dice Mohamed). E, ancora una volta, sono gli artisti a collaborare a questo progetto, disegnando costumi insieme ai cavalieri.
La tredicesima edizione della Biennale di Lione (direzione artistica di Thierry Raspail), è affidata quest’anno alla cura di Ralph Rugoff, timoniere alla Hayward Gallery di Londra, considerato uno dei cento critici e operatori nel campo dell’arte più influenti del mondo. Nella città francese, parte da una scommessa che sembra semplice, quasi ovvia: rispolvera un binomio dal suono desueto, La vie moderne. Per farlo, però, apre il sipario su un teatro temporale che abbraccia insieme passato, presente e qualche profezia da disseminare sul futuro. Numi tutelari, Baudelaire e Benjamin, ma anche Raymond Depardon, Jacques Tati e Charlie Chaplin.
Per questo, l’idea della «modernità» va considerata più come un palinsesto che conserva tracce anteriori e, per il curatore della rassegna, non è altro che un «riposizionamento» dentro ciò che è contemporaneo, attraversando le mutazioni geografiche, sociali, urbane e anche psicologiche. Ma, «a differenza di scienziati, giornalisti e filosofi, gli artisti non hanno bisogno di fornire risposte, devono solo mettersi al servizio della loro attitudine all’esplorazione»: basta che sollevino domande, si allontanino dagli itinerari impigliati nella banalità, frughino in mezzo alle possibili narrazioni alternative del mondo che li circonda.
E quella modernità proposta nel titolo torna sotto varie forme in questa Biennale che si estende alla Sucrière, al Mac e al nuovo Musée des Confluences – qui con un’unica installazione-video di Yuan Goang-Ming, da Taiwan, Before Memory, indagine aerea e terrestre sulle rovine architettoniche e gli spazi desertificati, gli interstizi abitati solo dal ricordo. In fondo, va valutata ala stregua di una parola «ponte», con un dna mutante. Una parola in cui precipitano le macerie della Storia, pur con una buona dose di ironia. He Xiangyu, ad esempio, racconta la corsa capitalista della Cina con una metafora folgorante: in una grande vetrina ha esposto il suo Cola Project -Extraction. Nel 2008, ha speso l’intero l’anno per far bollire una quantità spropositata di bevande alla cola (127 tonnellate), trasformando quel prodotto della globalizzazione in una montagna di carbone.
Il turco Ahmet Ögut (classe 1981, vive tra Berlino e Istanbul) ha scelto di coniugare i due «fari» della vita moderna lionese ai suoi albori: i fratelli Lumière e l’industria del tessile. Li ha uniti facendo scorrere su vecchie macchine da cucire la celebre uscita degli operai dalle fabbriche. Quel protofilm venne girato nel 1895, ma nel marzo scorso, il suo 120 anniversario è stato festeggiato con un reenactment, una rievocazione in cui l’artista Ögut si è inserito per chiedere ad alcuni figuranti di uscire dalla fabbrica mostrando il logo di luoghi di lavoro dismessi e aziende fallite. Per sbirciare dentro quello squarcio di controstoria, i visitatori devono azionare il pedale della macchina da cucire e faticare fisicamente, se vogliono «sapere» e conoscere quei fantasmi.
Anche l’argentino Miguel Angel Ríos fa i conti con alcuni ghosts, riprendendo in video paesaggi desertici, discariche dell’umanità dove la sequenza di baracche che piombano dal cielo a popolare la zona viene interrotta da una presenza magica, un cubo trasparente di vetro, magico, leggero, una specie di sfida lanciata contro l’opacità dei muri e delle frontiere. Pure l’algerino Massinissa Selmani fa scorrere il mondo su alcuni cubi, animando i suoi disegni. È un condominio dove immagini private e momenti comunitari di mescolano, mentre poco oltre, si «proietta» sul mare il mosaico degli sbarchi dei migranti, anche qui mixato a immagini stranianti in un collage del paradosso.

Infine, per chiudere il cerchio, a confondere del tutto i confini tra mondo conosciuto e ignoto ci pensa il francoalgerino Kader Attia: in un enorme open space vanno in onda le interviste a oracoli, sciamani, stregoni e psichiatri occidentali nel tentativo di «classificare» la psichiatria e consegnare una impossibile e decisiva etichetta ai due (falsi) estremi di follia e normalità.