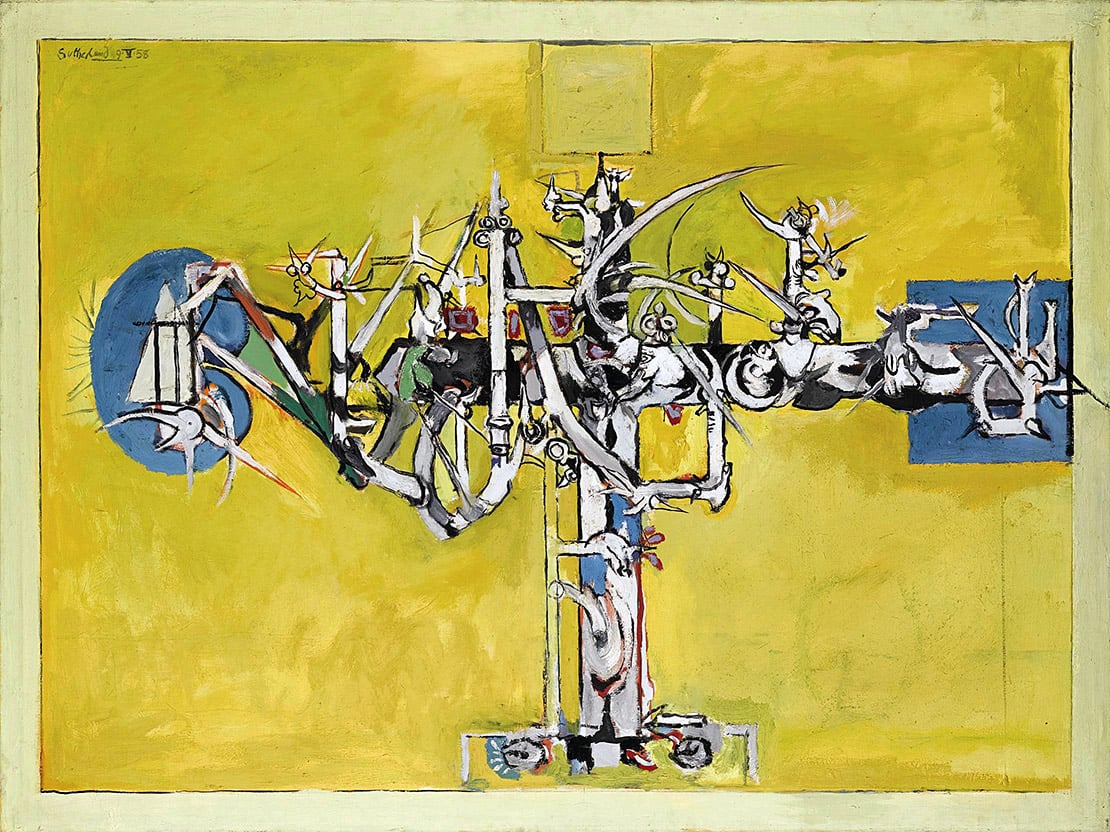Incontrai per la prima volta Rodolfo Quadrelli nel 1974. Andai a trovarlo nella sua casa milanese, al numero 13 di via Cosimo del Fante, a pochi passi da Porta Lodovica. Avevo letto Il linguaggio della poesia (Vallecchi, 1969), Filosofia delle parole e delle cose (’71) e Il paese umiliato (’73), entrambi pubblicati da Rusconi, oltre naturalmente all’esordio poetico di Apologhi e filastrocche (’72), sempre stampato per i tipi dell’editore fiorentino, nella collana diretta da Geno Pampaloni. In quel lasso di tempo storico e poi per tutto quel decennio di aspre tensioni ideologiche, di forti passioni politiche e civili, di irriducibili e spesso violente divisioni, la sua voce mi pareva segnata da una necessaria tempestività, il suo dire morale e la sua pronuncia solitaria, appartata e altera esprimevano lampi di prezioso sapere oppure e insieme di limpido e onesto controcanto – ma la luce che quella pietra effondeva non poteva che raggiungere coloro i quali, chiamiamoli pure i felici pochi, ben volentieri osavano avventurarsi nello spazio – in quella tempestosa e intemperante stagione considerato infetto ovvero di destra e conservatore o addirittura reazionario – concesso da Rusconi e in particolare, per l’acribia e l’impegno meticoloso e lungimirante, da Alfredo Cattabiani a scrittori e saggisti, per restare agli italiani, come Cristina Campo, Sergio Quinzio, Rosario Assunto, Quirino Principe, Guido Ceronetti e, appunto, Quadrelli (certo, poi, vi si poteva incontrare anche il nome di qualche avventuriero frustrato e grottesco della politica e della cultura magari impegnato, figurarsi!, a spiegare in un libro di un centinaio di pagine che cosa non aveva capito Marx).
Quel lontano pomeriggio mi trovai davanti a un uomo di trentacinque anni (era nato infatti nel 1939) con lo sguardo e il sorriso da ragazzo. Fu accogliente e benevolo, come sempre in seguito si mostrò, generoso di parole e di gesti fraterni, e se in un solo caso ebbe un impulso di impazienza, ecco, l’attimo dopo se ne pentì. Nel prosieguo mi fu ancora più evidente la sua bontà insieme alla fermezza (mai normativa però) delle idee, la sua fragilità accanto alla capacità di indignarsi e anzi di sdegnarsi senza mai tuttavia abiurare a quel sentimento di compassione che lo distingueva. La ricerca della fraternità era il suo stigma e sebbene quasi mai riuscì a vedersela ricambiata, in specie nel mondo della letteratura che preferì piuttosto ignorarne la presenza e la militanza sia critico-saggistica che poetica.
Il 2 novembre del 1975, verso sera, lo chiamai al telefono per parlare dell’assassinio di Pasolini. Era sconvolto e la mattina dopo, nell’unico necrologio a pagamento apparso sul Corriere della Sera, scrisse, pur non avendolo mai conosciuto, di piangere «come un fratello» la morte dell’«uomo libero» e del «grande poeta» che «lottò da solo per l’antica dignità del mondo». Né, ancora, posso dimenticare l’incontro imprevisto e per questo incredibile, nell’estate del 1979, al bar della piazzetta di Nibbiano, un piccolo centro dell’Alta Val Tidone, in provincia di Piacenza, dove Quadrelli – assieme alla moglie Romana e ai due bambini – si recava in villeggiatura (precisamente nella minuscola frazione di Caminata). I suoi occhi, oltre le lenti, brillarono di stupore e di contentezza («la felicità degli incontri casuali»), mi esortò subito a dargli del tu e così, per giorni, le mattine divennero nostre, lui portava il pallone e si andava a giocare nel campetto sterrato del paese.
Quel paesaggio gli era assai caro, di certo gli ricordava (lui nato a Milano) gli anni dell’infanzia, la sua «vita rustica», la chiamava così, trascorsa a Stradella, nell’Oltrepo Pavese, l’«umana compagnia» dei coetanei, la spensieratezza vissuta in piena libertà, i vagabondaggi che più avanti si protrassero nella periferia della città, laddove le case lasciavano dolcemente il posto alla campagna. Vale la pena di riportare quanto scrive in una nota autobiografica in terza persona che posseggo manoscritta e che ora ritrovo in appendice a Tutte le poesie (1960-1984), a cura di Fiorenza Lipparini e con uno scritto di Quirino Principe (Effigie, pp. 187, euro 18,00). Le illusioni «già insidiate, furono distrutte nei primi anni ’60», scrive, innanzitutto «dalla brutalità del “miracolo economico”, che egli visse soggettivamente come un trauma e che giudica obiettivamente una tragedia (…) La sua scelta religiosa è avvenuta gradatamente, e non lo ha mai condotto ad abbracciare pienamente l’ortodossia cattolica. Si è definito “cattolico di desiderio”, nel proposito, cauto o incauto, di darsi uno status. Riconosce i tratti della società moderna non tanto sotto le specie dell’alienazione e dello sfruttamento quanto sotto quelle dell’empietà, ovvero della cancellazione di ogni traccia di sacro».
Questo doppio nodo, privato e oggettivo, spiega la traiettoria di Quadrelli, proprio a partire dal rifiuto inappellabile degli «idoli della modernità». Ne chiarisce la saggistica (e si legga in proposito anche Il senso del presente, Rusconi 1976) e quella cifra dura, antilirica, si potrebbe dire antimelodica della scrittura in versi con l’utilizzo di forme chiuse in schemi metrici come il madrigale, il sonetto, la canzone-ode. Lo si verifica adesso, senz’ombra di dubbio, nel volume che, dagli Apologhi e filastrocche al postumo e bellissimo La fine del tempo (Scheiwiller 1986), ne raccoglie l’intera produzione. Pampaloni parlò di «rime petrose» e di «aspre metafore del pensiero» sostenute «da un duro orgoglio spirituale che cerca il suo bersaglio nella soggezione al tempo e alla storia, soggezione di cui il poeta fa colpa al nostro tempo e alla nostra storia». Non si potrebbe dir meglio, e allora vengono in mente almeno due antecedenti, due lezioni di un altro Novecento, quella di Clemente Rebora e quella di Giacomo Noventa. Fu questo forse a isolarlo? Oppure, come sostiene Principe, non gli fu perdonato «il suo rifiuto di due modalità della poesia, l’hortus conclusus dell’interiorità e il rapporto “organico” (ossia servile) con la sfera pubblica»? Rodolfo Quadrelli morì nel 1984.