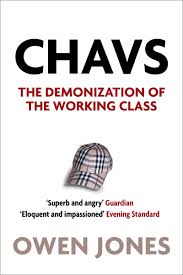Nel 2011, il giovane scrittore inglese Owen Jones pubblicava il libro “Chavs. The demonization of working class” (Edizioni Verso, New Left Books). In inglese, il termine Chavs sta a indicare quella massa di giovani britannici stigmatizzati dall’opinione pubblica per i loro comportamenti antisociali, la loro poca istruzione, la dipendenza dagli aiuti sociali, e in generale il loro modo di vivere secondo la moda più rozza e consumistica. I Chavs delle città inglesi sarebbero, con le dovute distanze e precauzioni, i coatti a Roma, o quelli che in lingua meridionale vengono chiamati “tamarri”. Il libro analizza l’emergere del fenomeno “Chavs” nell’Inghilterra del ventunesimo secolo, soffermandosi sulle sue manifestazioni mediatiche.
La tesi principale del giovane scrittore nato a Sheffield, e con una storia nel sindacato, è che i “Chavs” sono i figli e le figlie della classe operaia. Un settore sociale annientato dall’offensiva della classe media, portata avanti prima dalla Thatcher e poi dal neo laburismo: la finta sinistra in salsa liberista. Secondo l’autore, dietro l’odio dell’opinione pubblica inglese contro i Chavs si cela il classismo di una società inglese egemonizzata dal modo di vita borghese.
Grazie a questo libro, Owen Jones si è convertito in uno dei personaggi più influenti della sinistra inglese. Oggi giornalista del The Guardian, secondo un’inchiesta del Daily Telegraph è il settimo giornalista più influente nella sinistra del Regno Unito. Se di analisi economiche sul fondamentalismo neoliberista iniziato dalla Thatcher ne sono state scritte a bizzeffe, il suo libro ha infatti il merito di sistematizzare e amalgamare tutte le dinamiche sociali e culturali provocate dalla deindustrializzazione. E di farcene un libro ben scritto, con un registro narrativo con toni lontani dallo stile saccente, diventato un best seller.
L’imposizione delle politiche neoliberiste ha provocato una profonda trasformazione nella struttura economica, da cui è derivato un cambio -com’è consuetudine della Storia- anche nelle sovrastrutture culturali della società britannica. Il risultato: una totale egemonia culturale delle classi medie.
In principio, la privatizzazione delle case popolari fu vista come un’opportunità per una casa di proprietà perché fu accompagnata da forti incentivi voluti dalla Thatcher per facilitarne l’acquisto. A lungo termine, oltre a rivelarsi una perdita economica per i settori popolari, il decreto è riuscito a smantellare la solidarietà coltivata nei quartieri operai. Allo stesso modo, la mercificazione del mondo del Football e della cultura musicale (gli Oasis sono l’ultimo gruppo del Britpop veramente popolare), oltre a rappresentare la lenta ma inesorabile espansione della logica del capitale in tutti gli ambiti della vita, hanno espugnato le roccaforti della cultura operaia. L’egemonia della classe media nel potente apparato dell’informazione sensazionalista chiude il cerchio di questo “socialismo per i ricchi” che è oggi il Regno Unito.
I Chavs sarebbero allora i residui di una classe operaia sventrata dalle politiche economiche e dalla grande trasformazione culturale dello Stato inglese; proletari e proletarie senza un’identità di classe e ridicolizzati per essere usati come capro espiatorio della dilagante disuguaglianza economica. Infatti, ove non c’è alternativa alla cultura della classe media, chi non viene baciato dalla meritocrazia non solo prende schiaffi dalla “mano invisibile” che domina la società, ma viene anche colpevolizzato di non riuscire ad approfittare le opportunità che offre il libero mercato. Poiché hanno perso quelle aspirazioni collettive che il movimento operaio trasformava in rivendicazioni di classe, i Chavs rimangono in balia dei valori individualisti del capitalismo consumista, cercando goffamente l’ascensione a status di ceto medio.
In estrema sintesi, la forza del libro sta nello sbattere in faccia all’anestetizzata società inglese una spiegazione strutturale, e non classista, dei fenomeni antisociali che dilagano tra i giovani. Un ragionamento che porta, tra le altre, a una “sacrosanta” conclusione: il neoliberismo -iniziato con la Thatcher ma consolidato dal neo laburismo- non ha eliminato l’esistenza o la disuguaglianza tra le classi sociali. L’ha strutturalmente cementificata e ideologicamente avallata, mediante la distruzione della cultura operaia e rendendo egemonica quella borghese.
Il tema della cultura dei subalterni ovviamente non è cosa nuova; specialmente qui nel Belpaese dove grandi pensatori della sinistra hanno storicamente avuto a cuore la questione culturale della classe operaia. Pochi mesi prima di essere ucciso, Pasolini scriveva a un’Italia in pieno “sviluppo” consumista uno dei suoi gridi profetici. “C’è un’idea conduttrice sinceramente o insinceramente comune a tutti: l’idea cioè che il male peggiore del mondo sia la povertà e che quindi la cultura delle classi povere deve essere sostituita con la cultura della classe dominante.” Ancora prima, Gramsci scriveva che il primo problema per la sinistra era l’identità di classe, e che quindi occorreva “rivelare i proletari a se stessi”. Per molti, un’interpretazione politica del mitico detto di Solone: “conosci te stesso”, messa al servizio del pensiero marxista.
Ma al di là delle grandi intuizioni del passato, e forse anche del libro di Owen Jones, diversi sociologi stanno ponendo al centro dei loro studi la “metamorfosi della questione sociale” –come la definisce Robert Castel- nell’attuale conformismo della società dei consumi. Questa metamorfosi sociale non sancisce la fine delle classi, ma la tragica crisi d’identità e di valori di quelle povere, che vanno accumulando rabbia senza convertirla in coscienza sociale. Così come li definiva Hannah Arendt, tutti i giovani “lavoratori senza lavoro”, che sgattaiolano per le periferie delle grandi metropoli europee, assomigliano –in salsa consumista- ai sottoproletari degli scritti di Marx: “Mendicanti, prostitute, gangster, truffatori, imbroglioni, piccoli criminali, disoccupati cronici, persone che sono state espulse dall’industria, declassati di ogni sorta, elementi degradati o degenerati”.
E non è solamente una questione britannica. Il dilagare di questa nuova forma di povertà ed emarginazione sociale dei proletari metropolitani è tema centrale anche di un piccolo e umile corto girato a Roma nell’ultimo anno. Infatti, ogni anno il Comune di Roma organizza un festival di cortometraggi sulle borgate: “Mamma Roma e i suoi quartieri” e sul podio dell’ultima edizione è arrivato “BellaSkí” (5:42). Un corto ambientato nel centro storico della periferia romana: il Quadraro, e prodotto da “Rudere Produzioni”: un collettivo di giovani del quartiere. Il video lascia intuire come non c’è più nella periferia romana il giovane pasoliniano: “accattone” che rifiuta folcloristicamente il mondo capitalista. Ma una massa di precari e disoccupati che non vi ci trovano un posto stabile e che sono bombardati dalla sua propaganda consumista. La storia, di cui è protagonista uno di questi nuovi vagabondi metropolitani con l’orecchino, a differenza del libro di O. Jones, parla anche di riscatto. Infatti, grazie al prezioso lavoro di un centro sociale: Spartaco, Bellaschino ha preso coscienza della sua condizione, e piano piano si fa spazio nel quartiere per difenderne i diritti.
Nel corto, si vede un giovane pugile della palestra popolare del Quadraro raccontare la sua burrascosa vita nella periferia romana. Così, spontaneamente e naturalisticamente escono fuori temi centrali per lo studio delle classi subalterne e della questione giovanile in questo strano ventunesimo secolo. Bellaschino, tra le altre pittoresche descrizioni della sua quotidianità, racconta dei primi problemi arrivati con la disgregazione del nucleo famigliare e della propaganda conformista della televisione. “Ce vorrebbero tutti verso la stessa direzione”, racconta il protagonista.
Il profondo processo d’individualizzazione della vita parte dalla flessibilità del lavoro, ma arriva a praticamente la totalità delle sfere dell’esistenza sociale, senza escludere la famiglia. Ne esce fuori uno smantellamento di alcune tutele sociali tradizionali, come appunto le relazioni famigliari, che ovviamente hanno effetti sostanzialmente differenti a seconda degli strati sociali. Senza tutele collettive e risorse materiali, la distruzione di queste reti tradizionali diventa spesso un dramma per i settori più instabili della società.
Per quanto riguarda la questione del conformismo e della propaganda consumista, il teologo brasiliano Frei Betto, esperto di culture giovanili, ha illustrato come la democratizzazione del consumo, rappresentata dall’universalizzazione del “diritto allo smartphone”, condizioni profondamente la coscienza dei poveri. Percependo un’apertura del mercato, si sentono meno minacciati dal sistema capitalista e dal suo pacchetto di valori.
Una stupenda metafora per spiegare come l’esclusione sociale di oggi rappresenti più che un’assenza di relazioni sociali: un insieme di posizioni instabili, frammentate, precarie, con diverse e mutevoli relazioni con il centro, estremamente vulnerabili dalla falsa coscienza e dagli anti-valori che questo propaga. Infatti, i proletari delle città europee d’oggi non sono esclusi dal sistema capitalista, sono tenuti dentro ma ai margini, perché ne assorbano tutta l’ideologia conservatrice. Le politiche sociali assistenzialiste dello Stato sociale europeo ne sono un esempio, un’inserzione costante e permanente che non è mai sfociata in una reale integrazione degli emarginati, dei migranti, dei più poveri.
Più a fondo di una mancanza di politiche sociali, la questione radica nell’evoluzione tecnologica del capitalismo moderno. Caratterizzato da un constante processo d’innovazioni tecnologiche indirizzate a massimizzare i benefici della classe capitalista, spesso espellendo direttamente dal processo produttivo i lavoratori. Il risultato: una lenta ma inesorabile “destabilizzazione degli stabili”.
Così come i vagabondi del pauperismo dilagante laceravano le città fresche d’industrializzazione del diciannovesimo secolo, i disorientati ed emarginati giovani delle periferie metropolitane stanno lacerando dal centro (del sistema mondo) quest’inumana globalizzazione consumista. Marco Felli, il giovane regista di “Bellaskì”, ci tiene a sottolineare che il corto ambientato nella periferia romana parla proprio di questo. “Parliamo di presa di coscienza del vero senso di povertà e di esclusione, dell’emancipazione dal senso che la società dei consumi dà a queste due parole”. “Il raccontarsi ha come base di partenza l’auto analisi, che è a sua volta il punto di partenza per una presa di coscienza della propria condizione sociale”, spiega ancora Marco.
Il corto su Bellaschino è la prima uscita del progetto Rudere Produzioni.
Un progetto che nasce “nel riflesso delle insegne luminose della Tuscolana, nella calma apparente dei lotti popolari del Quadraro, negli occhi e nel cuore di chi non si è mai nascosto alla dolcezza e alla violenza della vita, nella speranza che raccontandolo, tutto questo grande casino possa servire a qualcosa”.
Il progetto è molto simile al “Laboratorio Mina”: il collettivo dei giovani di Scampia. I giovani scugnizzi di Napoli che stanno riscuotendo un enorme successo con la produzione di materiale cinematografico che indaga la realtà, per promuovere coscienza. Vento in poppa, allora. Oggi più che mai, nell’Italia martoriata dal neofascismo consumista, serve un cinema autentico che diffonda valori per la trasformazione sociale.