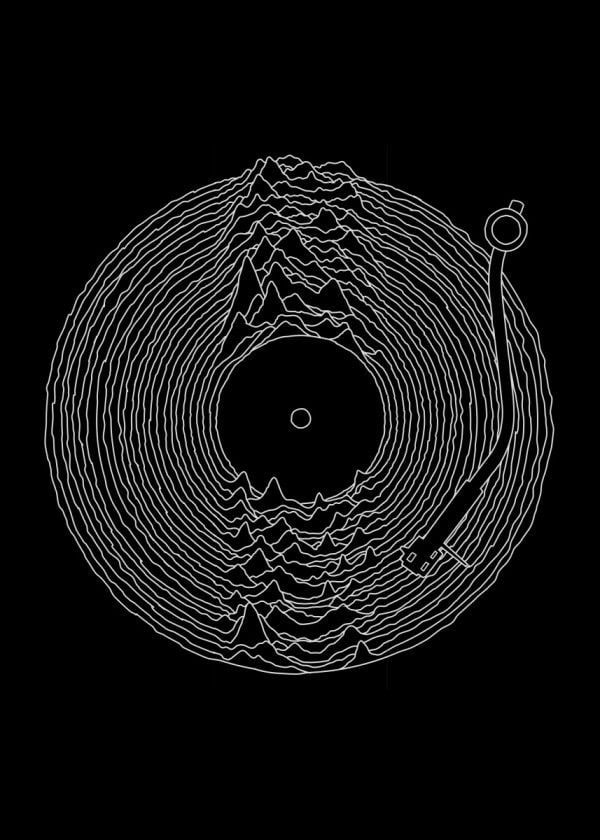Nel 1977, Murray Schafer pubblicò la prima edizione del suo testo fondamentale Soundscape, tradotto poi in italiano nell’85 e pubblicato col titolo Il paesaggio sonoro. In senso generale, il soundscape è l’insieme degli eventi acustici e delle loro proprietà di un determinato territorio, una caratteristica così sottilmente pervasiva (sia che l’impronta fonica sia forte, sia che, assai più raramente, sia sporadica e/o intermittente), che le persone tendono non accorgersene. Se non in casi particolari. Il soundscape è formato dall’insieme dei suoni prodotto dalla natura in quanto tale, dai suoni prodotti dagli animali, e dalla sempre più schiacciante mole di suoni prodotti dall’uomo, tanto maggiore quanto più un territorio è fortemente antropizzato, cioè modificato dall’operato dell’uomo. L’analisi di Schafer fu, per tutti, una sorta di rivelazione: nel senso letterale del termine, qualcosa che esisteva anche prima, e che qualcuno riesce a tradurre in modo comprensibile per tutti analizzando e dando nome a ciò che un nome non aveva.
Tra i molti concetti introdotti, Schafer parla di una «impronta sonora» dei luoghi (soundmark): l’insieme dei suoni di riferimento di una comunità, quelli cioè che neppure vengono avvertiti come abituali, essendo sempre e comunque percepiti come un riferimento di fondo. L’impronta sonora di una seduta «live» della borsa di Wall Street è ben evidente, così come quella di un suq marocchino, o di una birreria bavarese, di una comunità di monaci in preghiera in un’abbazia, di un gruppo di tifosi. Il soundmark è dunque un atto importante (e poco ricordato) nella costruzione delle identità culturali delle comunità. Il meno avvertito, forse. Si dà per scontato. Schafer spiega poi che in un paesaggio sonoro esistono le toniche, cioè quei suoni caratterizzati (e caratterizzanti, aggiungiamo) che fanno da sfondo acustico continuo a un territorio: lo sciabordio delle onde del mare in un paesino marinaro affacciato sulle acque, come ad esempio Camogli, e i segnali, quegli elementi acustici improvvisi che ci «avvisano» di qualcosa. Stai attraversando la strada distratto, e il guidatore che si sta avvicinando a forte velocità ti avvisa (o cerca di avvisarti ) tempestivamente attaccandosi al clacson.
ASSETTI
Un altro contributo improntante del testo di Schafer fu la definizione della diversità di due fondamentali assetti sonori. Esiste un paesaggio sonoro Hi-Fi, dunque con un basso impatto sull’orecchio umano di rumori di fondo ambientali, e suoni nitidi e definiti, ed esiste un paesaggio sonoro Lo-Fi, a bassa fedeltà, dove quindi è quasi impossibile per una persona identificare chiaramente le fonti sonore che gli arrivano all’orecchio, essendo il paesaggio sonoro saturo di segnali acustici. Tutte le civiltà che hanno preceduto l’avvento dell’industrializzazione, in un grafico ipotetico sulla saturazione sonora del soundscape, starebbero sotto una certa soglia: basso rumore di fondo, magari interrotto da quelli che lo storico Jacques Le Goff chiamava episodi un tempo «evenemenziale». Una campana che comincia a battere ininterrotta perché annuncia l’arrivo dei pirati saraceni, il canto di una processione religiosa per una festa liturgica, o da episodi sonori non controllati dall’uomo: è notte fonda in campagna, si percepiscono pochi rumori ambientali, e all’improvviso un tuono poderoso squassa la tranquillità. Il soundscape della città, viceversa, nella sua saturazione di stimoli sonori non consente quasi di avvertire discontinuità in un continuum sonoro caratterizzato dall’uso delle macchine, e da suoni cadenzati delle industrie e degli attrezzi usati. Un cantiere in mezzo a una strada con pale meccaniche e martelli pneumatici «alza» di alcuni punti significativi la soglia dei decibel, ma finisce tutto lì, per così dire. A voler considerare anche un aspetto propriamente antropofonico, quindi legato alla produzione consapevole di suoni da parte delle persone, e cioè la musica, nell’ultimo centinaio di anni a ben vedere la tensione del «soundscape» musicale è andata in due direzioni opposte e perfettamente complementari, dunque. Da un lato una tendenza mimetica a riprodurre nella musica affollamento, la saturazione sonora di ogni istante possibile: pensate a un’orchestra swing che guida le danze in un locale di New York del 1935, o a un concerto di heavy metal oggi. Dall’altro una tendenza a diradare la saturazione con inviti a riscoprire il silenzio, lo spazio fra le note, la lentezza dei suoni, le melodie risonanti. Qui si potrebbe far ricorso a infiniti esempi, dalla musica new age a un’etichetta di jazz raffinato (e non solo) come la Ecm di Monaco, il cui motto pubblicitario, qualche anno fa, recitava testualmente: «Il più bel suono al mondo dopo il silenzio». In altre parole, il silenzio è catartico, per molti, così come anche l’estremo rumore invasivo è catartico, per un Sufi Gnawa o un metallaro. Qualche anno fa, nel 2016, apparve sui giornali la storia di Gordon Hempton, l’ecologo che da un quarantennio gira il mondo con microfoni e registratori per cercare gli ormai residui spazi sonori naturali non infestati da quella che si definisce antropofonia, la superfetazione sonora e rumoristica prodotta dall’uomo quando abita o colonizza un territorio. Sono i luoghi geofonici, per usare la definizione di Bernie Krause, musicista e studioso del soundscape contemporaneo, luoghi dove cioè le uniche fonti di produzione di suoni sono naturali. Allora, all’epoca dell’articolo, ne erano rimasti una cinquantina di questi spazi sul pianeta, territori dove un orecchio umano può cogliere un suono distante anche venti chilometri, oggi sono anche meno. Anche se, in parte, il virus sta cambiando la nostra percezione almeno del soundscape urbano.
IL CAMBIAMENTO AURALE
Un caso imprevedibile come il Corona Virus, con tutte le decisioni a cascata che ne sono conseguite, all’atto di presa di coscienza della pandemia e delle manovre necessarie per contenerla, ci offre il destro per una serie di riflessioni su come sotto i nostri occhi, e soprattutto sotto le nostre orecchie, si sia verificata una mutazione quasi improvvisa e significativa dei soundscape urbani (e non solo) in cui viviamo immersi senza quasi consapevolezza, come pesci che non avvertono la presenza del liquido in cui nuotano e vivono, o umani che non avvertano la presenza dell’ossigeno fino a quando viene a mancare. La prima considerazione da fare è la nuova ambiguità assunta dal valore del «silenzio», o, per meglio dire, la coscienza di un ambiente acustico in cui siano nuovamente identificabili una serie di suoni e rumori prima sommersi nel continuum meccanico del tessuto sonoro urbano. Il silenzio è d’oro, dice il proverbio. E tutti siamo ben consapevoli di come una maggiore disponibilità economica si traduca, al di là della qualità della vita, nella possibilità di affittare o acquistare casa in una zona «tranquilla» o «silenziosa». Cioè senza rumori, o con una soglia di rumore considerata «naturale» e non invasiva. I poveri possono (e devono) anche vivere nel rumore, in sostanza, e così accade. Gli ultimi degli ultimi, poi, devono rassegnarsi anche al frastuono, oltre che al rumore: pensate a un campo profughi a Lesbo, in questi giorni, o a quale debba essere l’agghiacciante soundscape in un centro di detenzione libico.
La diffusione del Corona Virus, e la conseguente decisione di dar corpo alle manovre riassumibili nella formula «restate a casa» dà un’altra dimensione al silenzio, ai rumori, alla musica, alla coscienza reale delle tre parole appena citate. Di colpo ci siamo ritrovati con un nuovo soundscape, e con una mutata antropofonia, cioè a fare i conti con una diversa coscienza di come (e quanto) le persone emettano suoni in un ambiente pur sempre Lo-Fi, ma che tende a diradare il continuum ininterrotto di suoni. Esperienza non più provata da diversi decenni. E ora assunta, per dirla con Murray Schafer, come continuo «segnale» di una socialità negata nella presenza fisica, non più bastevole nei succedanei elettrici di immagine, smartphone e schermi vari, e necessaria. Il flash mob come azione più o meno dirompente nel tessuto urbano delle relazioni è un invenzione relativamente recente. Il flash mob acustico è un portato nuovo del Corona Virus. Le persone si danno appuntamento per vie immateriali a una certa ora, e ognuno (questa è la novità) dal proprio necessitato luogo di presenza, la casa. Poi abbattono l’unico diaframma possibile con il resto del mondo, la finestra, il terrazzo, il balcone, e si danno comunicazione acustica di esistenza, cercando di rinsaldare quel legame sociale che non è più concesso alla corporeità. C’è il bisogno di «rompere il silenzio». Che è quello esterno che ci rimanda il nostro nuovo doppio speculare: la solitudine della folla che siamo riportata a casa sotto costrizione.
EVENTI ACUSTICI
Cosa si comunica con i suoni al tempo dei flash mob acustici? Al solito, si inseguono in diversi modi tratti valoriali che costruiscano, per scelta, identità collettive a rinforzare quella individuale negata alla socialità e confinata tra quattro mura. Idealmente, un flash mob acustico è un equivalente simbolico di quei ragazzi che giravano per le piazze con i cartelli «free hugs», abbracci gratuiti per tutti. Quando il panorama sonoro era saturo di suoni c’era bisogno di bandiere alle finestre, non di rumore. A meno che non si trattasse, per così dire, di «alzare la soglia del rumore» per farsi sentire o ascoltare sopra il continuum sonoro: si pensi al cazerolazo, le proteste in America Latina fatte battendo mestoli e forchette sulle pentole. Adesso si spostano le casse acustiche di casa sul balcone e si manda a tutto volume l’inno di Mameli. Oppure si utilizzano i sistemi wifi. O, anche, torna la figura guida del musicista che si fa «portavoce», e il trombettista alla finestra suona O Mia bela madunina. Luca Barbarossa che dalla finestra ritorna menestrello, e canta la sua hit Roma spogliata alla città. O, almeno, a quella parte della città che può ascoltarlo. Il resto sarà rilancio mediatico per chi è più famoso, o curiosità e bizzarria antropologica, per chi famoso non è. A Genova fra i caseggiati popolari si affaccia il ragazzo con la barba che suona Crêuza de mä di De André, da un trentennio nuovo inno «identitario» (per fortuna non campanilistico né con assonanze sovranistiche di alcun tipo). Si ribadisce dunque quella tensione sonora duplice che riguarda un paese non maturato come nazione consapevole, l’inno nazionale (oggettivante brutto: una marcetta ternaria che senz’altro ha ben pochi elementi di fascino sonoro), o quello che fa da marcatore sonico del «territorio». Si alzano anche voci isolate, e riprese da un caseggiato all’altro. «Ce la faremo» è il più usato: difficile non vedere qui un’influenza diretta di decenni di produzione seriale audiovisiva nordamericana, dove gli imperativi che si danno i personaggi portano pur sempre a quel «ce la farai, ce la faremo», magari in pendant con quell’altro assunto-mantra ottimistico e molto yankee del rimboccarsi le maniche e giocarsela, «dammi, datti un’altra possibilità».
LE SBARRE E IL RITORNO AL FUTURO
Le carceri sono luoghi nei luoghi, nelle città. Immerse spesso negli stessi spazi in cui vivono i cittadini «normali», quelli non reclusi, hanno una presenza sonora, normalmente, poco caratterizzata o assente: al massimo la sirena di un’auto o di un furgone per un’emergenza, un trasporto veloce. Il Virus ha portato una novità che pure non è tale: la rivolta per non essere costretti a morire di Corona come topi in trappola. Nel silenzio delle città con qualche sparuto passante, il battere ossessivo sulle inferriate delle celle e le grida «Indulto!» che si avvertivano con chiarezza fuori dai muri hanno funzionato da soundmark , da marcatore acustico della differenza di quel luogo non più conosciuto dai tempi delle rivolte di quarant’anni fa, con medesimi rumori e scalata sui tetti. Battito nel (quasi) silenzio , in pratica.
LE MILLE BOLLE SONORE
La ricerca sociologica e antropologica degli ultimi decenni sul modo di usufruire della musica ha messo in luce diversi aspetti interessanti. Ad esempio che, mentre aumenta vertiginosamente il numero di chi dichiara di non aver alcun criterio di valutazione sulla musica che non sia il gusto modellato dai media, viene accettato come normale e parte dello stesso soundscape urbano a bassa fedeltà il fatto di essere letteralmente immersi nella musica che non si è scelta. Chi dice quattro, chi dice sei ore ogni giorno. Dai cellulari, dalla segreteria che vi mette in attesa, dalla televisione, dagli altoparlanti nascosti o poco visibili dei supermercati che tengono la «musica di sottofondo» perché così si acquista di più e più rilassati. Invenzione peraltro statunitense della metà degli anni Trenta, ad opera della corporation Muzak, qualcosa come «la musicaccia». Diede anche nome, ironicamente, a una bella rivista di popular music e jazz nell’Italia degli anni Settanta. Non ci accorgiamo quasi più della «muzak»: c’è e basta. Curioso che una delle reazioni più normali alla pervasività estrema della musica inserita nel soundscape urbano sia stata la creazione delle bolle personali della musica. Si potrebbe riassumere così: il mondo mi assedia con i suoni e i rumori ininterrotti, io tengo fuori il mondo, la musica imposta e i rumori con la mia musica, isolandomi dal continuum sonoro. È un fenomeno che potremmo esemplificare e far partire, con una certa approssimazione, dall’invenzione del walkman, il geniale lettore portatile di audiocassette made in Japan commercializzato nel 1979. Indossare le cuffiette e far girare la propria cassetta nel walkman significava approntarsi una bolla sonora individuale e non soggetta a invasione da parte di estranei. Di più: significava poter fare sport, passeggiare, muoversi in ambienti saturi di suoni e rumori combattendo alla pari l’assedio sonico con la propria e personalissima dose di saturazione sonora. Di lì a poco diventarono «bolle sonore» anche le automobili, con la sottile ambiguità, però, di poter montare impianti stereofonici sempre più potenti, e di poter funzionare quindi anche come l’uguale e contrario: da bolla privata a soundmark indiretto di potenza individuale in movimento. Basti pensare alla figura del «coatto» con i finestrini abbassati e il bum-bum dei bassi che scuotono le viscere, ostentato come un marcatore di diversità. In pratica la stessa funzione che avevano i «ghetto blaster», i grossi radioloni con riproduttore di cassetta che servivano a marcare gli spazi di influenza delle gang nei ghetti americani. Il Corona Virus ha prodotto, a oggi, diversi effetti nel territorio delle bolle sonore: ad esempio l’incoraggiamento istituzionale a (ri)praticare il rito domestico dell’ascolto della musica, una pratica evidentemente secondaria ormai, nella miriade di stimoli offerti da Internet e dai videogiochi, e considerata la soglia d’attenzione per le note che è quella del pesce rosso. Pochi secondi. Tutti a casa, dunque nuova tolleranza anche per le bolle musicali altrui: la mia musica accanto alla tua, e senza guerre evidenti di watt per il predominio. L’adesione al flash mob acustico, però, ci fa registrare una sorta di «sfondamento» della bolla sonora individuale verso l’incorporeo collettivo di persone che si stanno attorno: se non sai suonare uno strumento, ti faccio ascoltare dal balcone quello che per me è o ritengo sia significativo per tenere alto il morale della comunità.
TACI, IL NEMICO NON TI ASCOLTA
La rottura istituzionale (nel senso di : voluta dalle istituzioni, a protezione della salute) del soundscape urbano caratterizzato da ininterrotta sequenza di eventi acustici aggressivi fa risaltare eventi acustici che non sapevamo più riconoscere, se non in qualche giornata di vacanza in montagna o in campagna «per quietare un po’». Un cane che abbaia nella notte, e crea una sorta di catena di sant’Antonio di latrati a riprendere la prima irruzione sonora, e rilanciarla. La coscienza che la straordinarietà di una sirena diventata poco più che ordinarietà, nella selva sonora di clacson, è di nuovo indicatore, soundmark di qualcosa che sta accadendo. I passi solitari che risuonano sul selciato.
THE SOUND OF SILENCE?
C’è chi si sta attrezzando per questa amara occasione offerta dal Corona Virus. L’Istituto centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, assieme al Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Padova e Lys (Locate Your Sound) invitano alla raccolta spontanea di documentazione sonora su queste strane giornate se non di silenzio, di rumori diversi, attutiti o intermittenti. Locate Your Sound mette a disposizione il proprio sistema di archiviazione sonora ideato dalla ditta italiana mOOviOOle per riuscire poi a mettere in rete i fondi sonori di tutto il pianeta. Armatevi di registratore. Cercate i suoni nel silenzio.