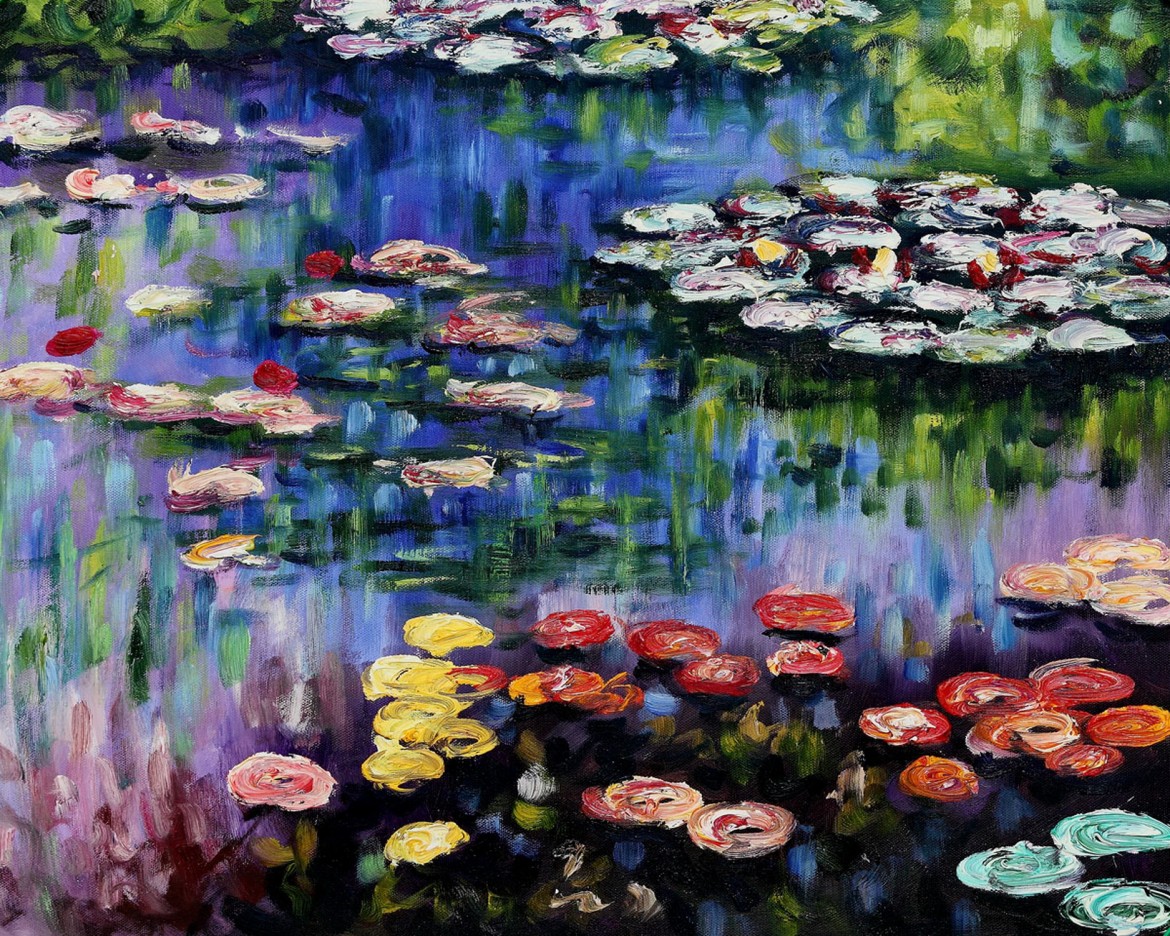Diceva uno dei più cari amici di Proust, Lucien Daudet: «l’amore non è mai reciproco, però a volte è contagioso». E qualcosa di «contagioso», a dire il vero, c’è anche nelle pagine della Recherche: trasmettono al lettore congeniale il virus di una percezione alterata della realtà sensibile, del mondo sociale, di tutte le distanze nello spazio e nel tempo. Non sono mancati, certo, i lettori immuni da questo contagio: tanto David Herbert Lawrence, che dell’autore della Recherche detestava l’intellettualismo, quanto Arrigo Cajumi, convinto che Proust non fosse «di quegli scrittori che lasciano tracce profonde nella storia letteraria e nel movimento delle idee»; Aldous Huxley, poi, era respinto da un autobiografismo a suo avviso troppo compiaciuto, e il romanziere Marco Missiroli ha dichiarato in un’intervista di non essere mai riuscito ad arrivare sino al Tempo ritrovato: uno dei tanti che non hanno esitato a confessare come non fossero mai approdati alla fine dell’opera.
Le testimonianze delle vittime del bacillo di Proust restano però numerose e significative: Rilke, Katherine Mansfield, Virginia Woolf, Walter Benjamin… È incredibilmente forte, in questi contagiati, l’impressione che Proust, rispetto ad altri scrittori altrettanto grandi, o anche più grandi, catturi il suo lettore e ne condizioni lo sguardo con un sovrappiù di irresistibile prepotenza. Giacomo Debenedetti, rievocando nel 1952 questa sensazione provata negli anni venti, l’ha tradotta in termini particolarmente efficaci: «Gli altri scrittori erano semplicemente scrittori, della stessa razza di quelli che avevamo studiato nelle storie letterarie, gente che lavorava con carta, penna e inchiostro; mentre Proust sembrava far parte direttamente del nostro destino, sembrava prendere la durata uniforme dell’esistenza e farne una fluida, stupenda, incessante calligrafia di luce».
Se si volesse apporre un’epigrafe ai saggi proustiani di Giovanni Raboni, titolati La conversione perpetua e altri scritti su Marcel Proust (Mup, pp. 163, euro 15,00) recentemente raccolti dalla figlia Giulia in un bel volume, completato da un’intervista della curatrice a Mario Lavagetto – mi pare che non se ne potrebbe trovare una più appropriata di queste parole di Debenedetti; perché quel che Raboni cerca instancabilmente di definire e circoscrivere, nei suoi interventi che vanno dal 1959 al 2002, è proprio il modo peculiare in cui Proust irrompe nel destino di chi lo legge e ne trasforma la percezione dell’esistenza. Intorno a questo nucleo centrale si dispongono moltissimi altri spunti, dalle trasposizioni cinematografiche della Recherche a quel che vede il turista in pellegrinaggio a Illiers-Combray, dai repertori iconografici che ci mostrano i «modelli» della duchessa di Guermantes e di Charlus ai problemi lessicali affrontati dal Raboni traduttore. Ma il cuore del libro è il rapporto che si instaura tra Proust e il suo lettore e che non somiglia a nessun altro.
«Amare Proust – leggiamo – amarlo da proustiani, vuol dire essere convinti che esista un rapporto speciale, particolarmente continuo e sottile, fra la sua scrittura e la nostra vita: che ciò che è scritto nelle sue pagine ci riveli minutamente e incessantemente a noi stessi».
L’ordine cronologico, nel quale sono disposti i saggi più importanti di questa raccolta, ci aiuta a ricostruire le tappe del lungo dialogo del poeta con il romanziere. Il primo saggio, La riduzione nella Recherche, è datato 1959. Raboni, non ancora trentenne, ha letto Proust nove anni prima; i quindici volumi dell’edizione Gallimard gli sono stati regalati dal padre subito dopo la licenza liceale, e hanno esercitato su di lui una tale fascinazione da indurlo, un paio di anni dopo, a visitare Illiers, il modello della Combray di Du côté de chez Swann, non ancora trasformata, a quel tempo, in una piccola Disneyland della madeleine e del biancospino. La sua prima lettura è avvenuta dunque nel 1950, nello stesso anno in cui, grazie ai concerti dell’Anno Santo, le sue conoscenze musicali hanno fatto progressi decisivi. Ed è proprio la musica che troviamo, in posizione centrale, nel saggio del 1959.
La «riduzione» alla quale allude il titolo è quella che potremmo definire la pars destruens del romanzo proustiano: la sistematica demolizione delle aspettative del lettore, che vede molti eventi assumere un significato diverso da quello che gli è stato inizialmente proposto e molti personaggi svelare un volto segreto, in totale contraddizione con la loro identità «ufficiale». Questa «riduzione» proustiana – suggerisce Raboni – non è forse analoga a quella condotta dal Beethoven degli ultimi quartetti, che sembrano distruggere ogni equilibrio precedentemente raggiunto, per ordinare in una nuova tensione «i frantumi ancora vivi» dell’universo musicale di Haydn e di Mozart? A questo folgorante parallelo, il saggio del 1959 affianca considerazioni che si riallacciano esplicitamente a un’intuizione di Antonio Banfi: la prossimità tra il gesto proustiano che sospende la verità delle apparenze, per preparare quella del Tempo ritrovato, e l’epoché di Husserl. In tempi recenti, la critica ha ripreso e variamente declinato l’accostamento Proust-Husserl.
Eppure quel che più colpisce, oggi, del primo scritto proustiano di Raboni, non è il suo proiettarsi verso il futuro, ma il suo esser radicato nei remoti anni cinquanta, in un tempo in cui la familiarità con la Recherche è ancora di pochi lettori ipercolti (e forse anche un po’ eccentrici, come gli «esistenzialisti» che in «Totò imperatore di Capri» intonano in coro: «Noi siamo sempre trist, leggiamo solo Proust»). Una diversa stagione si aprirà alla fine degli anni settanta, quando Einaudi manderà in libreria la riedizione negli Struzzi della prima traduzione a più mani (quella che ebbe tra i traduttori Natalia Ginzburg, Fortini e Caproni), nello stesso momento in cui Mondadori metterà in cantiere la nuova edizione dei Meridiani, affidata a Raboni come unico traduttore. Tutti gli altri saggi della Conversione perpetua appartengono a questa nuova stagione, nella quale cambierà il rapporto del poeta con il suo autore – ripercorso per dodici anni parola per parola – e anche, sensibilmente, il rapporto del pubblico italiano con Proust.
Nel saggio del 1959, inseguendo le analogie tra il pensiero di Proust, l’arte di Beethoven e la filosofia di Husserl, Raboni aveva adottato un punto di vista situato all’esterno della Recherche; il punto di vista di un osservatore che, contemplando da una certa distanza tre monumenti, ne coglie i tratti convergenti, le linee comuni. A questo punto di vista in qualche modo aereo, distante, complessivo, se ne sostituisce negli anni della traduzione uno completamente diverso. Impegnato, come traduttore, in una resa del testo che si vuole strenuamente fedele alla sintassi proustiana, Raboni scrive della Recherche dall’interno, come un minatore che renda conto, a chi sta fuori, di ogni venatura del filone di roccia con il quale sta lottando. Ed è riflettendo sulle condizioni del proprio lavoro che arriva a definire in termini estremamente suggestivi la stratificata complessità della Recherche.
Come nel traduttore, ci dice, convivono un «cieco scriba» che si accanisce sulla singola parola e un lettore che ha già letto l’opera intera e decifra quella parola alla luce dell’insieme, così nella Recherche coesistono due romanzi, quello del Narratore e quello del protagonista, «il romanzo che è stato scritto e il romanzo che si sta scrivendo, che si scrive incessantemente senza fine». In difficile equilibrio tra questi due romanzi procede il lettore, perennemente sconcertato ma anche sedotto dalla nuova visione del reale che gli viene proposta. Il suo incontro con Proust – Raboni ne è certo – non potrà che sfociare in una «conversione»; una «conversione perpetua» a «quell’immensa partitura per io solista» che è la Recherche.