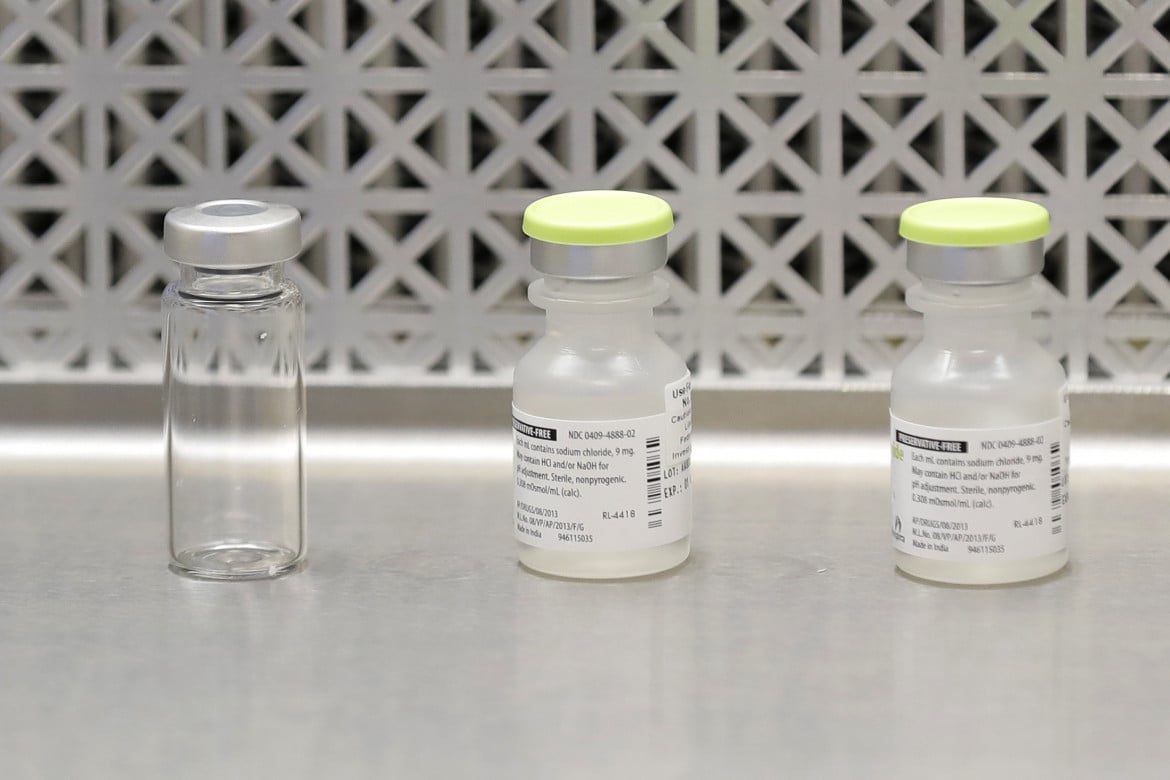Nei tragici giorni della pandemia si fa strada quella che appare essere la soluzione definitiva al problema Covid 19: il vaccino. Si moltiplicano così le petizioni che ne chiedono l’utilizzo come «bene comune» affinché la distribuzione raggiunga tutti coloro i quali ne hanno bisogno, dunque potenzialmente almeno il sessanta per cento della popolazione mondiale.
Ma la sfida dell’accesso equo a questo «bene comune» urta contro due questioni che vanno affrontate e risolte: la prima è la definizione stessa di «bene comune», la seconda la normativa del Wto (Word Trade Organisation) che garantisce i Diritti di Proprietà Intellettuale ai produttori del farmaco (Trips). Ora, mentre la seconda problematica sembra essere del tutto politica, anche se affrontabile con le regole stesse del Wto, la questione «bene comune» pone un problema di fondo che va posto con chiarezza, affinché non si perda anche questa occasione per cambiare radicalmente l’approccio ad un qualcosa che va ben oltre l’aspetto sanitario.
Riguardo alle normative Trips del Wto, forse qualcuno ricorderà la posizione degli USA quando ne chiesero la deroga per la produzione dell’antidoto contro gli attentati all’antrace, nel 2001. Chi scrive seguiva allora le questioni del Wto per il Forum Sciale Mondiale, e si trovava a Doha per presenziare al Ministerial Meeting.
Ebbene dopo quegli attacchi il WTO rilasciò un dichiarazione nella quale si diceva che i Trips dovevamo comunque essere a supporto della sanità pubblica, e dunque si introdusse una prima deroga su pressione degli Stati uniti, paragrafo 17. In tempi successivi India e Sud Africa hanno mosso gli stessi passi per quanto concerne i farmaci anti Hiv al tempo estremamente costosi perché, appunto, coperti da brevetti.
Dunque chi oggi si batte perché le regole del Wto vengano modificate nel senso di sospendere i Trips per quanto concerne il vaccino anti Covid 19, non solo è nel giusto, ma può basarsi anche su alcuni antecedenti significativi. Per quanto concerne invece la questione vaccino «bene comune», sarebbe il caso di chiarire che questa definizione non è, come potrebbe sembrare, un mero ritorno al socialismo del secolo passato, per il quale ciò che era ritenuto vitale doveva essere alla portata di tutti. Non è così, o almeno non solo questo.
Dalla battaglia per l’acqua «bene comune» abbiamo imparato, mercé le popolazioni indigene che ci hanno insegnato il suo reale significato, che non significa solo avere tutti in comune lo stesso bene ma capire che, invece, si ha qualcosa in comune con quel bene. In altre parole io definisco «bene comune» l’acqua non solo perché tutti devono potere avere accesso a quella potabile senza mercificazione alcuna, ma perché ho capito di avere qualcosa in comune con l’acqua: siamo fatti dello stesso elemento; l’acqua “fuori” di me chiama l’acqua “dentro” di me.
Da questa comunione elementare nasce un vero rispetto per il «bene comune» e non solo un suo diverso uso. Ma tutto questo cosa significa nel caso di un vaccino?
Ebbene il legame è ancora più profondo, se possibile: se comprendiamo ciò che ci unisce al virus come parte del vivente, e che è per colpa nostra se la sua esistenza un tempo confinata in certi biomi oggi invasi da noi, lo ha costretto a migrare nei nostri polmoni (spillover), allora forse da questa pandemia potremmo veramente trarre un nuova consapevolezza, una nuova relazione tra noi ed il resto del vivente.
Ecco che la battaglia per il vaccino «bene comune» assume un’ampiezza sistemica, paradigmatica. Peggio di questa pandemia non c’è che il rischio di sprecarla, assumiamo dunque la definizione giusta di «bene comune» per la valenza che realmente rappresenta.