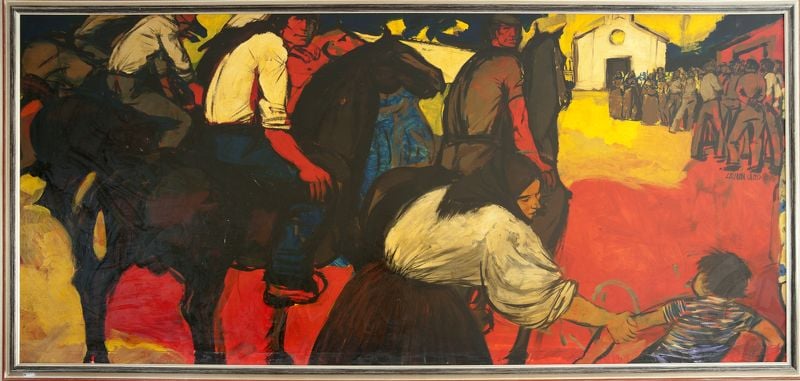Pubblicato 3 mesi faEdizione del 19 maggio 2024
Le bambine troppo vivaci si curano con le iniezioni: questa l’eredità familiare che Antonella Moscati riversa, in un registro tragicomico, nel suo nuovo racconto autobiografico, Patologie (Quodlibet, pp. 96, € 12,00), dedicato alla sua infanzia di ragazzina magrissima, cresciuta nella famiglia di un medico napoletano, che tale non era considerato, tuttavia, dalla moglie e dalle tre figlie, in quanto specializzato in una materia di cui non si poteva parlare, soprattutto a scuola – la dermosifilopatia. Coerentemente con la confusione generata dal ruolo paterno, parte da qui il racconto di formazione dell’autrice: non dalla medicina, semmai dalla malattia. Ben disposto verso...